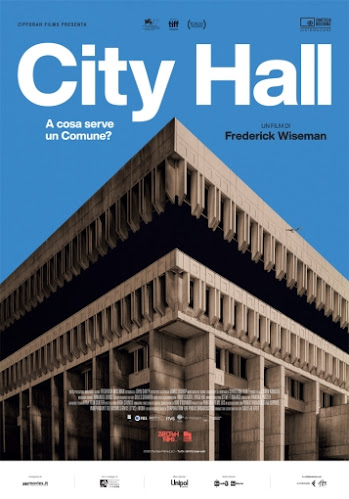(di Lisa Bosi, 2024)
Se nel pensare a periodi e ad anni di rottura o "rivoluzionari" è il Sessantotto a venire alla mente di primo acchito, il finale degli anni Settanta non è certo stato da meno. Si pensi al fermento nato intorno ai movimenti politici e culturali del 1977 e degli anni successivi, anni che hanno visto srotolarsi davanti agli occhi degli italiani (e del mondo) scontri di piazza, proteste studentesche, la diffusione su scala ampia delle droghe pesanti, dell'eroina in particolare, ma anche il diffondersi delle condivisioni, delle piccole comuni abitative, di gruppi spontanei di fermento creativo, inizialmente anche molto abborracciati ma nati da urgenze o malesseri sinceri, da voglie d'espressione libera e di rivalsa, magari anche economica, perché no, ma soprattutto da una spinta culturale e libertaria che ha portato ondate di cambiamento, alcune delle quali favorite da influenze provenienti dall'estero. È in questo contesto che a Bologna, uno dei punti caldi del periodo in esame, si formano diverse nuove esperienze musicali tra le quali una delle più significative e trasversali è stata quella legata al gruppo dei Gaznevada. Con Going Underground la regista Lisa Bosi ci accompagna non solo attraverso le vicende e i cambi di formazione e di attitudine dei Gaznevada ma anche lungo il dipanarsi di un periodo storico e culturale molto significativo per la Storia del nostro Paese in un amalgama ben riuscito tra musica e ambiente, influenze esterne ed esperienze dirette di un gruppo di ragazzi che della musica libera voleva fare la loro vita, cadendo, riprovando, eccedendo, lasciando qualcuno sul campo e infilando anche qualche successo, imprimendo così il loro nome, oggi forse un poco dimenticato, su una pagina importante della musica italiana alternativa.Questa storia parla di persone realmente esistite ma ogni riferimento a loro è puramente casuale. "Eravamo ragazzi con la testa piena di letture sbagliate fatte troppo in fretta [...] prigionieri di un mondo appena creato ma pieno di promesse. Noi abbiamo creduto a tutte quelle promesse. [...] Questa è una storia di eroina e amaro in gola; aspettavamo di fare successo... facendo di tutto per non farlo. Decidemmo di chiamarci Gaznevada". È così che si apre, sulle immagini di un paesaggio alieno, questo Going underground, breve documentario, testimonianza dell'avventura Gaznevada raccontata dalle voci (con accento marcato) degli stessi componenti della band, ora cresciuti, presenze bizzarre di un ambiente allucinato, "un'interferenza trasformata in onda musicale". In realtà i Gaznevada arrivano in un momento storico in cui in Italia di interferenze di certo non ne mancano, sotto il punto di vista musicale e culturale la loro esperienza contribuì però a iniettare nuova linfa nel panorama del Paese; in un'epoca analogica, folgorati dall'ascolto dei dischi dei Ramones, alcuni giovani tra i quali il chitarrista Robert Squibb (Ciro Pagano), il bassista Johnny Tramonta (Giampietro Huber), il batterista Bat Matic (Marco Dondini), il cantante Andrew Nevada (Giorgio Lavagna), il tastierista Nico Gamma (Gianluca Galliani) e il sassofonista Sandy Banana (Alessandro Raffini) si trovano coinvolti nella nascita della Traumfabrik, inizialmente un'esperienza condivisa culturale senza pretese d'arrivare al mercato. In una casa occupata di Bologna i nostri condividono gli spazi con Filippo Scozzari, fumettista e illustratore diventato poi molto celebre, da qui i Gaznevada (ancora non si chiamavano nemmeno così) muovono i primi passi partendo dal rock demenziale (Mamma dammi la benza) subito abbandonato in favore di un approccio punk alla musica. L'incontro con la Harpo's Bazar, poi Italian Records, diede il via a un percorso musicale che portò il gruppo a una maggiore visibilità e ad attraversare negli anni i periodi del punk, della new wave, della italo disco fino ad arrivare al pop degli anni 80, alle apparizioni televisive e al palco del Festivalbar. Nel mezzo i danni causati dall'eroina, i cambi di formazione e, almeno per qualcuno, una voglia di emergere in contrasto con tutto e tutti.
In sala dal 24 febbraio per Wanted cinema, Going Underground è diretto da Lisa Bosi, regista interessata ai movimenti musicali, già autrice di Disco Ruin, documentario dedicato al mondo delle discoteche e dei club nel periodo che va dai 60 ai 90 del secolo scorso. Per Going underground la Bosi sceglie di non avvalersi solo dell'approccio classico delle "teste parlanti", andando invece a creare un documentario dal taglio vivace e moderno tra voci fuori campo sghembe e protagoniste in prima persona della vicenda narrata, scampoli di repertorio tratti da episodi di cronaca del periodo come da performance live dei primi Gaznevada fino ad arrivare ai successivi passaggi televisivi; non mancano alcune interviste d'epoca e sequenze di introduzione e collegamento visivamente accattivanti e stralunate, realizzate dalla Bosi con i Gaznevada di oggi, ancora personaggi sopra le righe capaci di padroneggiare il video. Ciò che maggiormente funziona in questo documentario è la capacità di inserire al meglio l'avventura Gaznevada nel contesto sociale dell'epoca; è interessante infatti seguire il percorso di quei giovani ragazzi ma anche quello delle loro frequentazioni, la nascita della Traumfabrik, la presenza in casa non solo di Scozzari ma anche di un certo Andrea Pazienza, il nome più parlante del fumetto indipendente dell'epoca, un ragazzo destinato a fare un pezzo di storia del fumetto e a rimanere per sempre, oltre il momento della sua prematura scomparsa; divertente scoprire come dietro alcune delle storie di Pazienza ci siano proprio le vicende dei componenti dei Gaznevada e di come Zanardi, il suo personaggio di punta, sia stato (forse?) ispirato proprio da Robert Squibb (pare che in principio portasse anche il nome di Pagano che si incazzò e portò Pazienza ad optare per un nome alternativo, Zanardi appunto). Ne esce così il vissuto di quei ragazzi immersi in un'epoca non facile e turbolenta, punk nell'animo che sono stati in grado di reinventarsi col tempo; Going underground riporta alla memoria la loro storia e quella della loro generazione portando allo spettatore un punto di vista non istituzionale ma personale e costruito sulla sincerità delle ferite vissute sulla propria pelle. Si chiude con i Datura, costola e residuo di ciò che nacque in quell'ormai all'apparenza lontano 1977, ulteriore esperienza di chi a continuato a insistere e a insistere, ancora e ancora.