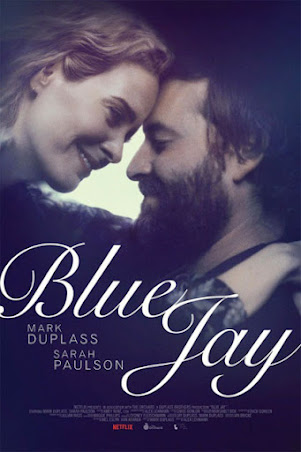(Borom Saret e La noire de... di Ousmane Sembène, 1963/1966)
Ousmane Sembène è stato uno dei cineasti più importanti del continente africano, a lui sono attribuiti il primo film (un corto) e il primo lungometraggio di finzione girati nel Continente Nero, entrambi questi titoli sono da poco disponibili nel catalogo di Raiplay nella preziosa sezione Fuori Orario; ovviamente, non c'è neanche da dirlo, queste due opere sono proprio Il carrettiere e La nera di..., due film risalenti agli esordi del regista senegalese che arriva all'arte cinematografica già quarantenne dopo essersi dedicato in precedenza alla produzione letteraria, le sue pubblicazioni sono infatti precedenti di qualche anno rispetto ai suoi primi film. I temi di questi girati, come molti di quelli successivi, vertono sulle vite della povera gente del suo Paese, con un focus particolare sulla zona di Dakar, sul loro privato e sul rapporto con la condizione sociale e di vita che sfocia nel politico, affrontando Sembène ciò che più da vicino ha toccato la storia del Senegal in epoca moderna: il colonialismo da parte della Francia. Grande divulgatore di cultura nel suo Paese, Sembène mette a disposizione dei suoi concittadini i libri e le riviste della sua biblioteca personale e fonda anche una compagnia di produzione cinematografica, la Doomirew. Proprio nel 1963 apre le porte della produzione cinematografica africana.Il primo approccio al cinema di Sembène si concretizza con Il carrettiere, un cortometraggio di diciannove minuti che racconta una giornata lavorativa in Dakar di un giovane uomo (Ly Abdoulaye) proprietario di un carretto di legno e di un cavallo di nome Albourah. Il carrettiere parte il mattino presto senza sapere come andrà la sua giornata, se lavorerà o meno, se riuscirà a portare a casa prima di sera qualcosa da mangiare per sua moglie e per suo figlio; offre servizi di trasporto nella periferia di una città dove i mezzi di locomozione non sono ancora così diffusi e sicuramente inarrivabili per la maggior parte delle tasche, trasporterà persone, una donna partoriente all'ospedale cittadino, carichi di mattoni e finanche una piccola bara con un bimbo deceduto. Non tutti i suoi clienti potranno pagarlo, il carrettiere avrà a disposizione pochissimo cibo e troverà il modo di non portare a casa nemmeno il poco guadagnato, inoltre subirà le conseguenze per aver portato in centro città un compaesano benestante, in una zona più ricca dove i carretti hanno l'accesso vietato. Su un finale amaro sarà la moglie a dover trovare una soluzione per mettere del cibo in tavola.
Non c'è nulla di esotico nell'Africa di Sembène, realizzato con pochissimi mezzi Il carrettiere ha un piglio che si avvicina al nostro neorealismo per temi e realizzazione, non ci sono professionisti, il cinema d'Africa è agli albori, in alcuni passaggi si ha l'impressione che le comparse guardino in macchina stupiti dalla realizzazione stessa del film che era fuor di dubbio cosa nuova a quelle latitudini (la scena del mercato), racconto lineare ma che già mette in evidenza il contrasto tra cultura locale e occidentale con quest'ultima che tende a ghettizzare (l'impossibilità di entrare con un mezzo misero nei quartieri centrali), creare divari tra la popolazione, tra autoctoni e francesi, oltre a raccontare le difficoltà nell'affrontare la realtà quotidiana. Nonostante le lamentele del protagonista non c'è un senso di tristezza o pesantezza nel racconto di Sembène che lascia intravedere amarezza solo nella chiusura del corto.
Con La nera di... Sembène passa al lungo (seppur con 65 minuti si tratti di un lungo breve) realizzando un film a cavallo tra due continenti con una narrazione circolare (tramite uso di flashback) che nasce e muore a Dakar ma che vive nel suo corpo centrale in Costa Azzurra, ad Antibes, nella terra dei colonizzatori. La protagonista è Diouana (Thérèse M'Bissine Diop), la nera del titolo, una giovane donna che passerà da un'esistenza in cerca d'occupazione nelle periferie di Dakar a un impiego a servizio di una famiglia francese conosciuta nella città africana e che la porterà con sé in Francia. Diouana passerà così da un primo lavoro a Dakar dove si occupa dei bambini dei due francesi, marito e moglie senza nome nel film, a un impiego da domestica ad Antibes che si farà sempre più gravoso, non più solo accudire i bambini, ma anche cucinare, fare il bucato, pulire casa, fare il caffè, divenendo anche oggetto e mezzo per sfoggiare un tenore di vita borghese da parte dei due "padroni" agli occhi degli amici, uno dei quali chiederà anche di poter baciare Diouana per provare la nuova esperienza di baciare una negra. La giovane cade in depressione, trattata sempre peggio dalla padrona (ma non dal marito, in fondo Diouana è una donna molto piacente) si sente sfruttata, non ha amici, sente la mancanza di Dakar, del suo ragazzo, della vita nelle strade, in Francia vive reclusa nell'appartamento, una prigione nella prigione, la tradizione della sua terra è lontana, il sogno francese si trasforma in incubo. Girato ancora in lingua francese, si accentua il tema dello sfruttamento coloniale e l'inserimento in un sistema che invece di benessere crea infelicità. Sembène ricorre ancora ad attori non professionisti anche se il suo cinema è già riconosciuto (La noir de... vince il premio Jean Vigò in Francia), il bianco e nero restaurato è limpido e chiaro, c'è un bel contrasto tra interni/Antibes ed esterni/Dakar molto simbolico, ancora una volta la chiusura è decisamente amara.
Piccola rassegna sulle origini del cinema africano molto interessante ma soprattutto piacevole, entrambi i film si guardano molto volentieri e nonostante i temi siano importanti e propongano realtà affatto semplici e felici non si accusa mai pesantezza né sotto il punto di vista della narrazione né tantomeno nei ritmi che sono dosati in maniera ottimale. Ancora una volta la sezione Fuori Orario si conferma una delle realtà più meritorie per chi il cinema vuole anche conoscerlo e studiarlo un minimo nelle sue latitudini e nella sua storia, dando finalmente un senso al pagamento dell'abbonamento Rai.