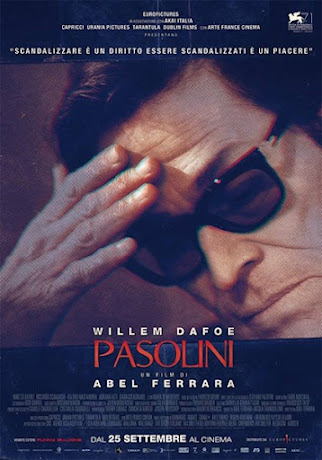(di Andy Muschietti, 2017)
Per me, negli anni della gioventù e dell'adolescenza Stephen King è stato uno degli autori (l'artefice principale senza ombra di dubbio) che ha fatto esplodere in maniera definitiva l'amore per la lettura che ancora oggi permane vivissimo e accompagna bene o male tutte le mie giornate. Avendo negli anni che vanno dalla seconda metà degli 80 ai primi 90 a disposizione più o meno tutte quelle che ancora oggi vengono unanimemente riconosciute come le opere migliori del re del brivido, è facile capire quanto King possa aver colpito l'immaginario di quel giovane lettore. Anche se ormai sbiadito nel ricordo e impolverato nei dettagli dalla mole cospicua di anni passati come l'acqua sotto i ponti, It è forse il libro che tra tutti più è rimasto nel cuore, non necessariamente il meglio riuscito (il finale, insomma...), forse nemmeno il più bello, ma quello che più di tutti ha mantenuto intatta la capacità di far riconoscere a questo lettore la grandezza di un'autore che troppo spesso è stato considerato in quanto scrittore di horror e non come grande scrittore tout court. Tra le mille e passa pagine di It King riusciva a creare pura magia, non tanto quella legata agli eventi sovrannaturali, sebbene stesse cesellando uno dei personaggi horror ancor oggi più riconoscibili, quanto quella universale e fortissima dell'amicizia in quell'età dove gli amici sono tutto, più della famiglia, istituzione qui spesso deleteria, ancora per un po' di tempo più dell'altro sesso; la descrizione dell'adolescenza e dei protagonisti trova qui una felicità di scrittura e di racconto forse pareggiata solo nel più breve Il corpo da cui venne poi tratto il bellissimo Stand by me - Ricordo di un'estate. La storia delle trasposizioni cinematografiche ci ha insegnato che spesso adattare King non è impresa facile, figuriamoci farlo con un libro monumentale come It pieno di suggestioni e che vede protagonisti un numero cospicuo di personaggi, adattamento tra l'altro già tentato senza suscitare troppi entusiasmi con un prodotto destinato alla televisione nel 1990 del quale quasi tutti ricordano più che altro l'interpretazione di Pennywise da parte di Tim Curry. Per questa nuova trasposizione dalla carta allo schermo la gatta da pelare se la prende il regista Andy Muschietti dopo l'abbandono del progetto da parte di Cary Fukunaga che rimane come sceneggiatore e al quale si deve l'idea di separare il film in due parti, una dedicata ai protagonisti adolescenti ambientata sul finire degli 80 e una contemporanea con i ragazzi ormai cresciuti e divenuti adulti.Derry, Maine, sul finire degli anni 80. Il giovane Bill Denbrough (Jaeden Lieberher), costretto a casa con l'influenza, costruisce una barchetta di carta per il fratellino George (Jackson Robert Scott) che la porta fuori in un giorno di pioggia per farla correre sui rivoli d'acqua lungo i marciapiedi. Nel tentativo di recuperare la barchetta caduta in un'apertura di scarico, il piccolo George si imbatte in Pennywise (Bill Skarsgård), un clown capace di essere divertente ma anche molto spaventoso che vive nelle fogne, questi si rivelerà presto un orribile mostro che farà sparire il bambino. Nei mesi successivi le scomparse a Derry si moltiplicano, viene indetto il coprifuoco, Bill non si rassegna alla scomparsa dell'amato fratello convincendosi che possa essere ancora vivo da qualche parte. Intanto al gruppo di amici di Bill che comprende il malaticcio (in apparenza) Eddie (Jack Dylan Grazer), tormentato da una madre iperprotettiva, il timoroso e un po' egoista Stan (Wyatt Oleff) e il volgare ed esuberante Richie (Finn Wolfhard), si aggiungono il grassottello Ben (Jeremy Ray Taylor), un ragazzo gentile e timido appena arrivato in città, la bella e più matura Beverly (Sophia Lillis) proveniente da una situazione familiare molto difficile e il ragazzo di colore Mike (Chosen Jacobs). L'incontro con i nuovi amici non sarà del tutto indolore, tutti quanti questi ragazzi sono infatti perseguitati dai bulli della scuola, una vera banda di delinquenti senza scrupoli capeggiata dall'odioso Henry (Nicholas Hamilton). Le difficoltà cementificheranno l'amicizia tra questi giovani ragazzi che oltre alle violenze dei bulli e i problemi familiari dovranno affrontare la furia ricorrente di Pennywise fino a caricarsi sulle spalle la responsabilità di fermare questa entità sovrannaturale che gli adulti della cittadina fanno finta di non vedere.
Il grande problema di It, almeno di questo primo capitolo, è la mancanza di tempo e di spazio. Nonostante le due ore e quindici minuti di durata del film è quasi impossibile per Muschietti riuscire a portare la profondità e lo spessore di tutti i personaggi delineati in maniera esemplare da King in questa trasposizione per il cinema. Alcuni dei protagonisti sono appena appena abbozzati, Roger, Stan, anche Eddie sono tratteggiati in superficie in pochi passaggi, gli unici un poco più convincenti sono Beverly, Ben e Bill nonostante tutti i protagonisti godano del loro incontro con Pennywise con tanto di manifestazione delle loro peggiori paure. Anche nel contesto si rimane in superficie, si perde il fascino degli anni 50 nei quali era ambientata la prima parte del libro che passava poi agli 80 dei protagonisti adulti, non si scalfisce la superficie degli ambiti familiari se non per la situazione di Beverly, che ha il bellissimo volto di Sophia Lillis, scelta di casting molto indovinata. Detto di un'operazione che non scava più di tanto, c'è da dire che il risultato finale è comunque piacevole e che per gli aspetti più horror e tensivi Muschietti lavora bene, non si discosta dagli stilemi già noti di tanto horror classico ma sfrutta bene gli effetti speciali e i trucchi per spaventare lo spettatore, contando che il film magari ha attirato anche un pubblico adolescente, trova un ottimo Pennywise, molto inquietante grazie alla prova di un Bill Skarsgård molto, molto adatto. Ne esce un buon adattamento a cui manca qualcosa (parecchio in realtà) per ricordare i fasti del romanzo di King, il fatto è che probabilmente ricreare proprio quelle atmosfere lì facendo andare tutto al posto giusto non è possibile. Diciamo che i fan del re si possono accontentare sapendo che in fondo si può sempre tornare alla pagina stampata.