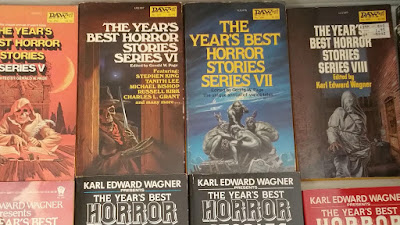(di Gary Ross, 2018)
Tutto abbastanza prevedibile nello sviluppo di questo Ocean's 8, film che nonostante manchi totalmente di suspense e di reali sorprese riesce nell'impresa di intrattenere e divertire a dovere il suo pubblico. Lo schema è quello già visto in Ocean's eleven, l'esordio di quella che a questo punto possiamo considerare la saga degli Ocean imbastita da Steven Soderbergh (qui produttore) diversi anni fa, un primo episodio che già era un remake di Colpo grosso, film del 1960 interpretato dai membri del celebre Rat Pack (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin e Peter Lawford) e che contava due sequel: Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen. Ora si aggiunge alla saga questo nuovo tassello grazie al quale scopriamo che il caro Danny Ocean (ormai defunto?) ha una sorella non meno abile di lui nell'arte del furto. Debbie Ocean (Sandra Bullock) ha appena finito di scontare cinque anni di galera dei quali incolpa il bel gallerista d'arte Claude Baker (Richard Armitage). Durante i cinque anni trascorsi come ospite delle patrie galere la signorina Ocean ha avuto tutto il tempo per pensare ed elaborare un piano per portare a termine il più ambizioso furto di gioielli del secolo, quello di una collana di diamanti di Cartier dal valore inestimabile che (se tutto filerà liscio) farà sfoggio di sé al galà annuale del Metropolitan Museum al collo della bellissima star Daphne Kluger (Anne Hathaway). Per portare a termine l'impresa Debbie vuole una squadra di sole donne che recluterà avvalendosi dell'aiuto della sodale Lou (Cate Blanchett), l'amica di sempre; a completare la squadra ci saranno la stilista di moda Rose Weil (Helena Bonham Carter), l'esperta di gioielli Amita (Mindy Kaling), la ricettatrice Tammy (Sarah Paulson), la borseggiatrice Constance (Awkwafina) e la hacker Palla 9 (Rihanna).
Ocean's 8 è il più classico degli heist movie: idea di base del crimine da compiere, una mente dietro il piano, la ricerca dei componenti che andranno a formare la banda, presentazione dei personaggi, allestimento del piano, esecuzione dello stesso, intoppi e risoluzione con qualche tentativo di sorpresa finale (qui poco riuscito). Sullo schermo non c'è davvero nulla di nuovo, il copione scorre risaputo, nemmeno la regia di Gary Ross regala spunti memorabili, è funzionale e guarda con qualche strizzata d'occhio al lavoro già svolto da Soderbergh anni fa, allo stesso tempo il film funziona, si guarda con piacere e poco impegno più che altro per ammirare al lavoro una manciata di nomi noti in vacanza premio che probabilmente si sono divertiti a girare il film ancor più degli spettatori nel guardarlo. I nomi coinvolti sono importanti, peccato l'assenza di Julia Roberts, volto femminile del primo episodio che non avrebbe stonato qui in mezzo e avrebbe dato quel tocco in più di continuità alla vicenda. Spiace un po' vedere come alcune delle bellezze più mature siano ricorse al classico ritocchino, queste splendide donne sarebbe bello vederle sempre al naturale o quasi, sul versante professionale il talento non manca, scopriamo anche una Hathaway che gioca bene con il lato più comico del suo personaggio e che mostra una marcia in più rispetto alle colleghe (personalmente per la Hathaway ho sempre avuto un debole), autoironica, viene anche presa in giro per i suoi occhioni da Bambi, sorta di tormentone per l'attrice già da diversi anni. La Bullock e la Blanchett sono una garanzia, ma anche tutto il resto del cast è in palla, compresa Palla 9 interpretata da Rihanna che al Cinema inizia a contare ben più di una presenza. Si notano un paio di cameo di componenti del vecchio cast, belle location e il giusto tocco glamour.
Ocean's 8 si va a inserire in quel filone di remake al femminile che sembra ormai un buon appoggio per Hollywood per tornare in maniera diversa su temi già noti, svolta al passo coi tempi o semplice carenza di idee nuove nascosta dietro la bandiera del femminismo? Nulla di male in entrambi i casi, ad ogni modo queste donne meriterebbero qualcosa di meglio di tutto ciò.
lunedì 31 dicembre 2018
giovedì 27 dicembre 2018
PESCA ALLA TROTA IN AMERICA
(Trout fishing in America di Richard Brautigan, 1967)
Inquadrare un'opera come Pesca alla trota in America non è affatto facile, così come non lo è collocare il suo autore Richard Brautigan all'interno della storia della letteratura americana del secolo scorso. Brautigan viene comunemente accostato al fenomeno della controcultura hippy della California di fine anni 60 così come viene spesso citato nel novero di quegli autori che hanno dato energia alla corrente della beat generation; Pesca alla trota in America, che rimane il suo libro di maggior successo, difficilmente riesce a esprimere elementi certi che possano avvalorare e dar peso a classificazioni e accostamenti di questo tipo, se non per affinità parziali o comunque puramente accidentali o del tutto involontarie. Pesca alla trota in America è prima di tutto un corpo estraneo rispetto a qualsiasi altro scritto, libro, romanzo, raccolta di versi, racconti o poesie che sia; è un esito unico, originale, particolare, difficile da comprendere per il lettore medio ma in parte anche per quello più avvezzo a forme di narrazione fuori dagli schemi. Nonostante i due scritti siano per struttura e peso specifico agli antipodi, il primo accostamento che lentamente ha preso corpo all'interno della mia mente è stato quello tra il lavoro di Brautigan e l'immenso Suttree di Cormac McCarthy: i due libri hanno in comune una vicinanza al popolo degli ultimi, degli sconfitti, degli abbandonati e dei miserevoli che non solo si sono visti traditi dal Sogno Americano ma molto più banalmente anche da tutti gli elementi di una vita semplicemente decorosa. Il contrasto tra le due opere è nel piglio, in questo Brautigan si rivela molto più leggiadro, volatile, agile, sinceramente divertente e decisamente più incline alla speranza rispetto a McCarthy: al mondo in qualche modo si sopravvive, con un po' di follia, con un pizzico di incoscienza, con leggerezza; questo sembra dirci Brautigan dalle pagine di Pesca alla trota in America. Invece no, al mondo non si sopravvive, è un fatto, nemmeno l'allampanato Brautigan ci è riuscito, dopo un periodo in cui allo scrittore vengono diagnosticati uno stato depressivo e una schizofrenia paranoide (curata con l'elettroshock) Brautigan pone fine alla sua vita suicidandosi nel Settembre del 1984. Noi possiamo ancora vederlo Brautigan, lungo, in tutta la sua altezza, sulla copertina dell'edizione originale di Trout fishing in America (riprodotta anche all'interno di quella italiana edita da Einaudi), una sorta di cowboy sui generis con tanto di cappello, panciotto e jeans, ritto davanti alla statua di Benjamin Franklin in Washington Square a San Francisco, città in cui passò gli ultimi anni della sua vita. All'apparenza sembra un tipo pacifico Brautigan, magari un po' strambo come il suo libro.
Strambo, perché Pesca alla trota in America non è solo il titolo di un libro, è il libro stesso, a volte è un personaggio incarnato dal nome Pesca alla trota in America, qualche volta è semplicemente un'attività, quella che Brautigan come altri disperati suoi pari amano praticare nei torrenti d'America (i vari creek), poi è un ricettario e allo stesso tempo un commensale di Maria Callas, un cadavere o una frase capace di farti finire per direttissima nell'ufficio del preside. È una forza dirompente capace di farti pensare che non sia così strano che il Missouri possa assomigliare a Deanna Durbin, o che il cane di una vecchia signora pisci pezza o ancora che Pesca alla trota in America possa avere un amico di penna. E perché no, porco diavolo!
Pesca alla trota in America è composto da circa una cinquantina di brevi frammenti, i più lunghi dei quali contano al massimo sette o otto pagine, attraversati da una sottile linea rossa che dipinge tassello dopo tassello un'America ai margini che va comunque intuita, cercata. Nel dipingerla questa America Brautigan usa un registro che a volte lascia spiazzati e interdetti, a volte raggiunge vette di assurda e demenziale comicità capace di farti squassare dalle risate se solo si è capaci di cogliere e abbracciare senza riserve l'atipico e surreale mood dello scrittore di Tacoma. Forse Richard Brautigan avrebbe meritato maggior fama, forse no, e forse Pesca alla trota in America avrebbe potuto scrivere un libro intitolato Richard Brautigan. O forse no. Ai posteri l'ardua sentenza.
Inquadrare un'opera come Pesca alla trota in America non è affatto facile, così come non lo è collocare il suo autore Richard Brautigan all'interno della storia della letteratura americana del secolo scorso. Brautigan viene comunemente accostato al fenomeno della controcultura hippy della California di fine anni 60 così come viene spesso citato nel novero di quegli autori che hanno dato energia alla corrente della beat generation; Pesca alla trota in America, che rimane il suo libro di maggior successo, difficilmente riesce a esprimere elementi certi che possano avvalorare e dar peso a classificazioni e accostamenti di questo tipo, se non per affinità parziali o comunque puramente accidentali o del tutto involontarie. Pesca alla trota in America è prima di tutto un corpo estraneo rispetto a qualsiasi altro scritto, libro, romanzo, raccolta di versi, racconti o poesie che sia; è un esito unico, originale, particolare, difficile da comprendere per il lettore medio ma in parte anche per quello più avvezzo a forme di narrazione fuori dagli schemi. Nonostante i due scritti siano per struttura e peso specifico agli antipodi, il primo accostamento che lentamente ha preso corpo all'interno della mia mente è stato quello tra il lavoro di Brautigan e l'immenso Suttree di Cormac McCarthy: i due libri hanno in comune una vicinanza al popolo degli ultimi, degli sconfitti, degli abbandonati e dei miserevoli che non solo si sono visti traditi dal Sogno Americano ma molto più banalmente anche da tutti gli elementi di una vita semplicemente decorosa. Il contrasto tra le due opere è nel piglio, in questo Brautigan si rivela molto più leggiadro, volatile, agile, sinceramente divertente e decisamente più incline alla speranza rispetto a McCarthy: al mondo in qualche modo si sopravvive, con un po' di follia, con un pizzico di incoscienza, con leggerezza; questo sembra dirci Brautigan dalle pagine di Pesca alla trota in America. Invece no, al mondo non si sopravvive, è un fatto, nemmeno l'allampanato Brautigan ci è riuscito, dopo un periodo in cui allo scrittore vengono diagnosticati uno stato depressivo e una schizofrenia paranoide (curata con l'elettroshock) Brautigan pone fine alla sua vita suicidandosi nel Settembre del 1984. Noi possiamo ancora vederlo Brautigan, lungo, in tutta la sua altezza, sulla copertina dell'edizione originale di Trout fishing in America (riprodotta anche all'interno di quella italiana edita da Einaudi), una sorta di cowboy sui generis con tanto di cappello, panciotto e jeans, ritto davanti alla statua di Benjamin Franklin in Washington Square a San Francisco, città in cui passò gli ultimi anni della sua vita. All'apparenza sembra un tipo pacifico Brautigan, magari un po' strambo come il suo libro.
Strambo, perché Pesca alla trota in America non è solo il titolo di un libro, è il libro stesso, a volte è un personaggio incarnato dal nome Pesca alla trota in America, qualche volta è semplicemente un'attività, quella che Brautigan come altri disperati suoi pari amano praticare nei torrenti d'America (i vari creek), poi è un ricettario e allo stesso tempo un commensale di Maria Callas, un cadavere o una frase capace di farti finire per direttissima nell'ufficio del preside. È una forza dirompente capace di farti pensare che non sia così strano che il Missouri possa assomigliare a Deanna Durbin, o che il cane di una vecchia signora pisci pezza o ancora che Pesca alla trota in America possa avere un amico di penna. E perché no, porco diavolo!
Pesca alla trota in America è composto da circa una cinquantina di brevi frammenti, i più lunghi dei quali contano al massimo sette o otto pagine, attraversati da una sottile linea rossa che dipinge tassello dopo tassello un'America ai margini che va comunque intuita, cercata. Nel dipingerla questa America Brautigan usa un registro che a volte lascia spiazzati e interdetti, a volte raggiunge vette di assurda e demenziale comicità capace di farti squassare dalle risate se solo si è capaci di cogliere e abbracciare senza riserve l'atipico e surreale mood dello scrittore di Tacoma. Forse Richard Brautigan avrebbe meritato maggior fama, forse no, e forse Pesca alla trota in America avrebbe potuto scrivere un libro intitolato Richard Brautigan. O forse no. Ai posteri l'ardua sentenza.
martedì 25 dicembre 2018
REGALI 2018
Ancora tanti auguri a tutti. Questo è il primo Natale in cui la mia bimba è diventata adulta, a mezzanotte ha voluto aprire i regali senza aspettare l'arrivo di Babbo Natale; questa cosa seppur naturale e giusta devo dire che un poco mi ha immalinconito, lei cresce, io invecchio, Babbo Natale si fa i cazzi suoi e la ruota gira. Ad ogni modo anche quest'anno i regali non sono mancati, allietiamoci e tiriamoci su con il vero motore del Natale: il consumismo!
Per contribuire in maniera decisa a questa tradizione io e mia moglie non abbiamo badato a spese, quest'anno abbiamo deciso di sostituire quella merda del nostro aspirapolvere Hoover (che ho odiato più o meno dal giorno dell'acquisto, con un nuovo (e in offertissima) Dyson V8 Absolute, l'abbiamo provato un pochino e devo dire che sembra una vera figata: maneggevolissimo, leggero, pratico, funzionale... addio scopa e addio Hoover di merda!
 |
| Si lo so, la foto fa cagare ma non avevo voglia di scattare... |
Comunque sarebbe questo qua sotto
 |
| foto dal web |
Mio cognato, addetto al reparto "cose frivole", ha portato dall'Inghilterra un thermos targato Marvel Studios con le locandine dei film del Marvel Cinematic Universe in color acciaio, un bell'oggettino davvero!
Settore vestiario: mia moglie Paola e mia figlia hanno pensato a un bel maglione e.... udite udite... un'elegantissima coppola siciliana. Spettacolo!
 |
| Anche qui la foto è quel che è |
Chiudiamo con un paio di libri offerti da mio fratello che fanno sempre più che piacere, senza libri non mi sembra neanche Natale... un po' come la pizza senza sole e mandolino...
Per quest'anno è tutto, e voi cosa avete ricevuto di bello?
lunedì 24 dicembre 2018
BUONE FESTE
Live long and prosper
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
sabato 22 dicembre 2018
MIDNIGHT SPECIAL
(di Jeff Nichols, 2016)
È con rammarico che mi sento di dire che Midnight special è un film riuscito solo in parte, perché gli spunti interessanti nell'opera di Nichols non mancano, viene omaggiata con rispetto la tradizione di un certo Cinema del fantastico e alcune sequenze effettivamente colpiscono nel segno; purtroppo spesso il ritmo non sostiene a dovere idee e contenuti andando a sfilacciare una storia potenzialmente vincente seppur non certo nuova.
America rurale. Le televisioni non fanno che parlare del rapimento di Alton (Jaeden Lieberher), un bambino di otto anni in mano a due loschi figuri. La prima sequenza ce lo mostra nel letto di una camera di un motel, una camera completamente buia, con le finestre oscurate da pezzi di cartone, il bambino indossa degli strani occhialini da piscina e delle cuffie ingombranti. I due uomini nella stanza sono armati ma il bambino sembra stranamente tranquillo. A volte l'apparenza inganna, i due loschi figuri di cui sopra altri non sono che Roy (Michael Shannon), il padre di Alton, e il suo amico d'infanzia nonché poliziotto Lucas (Joel Edgerton) che come solo intento hanno quello di proteggere il bambino in un viaggio attraverso l'America che li porterà verso Sarah (Kirsten Dunst), la madre del ragazzo. Alton va protetto perché è un ragazzo speciale, va protetto dalla setta alla quale i suoi genitori erano affiliati, capeggiata dal leader Calvin Meyer (Sam Shepard), un uomo convinto che Alton sia una sorta di nuovo messia fondamentale per il futuro della setta e non solo. Va protetto dagli agenti del governo che temono per i segreti militari che in qualche modo Alton è in grado di intercettare e interpretare.
Midnight special porta in sé elementi del road movie mischiati a quella fantascienza che punta alla meraviglia tanto cara al Cinema fantastico rivolto soprattutto ai più giovani, il lavoro di Nichols è stato giustamente paragonato al lavoro che il suo illustre predecessore Steven Spielberg ha portato avanti con opere come E.T. o ancor più con Incontri ravvicinati del terzo tipo. I semi effettivamente sono gli stessi, la pianta però non è cresciuta proprio nella stessa maniera. Lo spunto è buono, le vicende del ragazzino incuriosiscono, le sue inspiegabili capacità di parlare in lingue sconosciute, di conoscere informazioni riservate, di proiettare luminosissimi fasci di luce blu dagli occhi, uniti al suo problema con la luce e alle sue "visioni" rendono la vicenda molto intrigante. Nel corso della fuga da tutto e tutti dell'improbabile terzetto, sono diversi i momenti riusciti di un film che non gode di effetti speciali realizzati con cifre da capogiro ma che sopperisce alla mancanza con una buona fotografia e con l'uso discreto e sapiente della costruzione delle scene. Purtroppo questi rimangono, appunto, solo momenti. Non mancano infatti passaggi di stanca, quasi sonnolenti, che spezzano un po' il ritmo di un viaggio sulla strada, troppo spesso buio e notturno, al quale avrebbe giovato una dose maggiore di dinamismo. In più nessuno dei personaggi riesce a ritagliarsi un ruolo di vivo interesse agli occhi dello spettatore (se non il bambino stesso), nemmeno l'agente dell'NSA Sevier (Adam Driver) che dovrebbe essere il punto di contatto tra bambino e istituzioni.
Il finale non sorprende, il viaggio ci porta verso una meta più o meno intuibile, che non delude ma nemmeno entusiasma. Quello di Nichols è un compito svolto con diligenza, probabilmente anche con amore, al quale manca però quel guizzo che gli permette di emergere dalla massa di prodotti simili e ritagliarsi un posto nel nostro immaginario. Ripeto, un vero peccato, perché le basi erano buone. Sarà per la prossima volta.
È con rammarico che mi sento di dire che Midnight special è un film riuscito solo in parte, perché gli spunti interessanti nell'opera di Nichols non mancano, viene omaggiata con rispetto la tradizione di un certo Cinema del fantastico e alcune sequenze effettivamente colpiscono nel segno; purtroppo spesso il ritmo non sostiene a dovere idee e contenuti andando a sfilacciare una storia potenzialmente vincente seppur non certo nuova.
America rurale. Le televisioni non fanno che parlare del rapimento di Alton (Jaeden Lieberher), un bambino di otto anni in mano a due loschi figuri. La prima sequenza ce lo mostra nel letto di una camera di un motel, una camera completamente buia, con le finestre oscurate da pezzi di cartone, il bambino indossa degli strani occhialini da piscina e delle cuffie ingombranti. I due uomini nella stanza sono armati ma il bambino sembra stranamente tranquillo. A volte l'apparenza inganna, i due loschi figuri di cui sopra altri non sono che Roy (Michael Shannon), il padre di Alton, e il suo amico d'infanzia nonché poliziotto Lucas (Joel Edgerton) che come solo intento hanno quello di proteggere il bambino in un viaggio attraverso l'America che li porterà verso Sarah (Kirsten Dunst), la madre del ragazzo. Alton va protetto perché è un ragazzo speciale, va protetto dalla setta alla quale i suoi genitori erano affiliati, capeggiata dal leader Calvin Meyer (Sam Shepard), un uomo convinto che Alton sia una sorta di nuovo messia fondamentale per il futuro della setta e non solo. Va protetto dagli agenti del governo che temono per i segreti militari che in qualche modo Alton è in grado di intercettare e interpretare.
Midnight special porta in sé elementi del road movie mischiati a quella fantascienza che punta alla meraviglia tanto cara al Cinema fantastico rivolto soprattutto ai più giovani, il lavoro di Nichols è stato giustamente paragonato al lavoro che il suo illustre predecessore Steven Spielberg ha portato avanti con opere come E.T. o ancor più con Incontri ravvicinati del terzo tipo. I semi effettivamente sono gli stessi, la pianta però non è cresciuta proprio nella stessa maniera. Lo spunto è buono, le vicende del ragazzino incuriosiscono, le sue inspiegabili capacità di parlare in lingue sconosciute, di conoscere informazioni riservate, di proiettare luminosissimi fasci di luce blu dagli occhi, uniti al suo problema con la luce e alle sue "visioni" rendono la vicenda molto intrigante. Nel corso della fuga da tutto e tutti dell'improbabile terzetto, sono diversi i momenti riusciti di un film che non gode di effetti speciali realizzati con cifre da capogiro ma che sopperisce alla mancanza con una buona fotografia e con l'uso discreto e sapiente della costruzione delle scene. Purtroppo questi rimangono, appunto, solo momenti. Non mancano infatti passaggi di stanca, quasi sonnolenti, che spezzano un po' il ritmo di un viaggio sulla strada, troppo spesso buio e notturno, al quale avrebbe giovato una dose maggiore di dinamismo. In più nessuno dei personaggi riesce a ritagliarsi un ruolo di vivo interesse agli occhi dello spettatore (se non il bambino stesso), nemmeno l'agente dell'NSA Sevier (Adam Driver) che dovrebbe essere il punto di contatto tra bambino e istituzioni.
Il finale non sorprende, il viaggio ci porta verso una meta più o meno intuibile, che non delude ma nemmeno entusiasma. Quello di Nichols è un compito svolto con diligenza, probabilmente anche con amore, al quale manca però quel guizzo che gli permette di emergere dalla massa di prodotti simili e ritagliarsi un posto nel nostro immaginario. Ripeto, un vero peccato, perché le basi erano buone. Sarà per la prossima volta.
mercoledì 19 dicembre 2018
DOCTOR WHO - STAGIONE 11
L'epoca Capaldi è definitivamente tramontata. L'incarnazione del dodicesimo Dottore non mi ha mai convinto in pieno (e questo non l'ho mai nascosto) nonostante Capaldi si sia rivelato un ottimo attore, ben calato nella parte e cresciuto con il tempo, sempre più a suo agio nei panni del Timelord. Probabilmente è arrivato in un momento di crisi creativa, con un Moffat (sceneggiatore) a corto d'ossigeno e una difficoltà diffusa nel creare quel coacervo di emozioni che il serial si è portato dietro per un numero cospicuo di stagioni. Ad ogni modo anche nelle annate che hanno visto protagonista l'attore scozzese non sono mancati momenti alti, puntate molto riuscite e una caratterizzazione del personaggio coerente e progressiva. Alla fine di un ciclo che è durato ben tre stagioni avevo comunque accolto la notizia di una nuova rigenerazione, del cambio di attore protagonista, dell'avvicendamento nel ruolo di showrunner tra Steven Moffat e Chris Chibnall, come la classica e doverosa ventata d'aria fresca che avrebbe potuto donare nuova linfa alla serie per rilanciarla al meglio, convinto che ancora una volta il Dottore (la Dottoressa in questo caso) non ci avrebbe deluso. È stata un delusione su tutti i fronti.
L'occasione era ghiotta, per la prima volta dal 1963 il Dottore, in seguito a una delle sue ormai numerose morti, si rigenera nel corpo di una donna; l'evento ha del clamoroso, una svolta storica al passo coi tempi a dare corpo alla quale è stata chiamata l'attrice inglese Jodie Whittaker, una decina d'anni di carriera alle spalle, nulla di particolarmente memorabile in curriculum ma nemmeno un'attrice di primo pelo. Le prime foto della Whittaker nei panni del Dottore lasciavano ben sperare, il look era quello giusto, il volto anche, i presupposti per far bene non mancavano. Cambio totale anche per quel che riguarda il cast dei comprimari, tutti inseriti nel primo episodio della nuova stagione (The woman who fell to Earth, ottima scelta per il titolo d'apertura), a viaggiare con il Dottore troviamo il giovane Ryan Sinclair (Tosin Cole) nipote della coppia interrazziale formata da Grace O'Brien e del suo nonno "acquisito" Graham O'Brien (Bradley Walsh), lo stesso Graham e un'ex compagna di scuola di Ryan, ora poliziotta in forze al dipartimento di Sheffield, Yasmin Khan (Mandip Gill).
Nel corso dei dieci episodi che compongono questa stagione, molti dei quali di scarsa qualità, abbiamo un Dottore che deve completamente tararsi sul nuovo corpo: un nuovo carattere da definire, l'aspetto femminile da metabolizzare (questo avviene in fretta), una nuova identità da creare, personale ma come sempre coerente con lo storico del personaggio. La tredicesima incarnazione del Timelord è quella alla quale sembra occorrere più tempo per arrivare al suo equilibrio definitivo, a fine stagione sembra che il nuovo Dottore ancora non si sia "fatto", che non sia diventato ancora "adulto" e che nel corso dell'intera annata non sia riuscito a crearsi quel carattere che lo andrà a definire per tutto il tempo che passerà con noi. Se Dodici era il Dottore del gesto gentile (nonostante il carattere spesso scorbutico) e dell'altruismo, Tredici sembra essere il Dottore dell'indecisione, aspetto che emerge dalle scelte del personaggio, dal suo modo di parlare e anche e soprattutto dalle azioni spesso meno incisive ed efficaci di quelle dei suoi predecessori. Se con le incarnazioni precedenti era difficile vedere il Dottore lasciare morti sul campo, qui la cosa avviene con regolarità (anche se non per mano diretta del Dottore) quasi allarmante, spesso il Timelord non riesce a salvare vittime o colpevoli, creando un precedente un pochino straniante nell'economia della serie (anche se nel passato storico del protagonista ci sono grosse zone d'ombra). La scelta della Whittaker non mi sembra malvagia, anzi, proprio come accadeva con Capaldi, nonostante le puntate non sempre girassero al meglio (e quest'anno il livello è sceso ancora parecchio), non ho mai avuto l'impressione che la causa fossero gli attori protagonisti ma ancora una volta mi sembra che tutto sia imputabile a problemi in fase di scrittura. Lo stesso problema si avverte nella cura dei comprimari; a parte Graham che si rivela il personaggio migliore della serie (più dello stesso Dottore) Ryan e Yaz sono ancora appena abbozzati, per il primo si perde lungo il corso delle puntate il suo problema di disprassia che a inizio stagione sembrava dovesse essere uno dei leit motive del personaggio che invece vive più che altro di riflesso sulla relazione con nonno Graham (questa ben gestita a mio avviso), su Yaz si poteva lavorare decisamente di più e meglio, ma magari ci sarà tempo più avanti.
Mancano totalmente gli avversari storici, se Dodici ha dovuto gestire Missy e tutte le precedenti incarnazioni hanno avuto a che fare con Dalek, Slitheen, Cybermen e compagnia danzante, qui non c'è un avversario degno di questo nome, la minaccia degli Stenza si rivela inconsistente e alla memoria rimane forse solo l'alieno P'Ting, un esserino caruccio e vorace che può piacere parecchio ai bambini (a mia figlia è piaciuto molto). La stagione scorre via indolore, spesso annoia, mancano totalmente i picchi emozionali che hanno decretato il successo della serie (c'è proprio qualcosina in un paio di puntate) e anche il finale non vale più di una qualsiasi altra puntata della stagione, presenta qualche buon momento ma troppo poco per una chiusura d'annata. Per chiudere il cerchio manca lo speciale di Capodanno che per risollevare le sorti di una stagione deludente dovrà davvero fare i botti.
Partita con tutti i presupposti per ritagliarsi un posto nella storia della serie, questa undicesima stagione si rivela poco più di una cocente delusione.
L'occasione era ghiotta, per la prima volta dal 1963 il Dottore, in seguito a una delle sue ormai numerose morti, si rigenera nel corpo di una donna; l'evento ha del clamoroso, una svolta storica al passo coi tempi a dare corpo alla quale è stata chiamata l'attrice inglese Jodie Whittaker, una decina d'anni di carriera alle spalle, nulla di particolarmente memorabile in curriculum ma nemmeno un'attrice di primo pelo. Le prime foto della Whittaker nei panni del Dottore lasciavano ben sperare, il look era quello giusto, il volto anche, i presupposti per far bene non mancavano. Cambio totale anche per quel che riguarda il cast dei comprimari, tutti inseriti nel primo episodio della nuova stagione (The woman who fell to Earth, ottima scelta per il titolo d'apertura), a viaggiare con il Dottore troviamo il giovane Ryan Sinclair (Tosin Cole) nipote della coppia interrazziale formata da Grace O'Brien e del suo nonno "acquisito" Graham O'Brien (Bradley Walsh), lo stesso Graham e un'ex compagna di scuola di Ryan, ora poliziotta in forze al dipartimento di Sheffield, Yasmin Khan (Mandip Gill).
Nel corso dei dieci episodi che compongono questa stagione, molti dei quali di scarsa qualità, abbiamo un Dottore che deve completamente tararsi sul nuovo corpo: un nuovo carattere da definire, l'aspetto femminile da metabolizzare (questo avviene in fretta), una nuova identità da creare, personale ma come sempre coerente con lo storico del personaggio. La tredicesima incarnazione del Timelord è quella alla quale sembra occorrere più tempo per arrivare al suo equilibrio definitivo, a fine stagione sembra che il nuovo Dottore ancora non si sia "fatto", che non sia diventato ancora "adulto" e che nel corso dell'intera annata non sia riuscito a crearsi quel carattere che lo andrà a definire per tutto il tempo che passerà con noi. Se Dodici era il Dottore del gesto gentile (nonostante il carattere spesso scorbutico) e dell'altruismo, Tredici sembra essere il Dottore dell'indecisione, aspetto che emerge dalle scelte del personaggio, dal suo modo di parlare e anche e soprattutto dalle azioni spesso meno incisive ed efficaci di quelle dei suoi predecessori. Se con le incarnazioni precedenti era difficile vedere il Dottore lasciare morti sul campo, qui la cosa avviene con regolarità (anche se non per mano diretta del Dottore) quasi allarmante, spesso il Timelord non riesce a salvare vittime o colpevoli, creando un precedente un pochino straniante nell'economia della serie (anche se nel passato storico del protagonista ci sono grosse zone d'ombra). La scelta della Whittaker non mi sembra malvagia, anzi, proprio come accadeva con Capaldi, nonostante le puntate non sempre girassero al meglio (e quest'anno il livello è sceso ancora parecchio), non ho mai avuto l'impressione che la causa fossero gli attori protagonisti ma ancora una volta mi sembra che tutto sia imputabile a problemi in fase di scrittura. Lo stesso problema si avverte nella cura dei comprimari; a parte Graham che si rivela il personaggio migliore della serie (più dello stesso Dottore) Ryan e Yaz sono ancora appena abbozzati, per il primo si perde lungo il corso delle puntate il suo problema di disprassia che a inizio stagione sembrava dovesse essere uno dei leit motive del personaggio che invece vive più che altro di riflesso sulla relazione con nonno Graham (questa ben gestita a mio avviso), su Yaz si poteva lavorare decisamente di più e meglio, ma magari ci sarà tempo più avanti.
Mancano totalmente gli avversari storici, se Dodici ha dovuto gestire Missy e tutte le precedenti incarnazioni hanno avuto a che fare con Dalek, Slitheen, Cybermen e compagnia danzante, qui non c'è un avversario degno di questo nome, la minaccia degli Stenza si rivela inconsistente e alla memoria rimane forse solo l'alieno P'Ting, un esserino caruccio e vorace che può piacere parecchio ai bambini (a mia figlia è piaciuto molto). La stagione scorre via indolore, spesso annoia, mancano totalmente i picchi emozionali che hanno decretato il successo della serie (c'è proprio qualcosina in un paio di puntate) e anche il finale non vale più di una qualsiasi altra puntata della stagione, presenta qualche buon momento ma troppo poco per una chiusura d'annata. Per chiudere il cerchio manca lo speciale di Capodanno che per risollevare le sorti di una stagione deludente dovrà davvero fare i botti.
Partita con tutti i presupposti per ritagliarsi un posto nella storia della serie, questa undicesima stagione si rivela poco più di una cocente delusione.
lunedì 17 dicembre 2018
ORE 15:17 - ATTACCO AL TRENO
(The 15:17 to Paris di Clint Eastwood, 2018)
Con Ore 15:17 - Attacco al treno Eastwood continua la sua esplorazione della figura dell'eroe americano; questa volta, pur annoverando tra i protagonisti del film un paio di militari statunitensi, non troviamo sotto i riflettori una "leggenda" come accadeva per l'idolatrato dai compagni Chris Kyle, il protagonista di American sniper, abbiamo invece tre ragazzi comuni ritratti in un momento delle loro vite che potrebbe essere quello vissuto da chiunque di noi e che per indole naturale e altruismo si trovano a interpretare il ruolo dell'eroe. Attacco al treno narra un episodio realmente accaduto il 21 Agosto 2015 in territorio francese: su un treno diretto a Parigi il giovane Ayoub El Khazzani (Ray Corasani), armato di tutto punto, tenta la strage che verrà impedita solo grazie all'atto di coraggio di Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler, tre ragazzi americani in vacanza in Europa.
L'episodio della neutralizzazione del terrorista nell'economia del film riempie pochi minuti, a Eastwood preme farci vedere come i tre protagonisti siano arrivati al momento che di lì a poco cambierà le loro vite e soprattutto chi sono questi tre ragazzi, da dove provengono, quale è stato il loro percorso di vita. Ciò che di più interessante c'è in questo film non è la narrazione dell'episodio in sé, quanto le scelte tecniche e artistiche adottate da un regista ormai ottantottenne e ancora per niente domo. Parliamo di un regista che ha firmato film di altissimo livello, che sa come mettere in scena qualsiasi cosa in qualsiasi situazione e che ha diretto gente come Tom Hanks, Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Morgan Freeman, John Malkovich, Hilary Swank, Maryl Streep, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Gene Hackman, Ed Harris, Kevin Costner, sé stesso e chissà quanti altri. In controtendenza rispetto alla qualità di alcune sue opere precedenti qui Eastwood sceglie un'adesione alla realtà che sia la più alta possibile, a interpretare i tre ragazzi americani chiama proprio loro, Stone, Skarlatos e Sadler, andando incontro a grossi rischi, rinunciando a nomi di grido e soprattutto affidandosi a una recitazione meno che dilettantistica (i tre giustamente non sono questi grandi attori, vengono surclassati anche dai bambinetti che interpretano i tre protagonisti da piccoli), gira in digitale accentuando quell'idea di reale che il progetto vuole restituire.
Quello che era nelle intenzioni del regista riesce, il film è meno spettacolare, patinato e rifinito di altre sue opere, più diretto, vero, forse però anche meno interessante nei contenuti di altri episodi che si affidavano alla finzione pura. Attacco al treno si apre con i tre ragazzi ancora bambini, Stone e Skarlatos amici da sempre, in fissa con la guerra (saranno i due che diverranno militari), emarginati a scuola, provenienti da famiglie in qualche modo problematiche. Proprio a scuola conosceranno il vivace Anthony Sadler, minuto ma vero ribelle con un posto fisso nell'ufficio del Preside. Quella dell'infanzia è la parte più riuscita e interessante del film (forse perché in video non ci sono i tre protagonisti). Quando i ragazzi diventano adulti Eastwood ce li presenta come tre uomini normalissimi, anche meno dotati della media, vite e lavori poco interessanti fino alla decisione dell'arruolamento che almeno per Stone diverrà una prova con sé stesso per superare i propri limiti, un percorso che non lesinerà delusioni ma che al momento decisivo tornerà utile per uscire da una bruttissima situazione. Sarà lui su quel treno a fare il grosso del lavoro sporco fermando Ayoub El Khazzani. Il punto è che tutti, anche le persone più normali tra di noi, nelle giuste condizioni possono scegliere di fare qualcosa di eroico e di aiutare gli altri, questo è il messaggio che preme a un autore che continua ad esplorare il lato più alto dei suoi personaggi, siano questi delle leggende o semplici turisti (anche se militari). C'è qualche accenno alla predestinazione, c'è molta quotidianità soprattutto nelle sequenze del viaggio in Europa tra Roma, Venezia, Amsterdam e la Germania, c'è della filosofia spiccia, c'è la vita di persone normali che fortuitamente arrivano al punto di svolta delle loro vite.
Un bell'esperimento, Cinema del reale che fa a meno della buona recitazione, che non si avvale di scelte registiche memorabili ma che va dritto al sodo. Ne esce un film sicuramente più interessante che appagante, ma che è un ulteriore passo avanti del vecchio Clint, un uomo che ancora non è intenzionato a fermarsi. Proprio in questi giorni esce in America Il corriere - The mule dove Clint tornerà anche a recitare. Sorprendentemente intramontabile.
Con Ore 15:17 - Attacco al treno Eastwood continua la sua esplorazione della figura dell'eroe americano; questa volta, pur annoverando tra i protagonisti del film un paio di militari statunitensi, non troviamo sotto i riflettori una "leggenda" come accadeva per l'idolatrato dai compagni Chris Kyle, il protagonista di American sniper, abbiamo invece tre ragazzi comuni ritratti in un momento delle loro vite che potrebbe essere quello vissuto da chiunque di noi e che per indole naturale e altruismo si trovano a interpretare il ruolo dell'eroe. Attacco al treno narra un episodio realmente accaduto il 21 Agosto 2015 in territorio francese: su un treno diretto a Parigi il giovane Ayoub El Khazzani (Ray Corasani), armato di tutto punto, tenta la strage che verrà impedita solo grazie all'atto di coraggio di Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler, tre ragazzi americani in vacanza in Europa.
L'episodio della neutralizzazione del terrorista nell'economia del film riempie pochi minuti, a Eastwood preme farci vedere come i tre protagonisti siano arrivati al momento che di lì a poco cambierà le loro vite e soprattutto chi sono questi tre ragazzi, da dove provengono, quale è stato il loro percorso di vita. Ciò che di più interessante c'è in questo film non è la narrazione dell'episodio in sé, quanto le scelte tecniche e artistiche adottate da un regista ormai ottantottenne e ancora per niente domo. Parliamo di un regista che ha firmato film di altissimo livello, che sa come mettere in scena qualsiasi cosa in qualsiasi situazione e che ha diretto gente come Tom Hanks, Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Morgan Freeman, John Malkovich, Hilary Swank, Maryl Streep, Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Gene Hackman, Ed Harris, Kevin Costner, sé stesso e chissà quanti altri. In controtendenza rispetto alla qualità di alcune sue opere precedenti qui Eastwood sceglie un'adesione alla realtà che sia la più alta possibile, a interpretare i tre ragazzi americani chiama proprio loro, Stone, Skarlatos e Sadler, andando incontro a grossi rischi, rinunciando a nomi di grido e soprattutto affidandosi a una recitazione meno che dilettantistica (i tre giustamente non sono questi grandi attori, vengono surclassati anche dai bambinetti che interpretano i tre protagonisti da piccoli), gira in digitale accentuando quell'idea di reale che il progetto vuole restituire.
Quello che era nelle intenzioni del regista riesce, il film è meno spettacolare, patinato e rifinito di altre sue opere, più diretto, vero, forse però anche meno interessante nei contenuti di altri episodi che si affidavano alla finzione pura. Attacco al treno si apre con i tre ragazzi ancora bambini, Stone e Skarlatos amici da sempre, in fissa con la guerra (saranno i due che diverranno militari), emarginati a scuola, provenienti da famiglie in qualche modo problematiche. Proprio a scuola conosceranno il vivace Anthony Sadler, minuto ma vero ribelle con un posto fisso nell'ufficio del Preside. Quella dell'infanzia è la parte più riuscita e interessante del film (forse perché in video non ci sono i tre protagonisti). Quando i ragazzi diventano adulti Eastwood ce li presenta come tre uomini normalissimi, anche meno dotati della media, vite e lavori poco interessanti fino alla decisione dell'arruolamento che almeno per Stone diverrà una prova con sé stesso per superare i propri limiti, un percorso che non lesinerà delusioni ma che al momento decisivo tornerà utile per uscire da una bruttissima situazione. Sarà lui su quel treno a fare il grosso del lavoro sporco fermando Ayoub El Khazzani. Il punto è che tutti, anche le persone più normali tra di noi, nelle giuste condizioni possono scegliere di fare qualcosa di eroico e di aiutare gli altri, questo è il messaggio che preme a un autore che continua ad esplorare il lato più alto dei suoi personaggi, siano questi delle leggende o semplici turisti (anche se militari). C'è qualche accenno alla predestinazione, c'è molta quotidianità soprattutto nelle sequenze del viaggio in Europa tra Roma, Venezia, Amsterdam e la Germania, c'è della filosofia spiccia, c'è la vita di persone normali che fortuitamente arrivano al punto di svolta delle loro vite.
Un bell'esperimento, Cinema del reale che fa a meno della buona recitazione, che non si avvale di scelte registiche memorabili ma che va dritto al sodo. Ne esce un film sicuramente più interessante che appagante, ma che è un ulteriore passo avanti del vecchio Clint, un uomo che ancora non è intenzionato a fermarsi. Proprio in questi giorni esce in America Il corriere - The mule dove Clint tornerà anche a recitare. Sorprendentemente intramontabile.
giovedì 13 dicembre 2018
DIVERGENT
(di Neil Burger, 2014)
Se inquadrato all'interno del target e del segmento commerciale a cui il film è rivolto (quello adolescenziale) Divergent si rivela un prodotto con una sua dignità; indubbiamente siamo di fronte a un film non eccelso ma che ben assolve alla sua duplice funzione: quella di creare un intrattenimento piacevole e coinvolgente tentando un approccio formativo e quella di tirare su un bel mucchietto di dollari sonanti, impresa che al film riesce in pieno. Gli intenti sono chiari fin da subito, Divergent nasce dal romanzo omonimo di Veronica Roth che si può incasellare nel redditizio genere Young adult, narrativa per adolescenti (apprezzata anche da molti adulti) che al suo interno presenta caratteristiche ricorrenti: i primi moti di indipendenza dalla famiglia, gli scossoni amorosi, un percorso di crescita e formazione e ovviamente una buona dose d'avventura declinata nei generi più disparati. Questa breve premessa che accenna agli aspetti commerciali del fenomeno Young adult non è tesa a sminuirlo qualitativamente, anzi, soprattutto per quello che riguarda la narrativa, in un paese in cui sembra si legga sempre meno, ben vengano questo tipo di romanzi se essi si rivelano propedeutici a una cultura della lettura che poi con l'età si svilupperà verso altri autori, generi e forme (mi raccomando, noi quarantenni però non fermiamoci allo Young adult e a Fabio Volo). Ma sto divagando, torniamo al Cinema.
Il film di Neil Burger pur non essendo memorabile funziona a dovere, mette in scena un mix indovinato di giovani attori come si conviene al filone narrativo di appartenenza e conta su qualche nome di maggior richiamo per il pubblico adulto come Ashley Judd e Kate Winslet. Posso immaginare come un film alla stregua di Divergent avrebbe potuto appassionarmi se visto all'età giusta, probabilmente ottimo per gli adolescenti, semplice e passabile intrattenimento per il pubblico adulto. Come ormai spesso accade per i film rivolti ai giovani il contesto è fantascientifico, futuristico, anche distopico se vogliamo.
Scenario post-apocalittico non ben precisato. In seguito a qualche evento catastrofico la città di Chicago sopravvive in maniera indipendente isolata da una recinzione di protezione dalle potenziali minacce esterne. La società è molto cambiata, la popolazione è divisa in cinque caste ben delineate: i Pacifici, una sorta di contadini addetti al sostentamento della popolazione, gente semplice, felice e appunto pacifica; gli Abneganti dediti alla cura del prossimo, vivono di altruismo e per questo sono stati scelti come classe dirigente; i Candidi di indole onesta amministrano la giustizia; gli Eruditi, studiosi e detentori della conoscenza, si occupano del progresso della società; gli Intrepidi, coraggiosi, liberi e spericolati sono i protettori di questa nuova Chicago. Arrivati in età young adult i giovani appartenenti alle varie caste fanno il test, una serie di esami che consigliano loro quale sarà la casta a loro più adatta. Il test è un'indicazione, i ragazzi saranno comunque liberi di continuare a far parte della propria casta d'origine (scelta più comune anche come esito del test) e continuare a frequentare amici e famiglia, così come avranno la libertà di abbandonarli per sempre scegliendo le loro naturali inclinazioni passando ad un'altra casta. Per Beatrice Prior (Shailene Woodley), figlia di Abneganti, il richiamo della libertà, della vitalità energica dei giovani Intrepidi è fortissima, nonostante le aspettative della famiglia è lì che si indirizzerà probabilmente la sua scelta. Al momento del test però accade qualcosa di strano, gli esami non riescono a incasellare Beatrice che risulta avere una mente divergente e questo è un grosso problema. I divergenti sono temuti e cacciati da questa nuova società proprio per la loro alta capacità di usare il libero arbitrio e non farsi incasellare in una categoria predeterminata, la ragazza dovrà così tenere nascosto a tutti il risultato del test, mentire alla propria famiglia e infine scegliere, e la sua sarà una scelta di libertà.
Dopo le sequenze iniziali che porteranno Beatrice a scegliere gli Intrepidi, incomincia quello che è a tutti gli effetti una sorta di romanzo di formazione con l'arrivo dell'indipendenza dalla famiglia, l'addio agli affetti, le relazioni con il nuovo gruppo di amici/reclute conosciute nella nuova casta tra i quali spicca Christina (Zoe Kravitz, figlia di Lenny e di Lisa Bonet), i sentimenti amorosi per il prestante istruttore Tobias (Theo James), la presa di coscienza delle proprie capacità, della propria indole e di ciò che è giusto o sbagliato, ribellione verso i tiranni e via discorrendo. Il film avanza tra scene di addestramento, sequenze dinamiche (non manca nemmeno quella ad "effetto giostra" che al Cinema deve aver fatto la sua figura, quella sul cavo intendo) e rapporti tra i personaggi più che adeguati per un film dall'impianto teen. L'esperienza visiva non delude, il film è ben girato anche se alcuni effetti digitali risultano un poco algidi, freddini, detto questo poco rimane da ricordare di un film che si inserisce in un novero ampio di prodotti simili, magari tra qualche anno Divergent verrà ricordato con affetto come cult personale della giovinezza di qualcuno, personalmente non sento il bisogno di approfondire la conoscenza di questo scenario andando a recuperare anche i successivi capitoli della saga. Così mi autoelimino, sono fuori!
Se inquadrato all'interno del target e del segmento commerciale a cui il film è rivolto (quello adolescenziale) Divergent si rivela un prodotto con una sua dignità; indubbiamente siamo di fronte a un film non eccelso ma che ben assolve alla sua duplice funzione: quella di creare un intrattenimento piacevole e coinvolgente tentando un approccio formativo e quella di tirare su un bel mucchietto di dollari sonanti, impresa che al film riesce in pieno. Gli intenti sono chiari fin da subito, Divergent nasce dal romanzo omonimo di Veronica Roth che si può incasellare nel redditizio genere Young adult, narrativa per adolescenti (apprezzata anche da molti adulti) che al suo interno presenta caratteristiche ricorrenti: i primi moti di indipendenza dalla famiglia, gli scossoni amorosi, un percorso di crescita e formazione e ovviamente una buona dose d'avventura declinata nei generi più disparati. Questa breve premessa che accenna agli aspetti commerciali del fenomeno Young adult non è tesa a sminuirlo qualitativamente, anzi, soprattutto per quello che riguarda la narrativa, in un paese in cui sembra si legga sempre meno, ben vengano questo tipo di romanzi se essi si rivelano propedeutici a una cultura della lettura che poi con l'età si svilupperà verso altri autori, generi e forme (mi raccomando, noi quarantenni però non fermiamoci allo Young adult e a Fabio Volo). Ma sto divagando, torniamo al Cinema.
Il film di Neil Burger pur non essendo memorabile funziona a dovere, mette in scena un mix indovinato di giovani attori come si conviene al filone narrativo di appartenenza e conta su qualche nome di maggior richiamo per il pubblico adulto come Ashley Judd e Kate Winslet. Posso immaginare come un film alla stregua di Divergent avrebbe potuto appassionarmi se visto all'età giusta, probabilmente ottimo per gli adolescenti, semplice e passabile intrattenimento per il pubblico adulto. Come ormai spesso accade per i film rivolti ai giovani il contesto è fantascientifico, futuristico, anche distopico se vogliamo.
Scenario post-apocalittico non ben precisato. In seguito a qualche evento catastrofico la città di Chicago sopravvive in maniera indipendente isolata da una recinzione di protezione dalle potenziali minacce esterne. La società è molto cambiata, la popolazione è divisa in cinque caste ben delineate: i Pacifici, una sorta di contadini addetti al sostentamento della popolazione, gente semplice, felice e appunto pacifica; gli Abneganti dediti alla cura del prossimo, vivono di altruismo e per questo sono stati scelti come classe dirigente; i Candidi di indole onesta amministrano la giustizia; gli Eruditi, studiosi e detentori della conoscenza, si occupano del progresso della società; gli Intrepidi, coraggiosi, liberi e spericolati sono i protettori di questa nuova Chicago. Arrivati in età young adult i giovani appartenenti alle varie caste fanno il test, una serie di esami che consigliano loro quale sarà la casta a loro più adatta. Il test è un'indicazione, i ragazzi saranno comunque liberi di continuare a far parte della propria casta d'origine (scelta più comune anche come esito del test) e continuare a frequentare amici e famiglia, così come avranno la libertà di abbandonarli per sempre scegliendo le loro naturali inclinazioni passando ad un'altra casta. Per Beatrice Prior (Shailene Woodley), figlia di Abneganti, il richiamo della libertà, della vitalità energica dei giovani Intrepidi è fortissima, nonostante le aspettative della famiglia è lì che si indirizzerà probabilmente la sua scelta. Al momento del test però accade qualcosa di strano, gli esami non riescono a incasellare Beatrice che risulta avere una mente divergente e questo è un grosso problema. I divergenti sono temuti e cacciati da questa nuova società proprio per la loro alta capacità di usare il libero arbitrio e non farsi incasellare in una categoria predeterminata, la ragazza dovrà così tenere nascosto a tutti il risultato del test, mentire alla propria famiglia e infine scegliere, e la sua sarà una scelta di libertà.
Dopo le sequenze iniziali che porteranno Beatrice a scegliere gli Intrepidi, incomincia quello che è a tutti gli effetti una sorta di romanzo di formazione con l'arrivo dell'indipendenza dalla famiglia, l'addio agli affetti, le relazioni con il nuovo gruppo di amici/reclute conosciute nella nuova casta tra i quali spicca Christina (Zoe Kravitz, figlia di Lenny e di Lisa Bonet), i sentimenti amorosi per il prestante istruttore Tobias (Theo James), la presa di coscienza delle proprie capacità, della propria indole e di ciò che è giusto o sbagliato, ribellione verso i tiranni e via discorrendo. Il film avanza tra scene di addestramento, sequenze dinamiche (non manca nemmeno quella ad "effetto giostra" che al Cinema deve aver fatto la sua figura, quella sul cavo intendo) e rapporti tra i personaggi più che adeguati per un film dall'impianto teen. L'esperienza visiva non delude, il film è ben girato anche se alcuni effetti digitali risultano un poco algidi, freddini, detto questo poco rimane da ricordare di un film che si inserisce in un novero ampio di prodotti simili, magari tra qualche anno Divergent verrà ricordato con affetto come cult personale della giovinezza di qualcuno, personalmente non sento il bisogno di approfondire la conoscenza di questo scenario andando a recuperare anche i successivi capitoli della saga. Così mi autoelimino, sono fuori!
martedì 11 dicembre 2018
KILLER ELITE
(The killer elite di Sam Peckinpah, 1975)
Pensiamo a Sam Peckinpah e ci torna alla mente il massacro de Il mucchio selvaggio, uno dei western più iconici della storia del Cinema, la fuga verso il Messico di Steve McQueen in Getaway al fianco della bellissima Ali MacGraw, titoli ormai impressi a fuoco nella mente degli appassionati come Pat Garret e Billy Kid o Voglio la testa di Garcia; indubbiamente lo zio Sam nel corso degli anni ha saputo lasciare il segno negli annali della Settima Arte nonostante la sua rappresentazione della crudeltà e della violenza gli abbiano valso le infelici etichette di regista misogino e fascista. All'interno della filmografia di Peckinpah Killer elite, insieme a una manciata di altri titoli, viene considerato un minore, uno di quei film dove meno si avverte la poetica e la cifra stilistica del regista di Fresno, frettolosamente liquidato come un parto dallo scarso interesse. Killer elite esce in anni in cui la corrente impegnata e indipendente della New Hollywood è ancora viva, pellicole che in qualche modo affrontano tematiche simili a quelle toccate da Peckinpah in questo film, I tre giorni del Condor di Pollack ad esempio, riscuotono un grande successo e ancor oggi sono considerati come tasselli importanti del Cinema statunitense degli anni 70. Probabilmente alcune scelte del regista hanno ridimensionato e in parte inficiato le potenzialità di buona riuscita che in nuce anche un film come Killer elite avrebbe potuto sfruttare. Nel complesso il film non è da dimenticare come sostiene qualcuno, sicuramente presenta dei difetti nella parte centrale in cui si dilatano oltremisura i tempi dedicati alle vicende personali del protagonista, alcune prive di grandi sviluppi, mentre la trama centrale del film va in stand by, ripresa poi nell'ultima parte con derive di generi diversi che forse un poco di credibilità al film la fanno perdere. I contenuti però non mancano, Peckinpah in maniera abbastanza diretta formula una sorta di denuncia sui metodi poco puliti e ortodossi che Servizi come la C.I.A. adoperavano su suolo statunitense per perseguire i propri scopi: corruzione, utilizzo di organizzazioni mercenarie non sempre specchiate, violenza.
Mike Locken (James Caan) e George Hansen (Robert Duvall) sono due mercenari al soldo di un'agenzia privata che presta i propri servizi anche alla C.I.A.; i due amici sono specializzati in estrazioni e conseguente protezione di personalità politiche di strategica importanza. Ma in un ambiente dove è il profitto a comandare il gioco, anche il tradimento è da mettere in conto, aspetto che forse Locken ha sempre sottovalutato. Mike si troverà così gravemente ferito, tradito dal suo migliore amico, impossibilitato a riprendere il lavoro e costretto a una convalescenza lunghissima. Col tempo, grazie a una caparbietà infinita, l'uomo si troverà di nuovo in pista a dover affrontare proprio il suo vecchio amico in un'operazione nella quale potrà contare solo su un team fidato davvero ristretto.
La prima parte del film è intrigante, ci presenta la situazione iniziale dalla quale ci si potrebbe aspettare un film sulla scia de La conversazione (Coppola) o similare a Il maratoneta (Schlesinger), le riprese sulla San Francisco dei Seventies da parte di Peckinpah colpiscono ancora, Caan e Duvall sono due presenze caratterizzanti dell'epoca e due professionisti che non scopriamo certo oggi. I presupposti sono ottimi: un bell'incipit, azione solida, intrighi e ottimi interpreti. Il film poi esplode, arriva al suo culmine e si trasforma in una lunga narrazione dove seguiamo principalmente l'incidente e la successiva riabilitazione del personaggio di Caan, una parte centrale lunga, dai ritmi dimessi, utile per inquadrare meglio il personaggio e che si concede anche qualche divagazione superflua (l'infermiera interpretata da Kate Heflin) ma che finisce inevitabilmente per spezzare e smorzare il ritmo del film. Sotto i riflettori rimangono i vertici dell'organizzazione per cui lavoravano Mike e George, i possibili voltafaccia dei loro capi, poi si passa nuovamente all'azione con la creazione di una mini squadra composta dallo stesso Mike, dall'autista Mac (il noto Burt Young) e dall'esperto d'armi Jerome (Bo Hopkins). Il confronto tra questo team e il vecchio amico George riporta tutto su binari più solidi e coinvolgenti, l'ultimissima parte del film invece, seppur ambientata in una location affascinante, richiede da parte dello spettatore un'apertura mentale non da poco, in quanto in un contesto a loro estraneo entrano in scena addirittura dei ninja peraltro davvero poco credibili e ancor meno minacciosi se anche un infortunato James Caan riesce a tener loro testa senza particolari problemi.
Poteva indubbiamente uscirne un film migliore, più incisivo, più solido; l'impressione è che sia per qualche ragione saltato l'equilibrio di un progetto che poteva rivelarsi prezioso per la corrente della New Hollywood. Peccato, ad ogni modo la visione di Killer elite rimane piacevole, è uno dei tanti modi di godere dell'artigianato di tempi ormai perduti.
Pensiamo a Sam Peckinpah e ci torna alla mente il massacro de Il mucchio selvaggio, uno dei western più iconici della storia del Cinema, la fuga verso il Messico di Steve McQueen in Getaway al fianco della bellissima Ali MacGraw, titoli ormai impressi a fuoco nella mente degli appassionati come Pat Garret e Billy Kid o Voglio la testa di Garcia; indubbiamente lo zio Sam nel corso degli anni ha saputo lasciare il segno negli annali della Settima Arte nonostante la sua rappresentazione della crudeltà e della violenza gli abbiano valso le infelici etichette di regista misogino e fascista. All'interno della filmografia di Peckinpah Killer elite, insieme a una manciata di altri titoli, viene considerato un minore, uno di quei film dove meno si avverte la poetica e la cifra stilistica del regista di Fresno, frettolosamente liquidato come un parto dallo scarso interesse. Killer elite esce in anni in cui la corrente impegnata e indipendente della New Hollywood è ancora viva, pellicole che in qualche modo affrontano tematiche simili a quelle toccate da Peckinpah in questo film, I tre giorni del Condor di Pollack ad esempio, riscuotono un grande successo e ancor oggi sono considerati come tasselli importanti del Cinema statunitense degli anni 70. Probabilmente alcune scelte del regista hanno ridimensionato e in parte inficiato le potenzialità di buona riuscita che in nuce anche un film come Killer elite avrebbe potuto sfruttare. Nel complesso il film non è da dimenticare come sostiene qualcuno, sicuramente presenta dei difetti nella parte centrale in cui si dilatano oltremisura i tempi dedicati alle vicende personali del protagonista, alcune prive di grandi sviluppi, mentre la trama centrale del film va in stand by, ripresa poi nell'ultima parte con derive di generi diversi che forse un poco di credibilità al film la fanno perdere. I contenuti però non mancano, Peckinpah in maniera abbastanza diretta formula una sorta di denuncia sui metodi poco puliti e ortodossi che Servizi come la C.I.A. adoperavano su suolo statunitense per perseguire i propri scopi: corruzione, utilizzo di organizzazioni mercenarie non sempre specchiate, violenza.
Mike Locken (James Caan) e George Hansen (Robert Duvall) sono due mercenari al soldo di un'agenzia privata che presta i propri servizi anche alla C.I.A.; i due amici sono specializzati in estrazioni e conseguente protezione di personalità politiche di strategica importanza. Ma in un ambiente dove è il profitto a comandare il gioco, anche il tradimento è da mettere in conto, aspetto che forse Locken ha sempre sottovalutato. Mike si troverà così gravemente ferito, tradito dal suo migliore amico, impossibilitato a riprendere il lavoro e costretto a una convalescenza lunghissima. Col tempo, grazie a una caparbietà infinita, l'uomo si troverà di nuovo in pista a dover affrontare proprio il suo vecchio amico in un'operazione nella quale potrà contare solo su un team fidato davvero ristretto.
La prima parte del film è intrigante, ci presenta la situazione iniziale dalla quale ci si potrebbe aspettare un film sulla scia de La conversazione (Coppola) o similare a Il maratoneta (Schlesinger), le riprese sulla San Francisco dei Seventies da parte di Peckinpah colpiscono ancora, Caan e Duvall sono due presenze caratterizzanti dell'epoca e due professionisti che non scopriamo certo oggi. I presupposti sono ottimi: un bell'incipit, azione solida, intrighi e ottimi interpreti. Il film poi esplode, arriva al suo culmine e si trasforma in una lunga narrazione dove seguiamo principalmente l'incidente e la successiva riabilitazione del personaggio di Caan, una parte centrale lunga, dai ritmi dimessi, utile per inquadrare meglio il personaggio e che si concede anche qualche divagazione superflua (l'infermiera interpretata da Kate Heflin) ma che finisce inevitabilmente per spezzare e smorzare il ritmo del film. Sotto i riflettori rimangono i vertici dell'organizzazione per cui lavoravano Mike e George, i possibili voltafaccia dei loro capi, poi si passa nuovamente all'azione con la creazione di una mini squadra composta dallo stesso Mike, dall'autista Mac (il noto Burt Young) e dall'esperto d'armi Jerome (Bo Hopkins). Il confronto tra questo team e il vecchio amico George riporta tutto su binari più solidi e coinvolgenti, l'ultimissima parte del film invece, seppur ambientata in una location affascinante, richiede da parte dello spettatore un'apertura mentale non da poco, in quanto in un contesto a loro estraneo entrano in scena addirittura dei ninja peraltro davvero poco credibili e ancor meno minacciosi se anche un infortunato James Caan riesce a tener loro testa senza particolari problemi.
Poteva indubbiamente uscirne un film migliore, più incisivo, più solido; l'impressione è che sia per qualche ragione saltato l'equilibrio di un progetto che poteva rivelarsi prezioso per la corrente della New Hollywood. Peccato, ad ogni modo la visione di Killer elite rimane piacevole, è uno dei tanti modi di godere dell'artigianato di tempi ormai perduti.
venerdì 7 dicembre 2018
I LOVE RADIO ROCK
(The boat that rocked di Richard Curtis, 2009)
Nel mare magnum delle nuove proposte cinematografiche, numerose e sgomitanti nell'intento di ritagliarsi un posto al sole tra la mole abnorme di materiale in uscita tra sale, piattaforme e streaming più o meno legale (e aggiungiamoci anche i vari recuperi del Cinema passato che vale sempre la pena non trascurare), può capitare di perdersi qualcosa per strada. Per chi ha con il Cinema un rapporto di pura passione e non di lavoro è inevitabile lasciare indietro qualcosa, anche qualcosa di molto interessante. Poi un bel giorno quel qualcosa ritorna, spunta fuori all'improvviso, e magari ti rendi conto di esserti perso qualcosa di veramente grande. Ciò che può considerarsi grande per ognuno di noi si porta dietro un bel carico di soggettività, quel che lo è per me potrebbe non esserlo per voi, questo è certo. Seguendo i miei personali parametri di giudizio posso però affermare che con I love Radio Rock mi ero perso quello che a mio avviso è uno dei migliori film dell'ultimo decennio, per tutta una serie di motivi. In fondo è semplice: tutti abbiamo un cuore. C'è chi ce l'ha più incline al sentimentalismo, chi più capace di farsi toccare emotivamente, chi ce l'ha un pochino più arido, magari nascosto sotto un lieve strato di cinismo. Ma se in un qualsiasi momento della vostra vita la musica ha avuto un ruolo importante, profondo - e se avete un cuore con un minimo di sensibilità mi riesce difficile credere che quel momento non ci sia stato, breve o eterno poco importa - allora I love Radio Rock non potrà non colpirvi, almeno questo è quello che io credo. Risulta arduo comprendere come un film come questo si sia rivelato poco più di un flop al botteghino, quanto poco sia stato apprezzato dal grande pubblico e quanto sia stato invece sottostimato più o meno ovunque. Con ogni probabilità questo sarà uno di quei film capaci di costruirsi col tempo la fama di cult, almeno tra gli appassionati di musica, non necessariamente solo tra di loro.
I love Radio Rock nasce da un momento storico ben preciso. Siamo nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, nell'Inghilterra perbenista di quel periodo poco spazio era concesso nelle programmazioni radio ai fenomeni musicali del pop, del beat e del rock. Per coprire un bisogno che diveniva sempre più impellente tra le nuove generazioni, nascevano le prime stazioni pirata la più celebre delle quali fu Radio Caroline, emittente ubicata su una nave in rotta continua nelle acque internazionali, soluzione che aggirava le normative britanniche sulle trasmissioni radio. Proprio a Radio Caroline è ispirata la vicenda della Radio Rock del film, una nave pirata con un equipaggio sui generis completamente dedito all'adorazione e alla diffusione della musica rock. Il perno centrale su cui ruota I love Radio Rock è ovviamente la passione per la musica, quella dei magnifici protagonisti del film ma soprattutto la nostra, quella dei suoi amanti. All'interno del film Richard Curtis, anche sceneggiatore, è riuscito a calibrare questa passione mischiandola con dosi importanti di amicizia e solidarietà tra simili, spruzzate d'amore e sentimento, di passione (non solo per la musica); il regista esplora relazioni familiari, inscena rivalità epiche e riconciliazioni commoventi e annega il tutto in un vero mare (fisico e metaforico) di splendida musica. La colonna sonora è di una qualità spaventosa, alcuni dei pezzi proposti si sposano alle scene del film in maniera simbiontica aumentandone la riuscita in maniera esponenziale. In mezzo a tutto questo un cast di attori e personaggi indovinatissimi, un cast molto allargato all'interno del quale ad ogni singolo componente è dedicato il giusto spazio necessario a tratteggiarlo a dovere e a farcelo apprezzare e amare.
Il giovane Carl (Tom Sturridge), ragazzo timido e ben educato, si imbarca su Radio Rock per passare un periodo in compagnia del suo padrino Quentin (Bill Nighy), l'uomo al comando, il proprietario di Radio Rock, un elegantissimo ribelle con una missione da portare avanti e con un pizzico di diplomazia da dover gestire all'interno di una ciurma simpaticamente ingestibile. Al suo servizio, e al servizio di tutta una nazione, un gruppo di Dj amatissimi in tutta la terra d'Albione. Il più carismatico, quello pronto a sacrificare tutto per la causa è senz'altro il Conte (un divino Philip Seymour Hoffman), il suo rivale è il redivivo Gavin (Rhys Ifans), idolo delle donne, dj che gioca con una sensualità molto marcata. Dave (Nick Frost) è un ciclone d'esuberanza, nonostante il fisico poco prestante ha un enorme successo con l'altro sesso, la sua controparte timida e sfigata è Simon (Chris O'Dowd) che però in radio fa scintille (di persona invece...); Bob (Ralph Brown) è una sorta di eremita fantasma, trasmette solo nelle ore più improbabili, Angus (Rhys Darby) è quello che non piace a nessuno, un comico che non fa ridere ma al quale sotto sotto vogliono tutti un gran bene, la parte dello strambo è cucita addosso a Kevin (Tom Brooke). Tra tanta musica ci sono anche news e meteo offerte in maniera incerta e tentennante dall'impacciato John (Will Adamsdale), esatto opposto del cool e poco ciarliero Mark (Tom Wisdom). Insomma, l'equipaggio è variegato, a Richard Curtis bastano pochi momenti per definire in ognuno dei personaggi un carattere, l'impresa non così facile riesce alla perfezione assicurando gran parte della riuscita del film.
Il resto lo fa la musica ma risultano indovinate tutta una serie di sequenze e scene madri che spaziano dall'esaltante al commovente, momenti capaci di regalare qualcosa allo spettatore e in qualche modo di riempire i cuori, è un film di pancia, di cuore I love Radio Rock, inutile come hanno fatto diversi detrattori andarlo a scandagliare troppo con la testa, si rischia solo di non godere di un film che è principalmente (unicamente?) emozione con la E maiuscola. Vogliamo criticare il momento in cui Eleanore (January Jones) sale a bordo sulle note di Eleanore dei The Turtles? Contestare Marianne di Leonard Cohen? Analizzare la mole di magia in vinile dispersa sul fondo di un'inondazione d'acqua? Fare le pulci al Conte? Non scherziamo. È stato detto che il film è troppo lungo... forse sì, per chi non ha un cuore ricettivo a sufficienza. Lo sviluppo per qualcuno s'avviluppa... può essere, se non si è capaci di godere con trasporto di un'emozione, di ogni momento. In I love Radio Rock ho trovato davvero tanto: una medicina, tanto amore e, lo ripeto, uno dei migliori film del decennio. Tutto è sindacabile, certo, ma cercate per bene, tutti abbiamo un cuore, lì sta la chiave.
Nel mare magnum delle nuove proposte cinematografiche, numerose e sgomitanti nell'intento di ritagliarsi un posto al sole tra la mole abnorme di materiale in uscita tra sale, piattaforme e streaming più o meno legale (e aggiungiamoci anche i vari recuperi del Cinema passato che vale sempre la pena non trascurare), può capitare di perdersi qualcosa per strada. Per chi ha con il Cinema un rapporto di pura passione e non di lavoro è inevitabile lasciare indietro qualcosa, anche qualcosa di molto interessante. Poi un bel giorno quel qualcosa ritorna, spunta fuori all'improvviso, e magari ti rendi conto di esserti perso qualcosa di veramente grande. Ciò che può considerarsi grande per ognuno di noi si porta dietro un bel carico di soggettività, quel che lo è per me potrebbe non esserlo per voi, questo è certo. Seguendo i miei personali parametri di giudizio posso però affermare che con I love Radio Rock mi ero perso quello che a mio avviso è uno dei migliori film dell'ultimo decennio, per tutta una serie di motivi. In fondo è semplice: tutti abbiamo un cuore. C'è chi ce l'ha più incline al sentimentalismo, chi più capace di farsi toccare emotivamente, chi ce l'ha un pochino più arido, magari nascosto sotto un lieve strato di cinismo. Ma se in un qualsiasi momento della vostra vita la musica ha avuto un ruolo importante, profondo - e se avete un cuore con un minimo di sensibilità mi riesce difficile credere che quel momento non ci sia stato, breve o eterno poco importa - allora I love Radio Rock non potrà non colpirvi, almeno questo è quello che io credo. Risulta arduo comprendere come un film come questo si sia rivelato poco più di un flop al botteghino, quanto poco sia stato apprezzato dal grande pubblico e quanto sia stato invece sottostimato più o meno ovunque. Con ogni probabilità questo sarà uno di quei film capaci di costruirsi col tempo la fama di cult, almeno tra gli appassionati di musica, non necessariamente solo tra di loro.
I love Radio Rock nasce da un momento storico ben preciso. Siamo nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, nell'Inghilterra perbenista di quel periodo poco spazio era concesso nelle programmazioni radio ai fenomeni musicali del pop, del beat e del rock. Per coprire un bisogno che diveniva sempre più impellente tra le nuove generazioni, nascevano le prime stazioni pirata la più celebre delle quali fu Radio Caroline, emittente ubicata su una nave in rotta continua nelle acque internazionali, soluzione che aggirava le normative britanniche sulle trasmissioni radio. Proprio a Radio Caroline è ispirata la vicenda della Radio Rock del film, una nave pirata con un equipaggio sui generis completamente dedito all'adorazione e alla diffusione della musica rock. Il perno centrale su cui ruota I love Radio Rock è ovviamente la passione per la musica, quella dei magnifici protagonisti del film ma soprattutto la nostra, quella dei suoi amanti. All'interno del film Richard Curtis, anche sceneggiatore, è riuscito a calibrare questa passione mischiandola con dosi importanti di amicizia e solidarietà tra simili, spruzzate d'amore e sentimento, di passione (non solo per la musica); il regista esplora relazioni familiari, inscena rivalità epiche e riconciliazioni commoventi e annega il tutto in un vero mare (fisico e metaforico) di splendida musica. La colonna sonora è di una qualità spaventosa, alcuni dei pezzi proposti si sposano alle scene del film in maniera simbiontica aumentandone la riuscita in maniera esponenziale. In mezzo a tutto questo un cast di attori e personaggi indovinatissimi, un cast molto allargato all'interno del quale ad ogni singolo componente è dedicato il giusto spazio necessario a tratteggiarlo a dovere e a farcelo apprezzare e amare.
Il giovane Carl (Tom Sturridge), ragazzo timido e ben educato, si imbarca su Radio Rock per passare un periodo in compagnia del suo padrino Quentin (Bill Nighy), l'uomo al comando, il proprietario di Radio Rock, un elegantissimo ribelle con una missione da portare avanti e con un pizzico di diplomazia da dover gestire all'interno di una ciurma simpaticamente ingestibile. Al suo servizio, e al servizio di tutta una nazione, un gruppo di Dj amatissimi in tutta la terra d'Albione. Il più carismatico, quello pronto a sacrificare tutto per la causa è senz'altro il Conte (un divino Philip Seymour Hoffman), il suo rivale è il redivivo Gavin (Rhys Ifans), idolo delle donne, dj che gioca con una sensualità molto marcata. Dave (Nick Frost) è un ciclone d'esuberanza, nonostante il fisico poco prestante ha un enorme successo con l'altro sesso, la sua controparte timida e sfigata è Simon (Chris O'Dowd) che però in radio fa scintille (di persona invece...); Bob (Ralph Brown) è una sorta di eremita fantasma, trasmette solo nelle ore più improbabili, Angus (Rhys Darby) è quello che non piace a nessuno, un comico che non fa ridere ma al quale sotto sotto vogliono tutti un gran bene, la parte dello strambo è cucita addosso a Kevin (Tom Brooke). Tra tanta musica ci sono anche news e meteo offerte in maniera incerta e tentennante dall'impacciato John (Will Adamsdale), esatto opposto del cool e poco ciarliero Mark (Tom Wisdom). Insomma, l'equipaggio è variegato, a Richard Curtis bastano pochi momenti per definire in ognuno dei personaggi un carattere, l'impresa non così facile riesce alla perfezione assicurando gran parte della riuscita del film.
Il resto lo fa la musica ma risultano indovinate tutta una serie di sequenze e scene madri che spaziano dall'esaltante al commovente, momenti capaci di regalare qualcosa allo spettatore e in qualche modo di riempire i cuori, è un film di pancia, di cuore I love Radio Rock, inutile come hanno fatto diversi detrattori andarlo a scandagliare troppo con la testa, si rischia solo di non godere di un film che è principalmente (unicamente?) emozione con la E maiuscola. Vogliamo criticare il momento in cui Eleanore (January Jones) sale a bordo sulle note di Eleanore dei The Turtles? Contestare Marianne di Leonard Cohen? Analizzare la mole di magia in vinile dispersa sul fondo di un'inondazione d'acqua? Fare le pulci al Conte? Non scherziamo. È stato detto che il film è troppo lungo... forse sì, per chi non ha un cuore ricettivo a sufficienza. Lo sviluppo per qualcuno s'avviluppa... può essere, se non si è capaci di godere con trasporto di un'emozione, di ogni momento. In I love Radio Rock ho trovato davvero tanto: una medicina, tanto amore e, lo ripeto, uno dei migliori film del decennio. Tutto è sindacabile, certo, ma cercate per bene, tutti abbiamo un cuore, lì sta la chiave.
lunedì 3 dicembre 2018
EVA CONTRO EVA
(All about Eve di Joseph L. Mankiewicz, 1950)
Il 1950 è stata una grandissima annata per il Cinema statunitense, guardando solamente alla cinquina dei titoli candidati all'Oscar per la categoria miglior film possiamo trovare alcuni dei classici intramontabili del Cinema americano: Le miniere di Re Salomone di Bennett e Marton, Nata ieri di George Cukor, Il padre della sposa di Vincente Minnelli, il magnifico Viale del tramonto di Billy Wilder e questo Eva contro Eva che riuscì a sbaragliare una concorrenza di livello stratosferico e ad aggiudicarsi questa e altre cinque statuette (regia, attore non protagonista, sceneggiatura non originale, costumi e sonoro). Dev'essere stata una soddisfazione non da poco per Mankiewicz che si vide assegnare personalmente oltre al premio per il miglior film anche quello per la sceneggiatura da lui scritta e quello per la regia, in un anno in cui i nomi dei registi in lizza erano davvero da brividi.
Tra i premiati, grande assente la protagonista del film, una Bette Davis qui come altrove in splendida forma, all'epoca già insignita di due premi Oscar e che in futuro lascerà ancora e ancora il segno in pellicole fondamentali come Che fine ha fatto Baby Jane? e Piano... piano, dolce Carlotta. La messa in scena del film è sontuosa fin dalla prima sequenza, come si addice all'ambiente raccontato, il bel mondo del teatro, tra attrici sulla cresta dell'onda, impresari, sceneggiatori di grido e critici autorevoli capaci di cambiare le carriere di qualsiasi star e decretare il successo o l'insuccesso delle opere in cartellone.
È proprio con l'assegnazione di un premio che si apre Eva contro Eva, si attende la rivelazione del nome della miglior attrice di teatro dell'anno, sarà Eva Harrington (Anne Baxter) ad affermarsi, astro nascente che eclissa l'ormai più attempata Margo Channing (Bette Davis), attrice di razza riconosciuta per tanti anni come la migliore interprete sulle scene teatrali dell'epoca. L'apertura è in media res, la voce narrante quella del critico teatrale Addison DeWitt (George Sanders, qui premio Oscar), ormai Eva Harrington è una star acclamata ma solo una manciata di mesi prima le cose erano molto diverse; è grazie ai ricordi di Karen Richards (Celeste Holm), moglie del commediografo Lloyd Richards (Hugh Marlowe), che lo spettatore può ripercorrere i mesi lungo i quali avviene la trasformazione da bruco a farfalla di quella che era una ragazza all'apparenza mite e sempliciotta e che a fine del suo percorso diverrà l'attrice del momento, non mancando di rivelare lati del suo carattere in principio poco intuibili.
In Eva contro Eva c'è tutta la bellezza del Cinema Classico Hollywoodiano, la luce calibrata alla perfezione restituita da un bianco e nero sempre incisivo e mai sbiadito, attori in primo piano con un ottimo confronto nel confronto a opera delle bravissime Bette Davis (che sguardi, Kim Carnes ne sapeva qualcosa) e la più giovane Anne Baxter, recitazione da manuale, scenografie lussuose e dettagliate e un'eleganza diffusa che coinvolge la narrazione tout court così come gli spazi, luci ed ombre e tutti i movimenti di macchina funzionali alla buona riuscita del film.
Curioso notare come i contenuti siano molto simili a quelli dell'altro grande film dell'annata, Viale del tramonto di Billy Wilder, con il declino della star affermata, ormai accantonata a causa dell'arrivo del moderno, sia questo un nuovo tipo di Cinema (il sonoro in Viale del tramonto) o una star più fresca come accade in Eva contro Eva. In più c'è la competizione nel mondo artistico che può nascondere arrivismo, calcolo, tradimento, caratteristiche imprescindibili nella costruzione di questo dramma dello spettacolo, un mondo tanto scintillante quanto oscuro e falso nel dietro le quinte, che sia questo Cinema o teatro poco importa.
Eva contro Eva è graziato oltre che dalle interpretazioni superlative degli attori nei ruoli principali, anche dall'aiuto di comprimari sempre all'altezza, una su tutte la burbera governante di Margo Channing interpretata da Thelma Ritter, e soprattutto da una vena ironica che emerge in alcuni dialoghi e stempera quella che è una struttura ascrivibile al dramma. Uno di quei film che hanno contribuito a rendere grande l'industria cinematografica della Hollywood che fu.
Il 1950 è stata una grandissima annata per il Cinema statunitense, guardando solamente alla cinquina dei titoli candidati all'Oscar per la categoria miglior film possiamo trovare alcuni dei classici intramontabili del Cinema americano: Le miniere di Re Salomone di Bennett e Marton, Nata ieri di George Cukor, Il padre della sposa di Vincente Minnelli, il magnifico Viale del tramonto di Billy Wilder e questo Eva contro Eva che riuscì a sbaragliare una concorrenza di livello stratosferico e ad aggiudicarsi questa e altre cinque statuette (regia, attore non protagonista, sceneggiatura non originale, costumi e sonoro). Dev'essere stata una soddisfazione non da poco per Mankiewicz che si vide assegnare personalmente oltre al premio per il miglior film anche quello per la sceneggiatura da lui scritta e quello per la regia, in un anno in cui i nomi dei registi in lizza erano davvero da brividi.
Tra i premiati, grande assente la protagonista del film, una Bette Davis qui come altrove in splendida forma, all'epoca già insignita di due premi Oscar e che in futuro lascerà ancora e ancora il segno in pellicole fondamentali come Che fine ha fatto Baby Jane? e Piano... piano, dolce Carlotta. La messa in scena del film è sontuosa fin dalla prima sequenza, come si addice all'ambiente raccontato, il bel mondo del teatro, tra attrici sulla cresta dell'onda, impresari, sceneggiatori di grido e critici autorevoli capaci di cambiare le carriere di qualsiasi star e decretare il successo o l'insuccesso delle opere in cartellone.
È proprio con l'assegnazione di un premio che si apre Eva contro Eva, si attende la rivelazione del nome della miglior attrice di teatro dell'anno, sarà Eva Harrington (Anne Baxter) ad affermarsi, astro nascente che eclissa l'ormai più attempata Margo Channing (Bette Davis), attrice di razza riconosciuta per tanti anni come la migliore interprete sulle scene teatrali dell'epoca. L'apertura è in media res, la voce narrante quella del critico teatrale Addison DeWitt (George Sanders, qui premio Oscar), ormai Eva Harrington è una star acclamata ma solo una manciata di mesi prima le cose erano molto diverse; è grazie ai ricordi di Karen Richards (Celeste Holm), moglie del commediografo Lloyd Richards (Hugh Marlowe), che lo spettatore può ripercorrere i mesi lungo i quali avviene la trasformazione da bruco a farfalla di quella che era una ragazza all'apparenza mite e sempliciotta e che a fine del suo percorso diverrà l'attrice del momento, non mancando di rivelare lati del suo carattere in principio poco intuibili.
In Eva contro Eva c'è tutta la bellezza del Cinema Classico Hollywoodiano, la luce calibrata alla perfezione restituita da un bianco e nero sempre incisivo e mai sbiadito, attori in primo piano con un ottimo confronto nel confronto a opera delle bravissime Bette Davis (che sguardi, Kim Carnes ne sapeva qualcosa) e la più giovane Anne Baxter, recitazione da manuale, scenografie lussuose e dettagliate e un'eleganza diffusa che coinvolge la narrazione tout court così come gli spazi, luci ed ombre e tutti i movimenti di macchina funzionali alla buona riuscita del film.
Curioso notare come i contenuti siano molto simili a quelli dell'altro grande film dell'annata, Viale del tramonto di Billy Wilder, con il declino della star affermata, ormai accantonata a causa dell'arrivo del moderno, sia questo un nuovo tipo di Cinema (il sonoro in Viale del tramonto) o una star più fresca come accade in Eva contro Eva. In più c'è la competizione nel mondo artistico che può nascondere arrivismo, calcolo, tradimento, caratteristiche imprescindibili nella costruzione di questo dramma dello spettacolo, un mondo tanto scintillante quanto oscuro e falso nel dietro le quinte, che sia questo Cinema o teatro poco importa.
Eva contro Eva è graziato oltre che dalle interpretazioni superlative degli attori nei ruoli principali, anche dall'aiuto di comprimari sempre all'altezza, una su tutte la burbera governante di Margo Channing interpretata da Thelma Ritter, e soprattutto da una vena ironica che emerge in alcuni dialoghi e stempera quella che è una struttura ascrivibile al dramma. Uno di quei film che hanno contribuito a rendere grande l'industria cinematografica della Hollywood che fu.
venerdì 30 novembre 2018
SCAPPA - GET OUT
(Get out di Jordan Peele, 2017)
Classificato come thriller/horror alla fine questo Scappa - Get out si rivela essere un film più divertente che spaventoso. L'incipit guarda proprio a uno dei capisaldi della commedia classica americana, quell'Indovina chi viene a cena? che poteva vantare un cast eccezionale composto da Spencer Tracy, Katherine Hepburn (protagonisti nella vita di una storia d'amore all'epoca scandalosa e chiacchierata) e da un giovane Sidney Poitier. Quest'ultimo è il giovane fidanzato nero della figlia dei due attori di cui sopra; soprattutto il padre farà una certa difficoltà ad accettare la relazione della figlia con un afroamericano nell'America ancora bigotta e perbenista degli anni 60. In Get out l'idea di partenza è la stessa: Rose Armitage (Allison Williams) organizza un weekend nella lussuosa residenza della sua famiglia per presentare ai genitori il suo nuovo fidanzato, il fotografo nero Chris Washington (Daniel Kaluuya). Chris è un po' preoccupato dal fatto che Rose non abbia esplicitato alla sua famiglia, fratello compreso (Caleb Landry Jones), il colore della pelle del nuovo partner. A differenza di quel che accadeva a Sidney Poitier nei 60, Chris viene accolto a braccia aperte, la famiglia di Rose, composta dal padre Dan (Bradley Withford) e dalla madre Missy (Catherine Keener), è una famiglia moderna; Dan adora Obama, le loro idee sono inclusive e progressiste, il ragazzo sembra dover diventare un amicone ben accetto nel nuovo nucleo familiare.
Però. Perché c'è sempre un però. Nel tempo trascorso con gli Armitage, Chris ha l'occasione di girovagare per la tenuta: casualmente nota che il giardiniere di famiglia (Marcus Henderson) è un nero, la domestica Georgina (Betty Gabriel) pure, il padre di Rose imbarazzato quasi se ne scusa con il potenziale genero, inoltre entrambi i "servitori" sembrano avere qualcosa di strano e inquietante che inizia a mettere in allarme il giovane. Le sensazioni sgradevoli aumentano quando nella villa inizia il raduno degli amici di famiglia durante il quale Chris si imbatterà nella presenza di altri personaggi molto strani (e neri). Cosa c'è che non va nel giro di conoscenze della famiglia Armitage?
Ciò che sembra premere al regista Jordan Peele (nero), più che la costruzione di un film horror o di una commedia, classificazioni che qui lasciano il tempo che trovano, è il discorso sull'integrazione, sul rispetto, sull'accettazione della popolazione nera in America che purtroppo dagli anni 60 a oggi non ha fatto questi grandi passi in avanti. Il film arriva in un momento storico nel quale in America la parità di trattamento tra le razze sembra stia regredendo invece di progredire, episodi violenti ai danni di cittadini neri da parte delle forze dell'ordine, l'elezione di Trump alla Casa Bianca sono tutti segnali che non lasciano ben sperare. Scappa - Get out è una puntuale metafora di una situazione che a un regista di colore non poteva non stare a cuore; purtroppo lo stesso titolo del film non lascia intravedere molte speranze, alla fine, come per alcuni versi accade anche nella pellicola, per i neri sembra non rimanere altro da fare se non scappare lontano da quella classe gretta (e purtroppo dirigente) composta in maggioranza da bianchi e magari anche da qualche "fratello", fagocitato, asservito e inglobato nella mentalità supremazista e predatoria dei bianchi.
Dietro un'impostazione narrativa leggera si nasconde (ma neanche tanto) un discorso forse risaputo ma estremamente importante e delicato. Nonostante in sé il film non abbia nulla di memorabile, si lascia apprezzare per una buona riuscita unita a un discreto valore politico, qualità che sono valse a Get out un Oscar per la miglior sceneggiatura originale (sempre di Peele) e diversi riconoscimenti in numerosi festival. Un ottimo risultato se teniamo conto del fatto che questo per Peele è il primo film dietro la macchina da presa.
Classificato come thriller/horror alla fine questo Scappa - Get out si rivela essere un film più divertente che spaventoso. L'incipit guarda proprio a uno dei capisaldi della commedia classica americana, quell'Indovina chi viene a cena? che poteva vantare un cast eccezionale composto da Spencer Tracy, Katherine Hepburn (protagonisti nella vita di una storia d'amore all'epoca scandalosa e chiacchierata) e da un giovane Sidney Poitier. Quest'ultimo è il giovane fidanzato nero della figlia dei due attori di cui sopra; soprattutto il padre farà una certa difficoltà ad accettare la relazione della figlia con un afroamericano nell'America ancora bigotta e perbenista degli anni 60. In Get out l'idea di partenza è la stessa: Rose Armitage (Allison Williams) organizza un weekend nella lussuosa residenza della sua famiglia per presentare ai genitori il suo nuovo fidanzato, il fotografo nero Chris Washington (Daniel Kaluuya). Chris è un po' preoccupato dal fatto che Rose non abbia esplicitato alla sua famiglia, fratello compreso (Caleb Landry Jones), il colore della pelle del nuovo partner. A differenza di quel che accadeva a Sidney Poitier nei 60, Chris viene accolto a braccia aperte, la famiglia di Rose, composta dal padre Dan (Bradley Withford) e dalla madre Missy (Catherine Keener), è una famiglia moderna; Dan adora Obama, le loro idee sono inclusive e progressiste, il ragazzo sembra dover diventare un amicone ben accetto nel nuovo nucleo familiare.
Però. Perché c'è sempre un però. Nel tempo trascorso con gli Armitage, Chris ha l'occasione di girovagare per la tenuta: casualmente nota che il giardiniere di famiglia (Marcus Henderson) è un nero, la domestica Georgina (Betty Gabriel) pure, il padre di Rose imbarazzato quasi se ne scusa con il potenziale genero, inoltre entrambi i "servitori" sembrano avere qualcosa di strano e inquietante che inizia a mettere in allarme il giovane. Le sensazioni sgradevoli aumentano quando nella villa inizia il raduno degli amici di famiglia durante il quale Chris si imbatterà nella presenza di altri personaggi molto strani (e neri). Cosa c'è che non va nel giro di conoscenze della famiglia Armitage?
Ciò che sembra premere al regista Jordan Peele (nero), più che la costruzione di un film horror o di una commedia, classificazioni che qui lasciano il tempo che trovano, è il discorso sull'integrazione, sul rispetto, sull'accettazione della popolazione nera in America che purtroppo dagli anni 60 a oggi non ha fatto questi grandi passi in avanti. Il film arriva in un momento storico nel quale in America la parità di trattamento tra le razze sembra stia regredendo invece di progredire, episodi violenti ai danni di cittadini neri da parte delle forze dell'ordine, l'elezione di Trump alla Casa Bianca sono tutti segnali che non lasciano ben sperare. Scappa - Get out è una puntuale metafora di una situazione che a un regista di colore non poteva non stare a cuore; purtroppo lo stesso titolo del film non lascia intravedere molte speranze, alla fine, come per alcuni versi accade anche nella pellicola, per i neri sembra non rimanere altro da fare se non scappare lontano da quella classe gretta (e purtroppo dirigente) composta in maggioranza da bianchi e magari anche da qualche "fratello", fagocitato, asservito e inglobato nella mentalità supremazista e predatoria dei bianchi.
Dietro un'impostazione narrativa leggera si nasconde (ma neanche tanto) un discorso forse risaputo ma estremamente importante e delicato. Nonostante in sé il film non abbia nulla di memorabile, si lascia apprezzare per una buona riuscita unita a un discreto valore politico, qualità che sono valse a Get out un Oscar per la miglior sceneggiatura originale (sempre di Peele) e diversi riconoscimenti in numerosi festival. Un ottimo risultato se teniamo conto del fatto che questo per Peele è il primo film dietro la macchina da presa.
martedì 27 novembre 2018
THE INFORMANT!
(di Steven Soderbergh, 2009)
Ridendo e scherzando anche a Steven Soderbergh manca un solo lustro per toccare i sessant'anni, non si direbbe per un regista che da sempre continua a dare l'idea del giovanotto in eterno movimento, quasi schizofrenico e colpito a tratti da urgenze creative tra le più disparate. Più o meno una trentina di film all'attivo in altrettanti anni di carriera, diverse dichiarazioni di ritiro dalle scene (tutte smentite), e poi ancora produzione, montaggio, serie tv, corti, sceneggiature, film girati con il cellulare, e chissà cos'altro. Nel palmares un Oscar alla regia per Traffic e una Palma d'oro per Sesso, bugie e videotapes. Tra i vari interessi del regista c'è anche quello per un certo tipo di Cinema che si avvicina, magari solo lateralmente, a quello d'indagine e di denuncia: lo stesso Traffic sfiorava argomenti delicati pur rimanendo nella finzione, Erin Brockovich rientra invece appieno nel genere e in qualche modo, sicuramente molto meno serioso, ci si affaccia anche questo The informant!
Il grosso del lavoro per la buona riuscita di questo film lo si deve a un ottimo Matt Damon: un po' imbolsito, faccia quasi da ebete, calato nei panni di un manager davvero poco cool, è il perno attorno al quale ruota tutta la vicenda. La ADM (Archer Daniels Midland) è un'azienda agroalimentare che si occupa della produzione di un derivato del mais. Nel corso degli anni l'ADM, in combutta con altre aziende concorrenti del medesimo settore, imbastisce un sistema di accordi fraudolenti atti a scavalcare le regole del libero mercato andando a creare una manipolazione del prezzo del prodotto ai danni del consumatore finale. Il manager Mark Withacre (Matt Damon), in disaccordo col sistema illegale sviluppato dalle aziende del settore, decide di denunciarne gli illeciti all'F.B.I. iniziando a collaborare con l'agente Brian Shepard (Scott Bakula). Whitacre diventa così una sorta di informatore/agente segreto capace di donare un tocco quasi demenziale ai compiti assegnatigli dall'F.B.I. (impagabile la sequenza con il registratore nascosto nella 24 ore), a questo si unisce una serie di bugie e di mezze verità che l'informatore, man mano che la storia si dipana, non sembra in grado di poter gestire, fino ad arrivare a un crescendo incontrollato che porterà a un ribaltamento di prospettiva.
Soderbergh affronta questa volta la materia in maniera scanzonata e difficile da inquadrare (sarà una storia vera? Boh!), durante la visione del film ci si trova a chiedersi se un'informazione sia vera oppure no, se i personaggi siano attendibili, se qualcuno sia corrotto, se qualcuno sia invece semplicemente scemo o se gli scemi siamo noi. Oppure, forse, gli scemi sono quelli dell'F.B.I., tutto è possibile in un film che parte come una storia di denuncia e finisce in una farsa giocosa. Matt Damon è un ottimo agente 0014, bravo il doppio di 007 o semplicemente doppiogiochista? Indovinata anche la scelta di Soderbergh di aderire a un'estetica che richiama moltissimo gli anni a cavallo tra i 60 e i 70 mentre la vicenda è dichiaratamente ambientata negli anni 90, opzione fuori fase che contribuisce bene ad alimentare lo straniamento e la confusione dell'intera vicenda.
Alla fine a cosa abbiamo assistito? A una commedia? A un film d'inchiesta? A una farsa? A un inganno? Non importa, Soderbergh è stato bravo a condurci un po' di qua, un po' di la, dietro le strambe mattane di Whitacre, un folle... un ambizioso... un truffatore. Un ottimo agente in incognito. O forse no?
Ridendo e scherzando anche a Steven Soderbergh manca un solo lustro per toccare i sessant'anni, non si direbbe per un regista che da sempre continua a dare l'idea del giovanotto in eterno movimento, quasi schizofrenico e colpito a tratti da urgenze creative tra le più disparate. Più o meno una trentina di film all'attivo in altrettanti anni di carriera, diverse dichiarazioni di ritiro dalle scene (tutte smentite), e poi ancora produzione, montaggio, serie tv, corti, sceneggiature, film girati con il cellulare, e chissà cos'altro. Nel palmares un Oscar alla regia per Traffic e una Palma d'oro per Sesso, bugie e videotapes. Tra i vari interessi del regista c'è anche quello per un certo tipo di Cinema che si avvicina, magari solo lateralmente, a quello d'indagine e di denuncia: lo stesso Traffic sfiorava argomenti delicati pur rimanendo nella finzione, Erin Brockovich rientra invece appieno nel genere e in qualche modo, sicuramente molto meno serioso, ci si affaccia anche questo The informant!
Il grosso del lavoro per la buona riuscita di questo film lo si deve a un ottimo Matt Damon: un po' imbolsito, faccia quasi da ebete, calato nei panni di un manager davvero poco cool, è il perno attorno al quale ruota tutta la vicenda. La ADM (Archer Daniels Midland) è un'azienda agroalimentare che si occupa della produzione di un derivato del mais. Nel corso degli anni l'ADM, in combutta con altre aziende concorrenti del medesimo settore, imbastisce un sistema di accordi fraudolenti atti a scavalcare le regole del libero mercato andando a creare una manipolazione del prezzo del prodotto ai danni del consumatore finale. Il manager Mark Withacre (Matt Damon), in disaccordo col sistema illegale sviluppato dalle aziende del settore, decide di denunciarne gli illeciti all'F.B.I. iniziando a collaborare con l'agente Brian Shepard (Scott Bakula). Whitacre diventa così una sorta di informatore/agente segreto capace di donare un tocco quasi demenziale ai compiti assegnatigli dall'F.B.I. (impagabile la sequenza con il registratore nascosto nella 24 ore), a questo si unisce una serie di bugie e di mezze verità che l'informatore, man mano che la storia si dipana, non sembra in grado di poter gestire, fino ad arrivare a un crescendo incontrollato che porterà a un ribaltamento di prospettiva.
Soderbergh affronta questa volta la materia in maniera scanzonata e difficile da inquadrare (sarà una storia vera? Boh!), durante la visione del film ci si trova a chiedersi se un'informazione sia vera oppure no, se i personaggi siano attendibili, se qualcuno sia corrotto, se qualcuno sia invece semplicemente scemo o se gli scemi siamo noi. Oppure, forse, gli scemi sono quelli dell'F.B.I., tutto è possibile in un film che parte come una storia di denuncia e finisce in una farsa giocosa. Matt Damon è un ottimo agente 0014, bravo il doppio di 007 o semplicemente doppiogiochista? Indovinata anche la scelta di Soderbergh di aderire a un'estetica che richiama moltissimo gli anni a cavallo tra i 60 e i 70 mentre la vicenda è dichiaratamente ambientata negli anni 90, opzione fuori fase che contribuisce bene ad alimentare lo straniamento e la confusione dell'intera vicenda.
Alla fine a cosa abbiamo assistito? A una commedia? A un film d'inchiesta? A una farsa? A un inganno? Non importa, Soderbergh è stato bravo a condurci un po' di qua, un po' di la, dietro le strambe mattane di Whitacre, un folle... un ambizioso... un truffatore. Un ottimo agente in incognito. O forse no?
mercoledì 21 novembre 2018
I MILLE VOLTI DEL TERRORE
(The year's best horror stories. Series VI; AA.VV., 1978)
I mille volti del terrore è una compilazione a cura di Gerald W. Page che raccoglie alcuni di quelli che dovrebbero essere stati i migliori racconti a tema horror pubblicati su riviste varie nel 1978 (o poco prima). Come in tutte le antologie la qualità degli scritti proposti risulta inevitabilmente altalenante così come anche la definizione di racconto horror va presa con le molle, gli sconfinamenti e le commistioni con altri generi letterari non mancano, fermo restando quella base di brivido che la tematica affrontata richiede. Siamo di fronte a una serie di opere tutte più o meno brevi concepite dai rispettivi autori sul finire degli anni 70, alcune narrazioni risentono del passare del tempo restituendo al lettore quella sensazione di polveroso non necessariamente spiacevole, altre invece hanno una freschezza ancora invidiabile, una su tutte il racconto I figli del grano di Stephen King, autore di punta di questa antologia e di tutto il genere horror moderno il cui nome campeggia al centro della copertina del libro. A questo punto mi tocca ammettere la mia ignoranza e la mia scarsa dimestichezza col genere in quanto i nomi degli altri autori coinvolti nel progetto sono a me per lo più ignoti.
Vediamo con una rapida carrellata cosa contiene questo libro. Si parte con il racconto In fondo al giardino (At the bottom of the garden, 1976) di David Compton nel quale, in uno scenario familiare e domestico, la figlia della distratta signora Williams gioca con la sua amichetta nel giardino di casa. La bimba poi racconta delle cose ai suoi genitori che però non la ascoltano con la dovuta attenzione, le strane fantasie della bimba risulteranno invece avere ben più d'un fondamento. Un buon inizio, breve ma inquieto al punto giusto, l'attacco dell'antologia lascia ben sperare. Meno interessante l'incontro tra il protagonista della seconda storia, Urlando per uscire (Screaming to get out, 1977), con una poco attraente cameriera di un drive-in, incontro che terminerà con una sorpresa inaspettata. Anche qui pochissime pagine a opera di Janet Fox che oggi però sanno molto di già visto (c'è da dire anche che io arrivo alla lettura di questo libro con un ritardo di circa quarant'anni). Segue il primo racconto un po' più corposo, Kane il maledetto (Undertow, 1978) che purtroppo sconfina nel fantasy, genere che non amo particolarmente. La costruzione del racconto non è male, non nelle mie corde ma agli appassionati potrebbe piacere, inoltre sia il protagonista Kane, sia l'autore Karl Edward Wagner sembrano godere di ottimo credito tra i fan del fantasy a la Conan il barbaro. Io sento il buio (I can hear the dark, 1978) di Dennis Etchison richiede un minimo di concentrazione in più rispetto al solito nonostante la durata molto breve ma in fin dei conti si rivela un episodio tutto sommato trascurabile, non così è per La custode (Ever the faith endures, 1978), ottimo racconto molto vicino per atmosfere agli scritti di Lovecraft e al terrore suscitato da presenze mostruose come I Grandi antichi, l'autore Manly Wade Wellman è un prolifico ed eclettico scrittore che ha spaziato in carriera tra numerosi generi sfiorando anche il Pulitzer con uno dei suoi romanzi storici. Non male I signori dei cavalli (The horse lords, 1977) di Lisa Tuttle che presenta più di un punto di contatto con il ben più famoso Pet sematary (comunque successivo) di King. Con Bianco inverno (Winter white, 1978) di Tanith Lee si torna alle contaminazioni storico/heroic fantasy e il mio interesse torna a calare, anche qui però il racconto non è affatto malvagio. Dal sapore antico, ottocentesco, Una ragnatela di vene pulsanti (A cobweb of pulsing veins, 1977) che vede per protagonista un profanatore di tombe su commissione che accidentalmente recupera una bara che avrebbe dovuto lasciare al suo posto, ottimo stile e ottime atmosfere a opera di William Scott Home. Di scarso interesse anche Un colpo di fortuna (Hollow face, merciless moon, best of luck, 1978) di David Drake ambientato in uno scenario di guerra; finalmente arriva I figli del grano (Children of the corn, 1977) di Stephen King. L'autore di Bangor (ma nato a Portland) dimostra qui in maniera indiretta come la sua fama sia del tutto meritata, il suo racconto ha un altro passo rispetto ai contenuti presenti nel resto del libro, la scrittura di King sembra arrivare da un secolo più moderno, più vivo e vivido, a distanza di quarant'anni il racconto non perde una stilla di freschezza. Torna il tema dell'adolescenza qui protagonista in una comunità ormai morta e composta di soli ragazzini, una comunità che si rivelerà parecchio pericolosa per i viaggiatori Burt e Vicky. Forse grazie all'impulso dello scrittore del Maine il resto del libro sembra avere un piglio più moderno, Se arriva Damon (If Damon comes, 1978) porta in scena uno di quei bambini inquietanti che tante volte abbiamo avuto modo di vedere al Cinema, racconto di Charles L. Grant; de L'adescamento (Drawing in, 1978) di Ramsey Campbell ho già smarrito il ricordo, cattivo segno; parecchio interessante invece il dittico finale. Ricordo di un amore (Within the fall of Tyre, 1978) di Michael Bishop non presenta grandi sfumature horror ma si rivela uno dei racconti più interessanti dell'intero lotto e gode di un finale inusuale, quasi grottesco, che lascia da pensare e allo stesso tempo strappa un sorriso; bella storia di fantasmi invece la finale La lunga, lunga strada (There's a long, long trail a winding, 1977) di Russell Kirk, ottima chiusura di un libro che finisce in crescendo.
Tutto sommato I mille volti del terrore offre un buon intrattenimento, poco uniforme (può essere un bene come un male, a seconda dei gusti) ma con alcuni picchi di sicuro interesse, non c'è forse tutto quell'orrore che si vorrebbe lasciar intendere ma la lettura risulta piacevole anche se a volte ristagna nell'aria un odore di cose antiche. Magari sono cose antiche che stanno per venire a prendervi, e allora tutto si spiegherebbe!
I mille volti del terrore è una compilazione a cura di Gerald W. Page che raccoglie alcuni di quelli che dovrebbero essere stati i migliori racconti a tema horror pubblicati su riviste varie nel 1978 (o poco prima). Come in tutte le antologie la qualità degli scritti proposti risulta inevitabilmente altalenante così come anche la definizione di racconto horror va presa con le molle, gli sconfinamenti e le commistioni con altri generi letterari non mancano, fermo restando quella base di brivido che la tematica affrontata richiede. Siamo di fronte a una serie di opere tutte più o meno brevi concepite dai rispettivi autori sul finire degli anni 70, alcune narrazioni risentono del passare del tempo restituendo al lettore quella sensazione di polveroso non necessariamente spiacevole, altre invece hanno una freschezza ancora invidiabile, una su tutte il racconto I figli del grano di Stephen King, autore di punta di questa antologia e di tutto il genere horror moderno il cui nome campeggia al centro della copertina del libro. A questo punto mi tocca ammettere la mia ignoranza e la mia scarsa dimestichezza col genere in quanto i nomi degli altri autori coinvolti nel progetto sono a me per lo più ignoti.
Vediamo con una rapida carrellata cosa contiene questo libro. Si parte con il racconto In fondo al giardino (At the bottom of the garden, 1976) di David Compton nel quale, in uno scenario familiare e domestico, la figlia della distratta signora Williams gioca con la sua amichetta nel giardino di casa. La bimba poi racconta delle cose ai suoi genitori che però non la ascoltano con la dovuta attenzione, le strane fantasie della bimba risulteranno invece avere ben più d'un fondamento. Un buon inizio, breve ma inquieto al punto giusto, l'attacco dell'antologia lascia ben sperare. Meno interessante l'incontro tra il protagonista della seconda storia, Urlando per uscire (Screaming to get out, 1977), con una poco attraente cameriera di un drive-in, incontro che terminerà con una sorpresa inaspettata. Anche qui pochissime pagine a opera di Janet Fox che oggi però sanno molto di già visto (c'è da dire anche che io arrivo alla lettura di questo libro con un ritardo di circa quarant'anni). Segue il primo racconto un po' più corposo, Kane il maledetto (Undertow, 1978) che purtroppo sconfina nel fantasy, genere che non amo particolarmente. La costruzione del racconto non è male, non nelle mie corde ma agli appassionati potrebbe piacere, inoltre sia il protagonista Kane, sia l'autore Karl Edward Wagner sembrano godere di ottimo credito tra i fan del fantasy a la Conan il barbaro. Io sento il buio (I can hear the dark, 1978) di Dennis Etchison richiede un minimo di concentrazione in più rispetto al solito nonostante la durata molto breve ma in fin dei conti si rivela un episodio tutto sommato trascurabile, non così è per La custode (Ever the faith endures, 1978), ottimo racconto molto vicino per atmosfere agli scritti di Lovecraft e al terrore suscitato da presenze mostruose come I Grandi antichi, l'autore Manly Wade Wellman è un prolifico ed eclettico scrittore che ha spaziato in carriera tra numerosi generi sfiorando anche il Pulitzer con uno dei suoi romanzi storici. Non male I signori dei cavalli (The horse lords, 1977) di Lisa Tuttle che presenta più di un punto di contatto con il ben più famoso Pet sematary (comunque successivo) di King. Con Bianco inverno (Winter white, 1978) di Tanith Lee si torna alle contaminazioni storico/heroic fantasy e il mio interesse torna a calare, anche qui però il racconto non è affatto malvagio. Dal sapore antico, ottocentesco, Una ragnatela di vene pulsanti (A cobweb of pulsing veins, 1977) che vede per protagonista un profanatore di tombe su commissione che accidentalmente recupera una bara che avrebbe dovuto lasciare al suo posto, ottimo stile e ottime atmosfere a opera di William Scott Home. Di scarso interesse anche Un colpo di fortuna (Hollow face, merciless moon, best of luck, 1978) di David Drake ambientato in uno scenario di guerra; finalmente arriva I figli del grano (Children of the corn, 1977) di Stephen King. L'autore di Bangor (ma nato a Portland) dimostra qui in maniera indiretta come la sua fama sia del tutto meritata, il suo racconto ha un altro passo rispetto ai contenuti presenti nel resto del libro, la scrittura di King sembra arrivare da un secolo più moderno, più vivo e vivido, a distanza di quarant'anni il racconto non perde una stilla di freschezza. Torna il tema dell'adolescenza qui protagonista in una comunità ormai morta e composta di soli ragazzini, una comunità che si rivelerà parecchio pericolosa per i viaggiatori Burt e Vicky. Forse grazie all'impulso dello scrittore del Maine il resto del libro sembra avere un piglio più moderno, Se arriva Damon (If Damon comes, 1978) porta in scena uno di quei bambini inquietanti che tante volte abbiamo avuto modo di vedere al Cinema, racconto di Charles L. Grant; de L'adescamento (Drawing in, 1978) di Ramsey Campbell ho già smarrito il ricordo, cattivo segno; parecchio interessante invece il dittico finale. Ricordo di un amore (Within the fall of Tyre, 1978) di Michael Bishop non presenta grandi sfumature horror ma si rivela uno dei racconti più interessanti dell'intero lotto e gode di un finale inusuale, quasi grottesco, che lascia da pensare e allo stesso tempo strappa un sorriso; bella storia di fantasmi invece la finale La lunga, lunga strada (There's a long, long trail a winding, 1977) di Russell Kirk, ottima chiusura di un libro che finisce in crescendo.
Tutto sommato I mille volti del terrore offre un buon intrattenimento, poco uniforme (può essere un bene come un male, a seconda dei gusti) ma con alcuni picchi di sicuro interesse, non c'è forse tutto quell'orrore che si vorrebbe lasciar intendere ma la lettura risulta piacevole anche se a volte ristagna nell'aria un odore di cose antiche. Magari sono cose antiche che stanno per venire a prendervi, e allora tutto si spiegherebbe!
Iscriviti a:
Post (Atom)