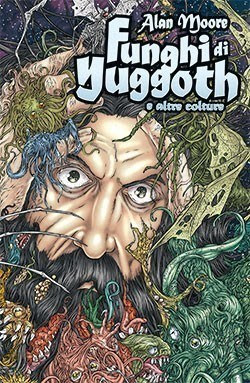(di Alfredo Castelli e Franco Bignotti)
Nei numeri tredici e quattordici della serie dedicata a Martin Mystère, (Un vampiro a New York e La maledizione) si accantonano temporaneamente i grandi enigmi della storia per dedicarsi a una delle figure principe della letteratura e del cinema gotico e horror: parliamo ovviamente del vampiro.
Dopo una sorta di spiegazione scientifica del fenomeno del vampirismo, legata ai sintomi della malattia della rabbia, è l'ispettore Travis a farla da padrone nella prima parte della storia. Dopo essersi consultato con l'amico Martin proprio sull'argomento vampiri, genere di cose che solitamente esulano dal campo d'interesse del concreto poliziotto, Travis torna a occuparsi dell'indagine che sta riempiendo le sue giornate, quella su un assassino seriale ribattezzato l'assassino del pugnale. Però l'interesse quasi maniacale di Travis per la figura del vampiro fa nascere più di un sospetto all'interno del piccolo gruppo composto da Martin, Java e Diana.
La figura del vampiro viene qui descritta da Castelli in maniera più umana e scientifica rispetto a quanto siamo abituati a vedere a proposito di questo tema, crisi d'astinenza, impulsi incontrollabili completamente slegati da qualsivoglia moto di malvagità e sopraffazione, a parte l'argomento trattato la costruzione di questo dittico di storie è abbastanza canonico, rientra nel genere del racconto d'investigazione con alcune immancabili sequenze d'azione, come affermato dallo stesso Castelli nei redazionali dell'albo, vengono accantonate per un paio di mesi quelle che sono le caratteristiche fondanti della serie di Martin Mystère per avvicinarsi un po' di più ad atmosfere che, seppur ripulite, sembrerebbero più adatte al collega Dylan Dog.
Onestamente una coppia d'albi tra i meno interessanti prodotti fino a questo punto per la serie, privi di spunti di interesse realmente degni di nota, anche il lavoro di Bignotti si assesta in una medietà poco entusiasmante, personalmente non amo in modo particolare le tavole di questo disegnatore che, seppur spesso abbastanza adeguate, non colpiscono il mio interesse né lasciano il segno. C'è poco da aggiungere per questa sortita nel mondo del detective dell'impossibile, ancora una volta non si può fare a meno di notare come alcune cose del buon vecchio zio Marty siano implacabilmente invecchiate con il passare degli anni.
sabato 30 settembre 2017
giovedì 28 settembre 2017
LE CRONACHE DEI MORTI VIVENTI
(Diary of the dead di George A. Romero, 2007)
Come spesso è accaduto per i film a tema zombi di George A. Romero, anche questo Diary of the dead è un film teorico, corredato da una tesi e un messaggio, ed è proprio grazie a Romero se la figura dello zombi, oltre alla sua carica orrorifica, si porta spesso dietro un significato metaforico, se non sempre nella figura del non-morto vero e proprio, almeno nel contesto, negli uomini e nella società che gli girano intorno (vedi anche The walking dead giusto per citare l'esempio ai giorni nostri più celebre). Come dicevamo, Diary of the dead non fa eccezione. Questa volta il focus è centrato sull'informazione, vista e declinata in numerosi dei suoi aspetti, per alcuni versi anche storici, ma soprattutto attualissimi e adesi a quello che è il mondo odierno in cui siamo chiamati a sopravvivere ogni giorno.
L'incipit è quello della classica epidemia zombi, non si sa perché, non si sa come, il mondo impazzisce e i morti si rifiutano di accettare la loro condizione, tornano scatenando il panico e diffondendo il contagio a suon di morsi dispensati con grande generosità. Le prime avvisaglie del fenomeno arrivano dai servizi televisivi, ed è così che il gruppo di ragazzi protagonisti del film vengono a sapere della nuova situazione che si sta andando a creare. Da subito l'informazione risulta però veicolata, parziale o mistificata, così Jason (Joshua Close), studente di cinema, decide di riprendere tutti gli avvenimenti che il suo gruppo di amici si troverà ad affrontare nei giorni seguenti lungo il viaggio che intraprenderanno per ritornare verso la casa natale di Debra (Michelle Morgan), ragazza dello stesso Jason, al fine di caricare poi su internet una versione veritiera dei fatti.
Il film si regge proprio sul tema dell'immagine e dell'informazione, da subito scopriamo che il girato di Jason, prima di arrivare al pubblico, sarà montato e manomesso dalla stessa Debra con lo scopo di rendere il materiale più attraente e spaventoso, ulteriore alterazione della verità. Splendido il titolo scelto dalla ragazza per presentare il materiale: Death of death - La morte della morte. Per il resto Romero costruisce il film usando tutto lo scibile dell'audiovisivo: telecamere a mano, professionali o meno, immagini televisive, frame da telecamere di videosorveglianza, video registrati da cellulari, immagini da internet e quant'altro ancora.
Oltre alla pervasività dell'immagine e alla sua possibilità di venire volutamente alterata soprattutto in ottica di controllo dell'informazione, si riflette anche su altri due temi di altrettanta importanza: la possibilità che un sovraccarico da informazione come quello a cui tutti siamo sottoposti ogni giorno possa creare una vera incapacità di discernere e quindi occultare (anche volutamente) quelle che sono le verità, e, forse a livello emotivo cosa ancor più spaventosa, la distruzione continua dell'empatia e la creazione di un'abitudine sempre più priva di compassione nel percepire attraverso l'immagine e l'informazione anche gli eventi più crudeli, terribili e dolorosi che il mondo ci sottopone. Sempre più confusi, disinformati e anestetizzati a tutto. Un film teorico come si diceva, con teorie non da poco.
Archiviata la tesi, devo ammettere di aver trovato il film più interessante che bello. Dal punto di vista prettamente horror, dello spavento, non ci ho visto niente di così riuscito o innovativo (a parte la sequenza con l'amish muto e un paio d'altre cosette), tutto è creato in maniera diligente e professionale, nulla da dire, ma la storia in se non ha suscitato in me particolari emozioni. In più l'utilizzo continuo della camera a mano, avendo visto il film su uno schermo abbastanza grande, mi ha creato non poco fastidio, ottima scelta per ricreare al meglio il senso di realtà ma anche quello di lieve nausea. Ad ogni modo Romero non tradisce, con profonda umiltà dedico a lui questo post a pochi mesi dalla sua scomparsa, augurandogli di cuore di non dover ritornare.
Come spesso è accaduto per i film a tema zombi di George A. Romero, anche questo Diary of the dead è un film teorico, corredato da una tesi e un messaggio, ed è proprio grazie a Romero se la figura dello zombi, oltre alla sua carica orrorifica, si porta spesso dietro un significato metaforico, se non sempre nella figura del non-morto vero e proprio, almeno nel contesto, negli uomini e nella società che gli girano intorno (vedi anche The walking dead giusto per citare l'esempio ai giorni nostri più celebre). Come dicevamo, Diary of the dead non fa eccezione. Questa volta il focus è centrato sull'informazione, vista e declinata in numerosi dei suoi aspetti, per alcuni versi anche storici, ma soprattutto attualissimi e adesi a quello che è il mondo odierno in cui siamo chiamati a sopravvivere ogni giorno.
L'incipit è quello della classica epidemia zombi, non si sa perché, non si sa come, il mondo impazzisce e i morti si rifiutano di accettare la loro condizione, tornano scatenando il panico e diffondendo il contagio a suon di morsi dispensati con grande generosità. Le prime avvisaglie del fenomeno arrivano dai servizi televisivi, ed è così che il gruppo di ragazzi protagonisti del film vengono a sapere della nuova situazione che si sta andando a creare. Da subito l'informazione risulta però veicolata, parziale o mistificata, così Jason (Joshua Close), studente di cinema, decide di riprendere tutti gli avvenimenti che il suo gruppo di amici si troverà ad affrontare nei giorni seguenti lungo il viaggio che intraprenderanno per ritornare verso la casa natale di Debra (Michelle Morgan), ragazza dello stesso Jason, al fine di caricare poi su internet una versione veritiera dei fatti.
Il film si regge proprio sul tema dell'immagine e dell'informazione, da subito scopriamo che il girato di Jason, prima di arrivare al pubblico, sarà montato e manomesso dalla stessa Debra con lo scopo di rendere il materiale più attraente e spaventoso, ulteriore alterazione della verità. Splendido il titolo scelto dalla ragazza per presentare il materiale: Death of death - La morte della morte. Per il resto Romero costruisce il film usando tutto lo scibile dell'audiovisivo: telecamere a mano, professionali o meno, immagini televisive, frame da telecamere di videosorveglianza, video registrati da cellulari, immagini da internet e quant'altro ancora.
Oltre alla pervasività dell'immagine e alla sua possibilità di venire volutamente alterata soprattutto in ottica di controllo dell'informazione, si riflette anche su altri due temi di altrettanta importanza: la possibilità che un sovraccarico da informazione come quello a cui tutti siamo sottoposti ogni giorno possa creare una vera incapacità di discernere e quindi occultare (anche volutamente) quelle che sono le verità, e, forse a livello emotivo cosa ancor più spaventosa, la distruzione continua dell'empatia e la creazione di un'abitudine sempre più priva di compassione nel percepire attraverso l'immagine e l'informazione anche gli eventi più crudeli, terribili e dolorosi che il mondo ci sottopone. Sempre più confusi, disinformati e anestetizzati a tutto. Un film teorico come si diceva, con teorie non da poco.
Archiviata la tesi, devo ammettere di aver trovato il film più interessante che bello. Dal punto di vista prettamente horror, dello spavento, non ci ho visto niente di così riuscito o innovativo (a parte la sequenza con l'amish muto e un paio d'altre cosette), tutto è creato in maniera diligente e professionale, nulla da dire, ma la storia in se non ha suscitato in me particolari emozioni. In più l'utilizzo continuo della camera a mano, avendo visto il film su uno schermo abbastanza grande, mi ha creato non poco fastidio, ottima scelta per ricreare al meglio il senso di realtà ma anche quello di lieve nausea. Ad ogni modo Romero non tradisce, con profonda umiltà dedico a lui questo post a pochi mesi dalla sua scomparsa, augurandogli di cuore di non dover ritornare.
Etichette:
cinema,
film,
George A. Romero,
horror
mercoledì 27 settembre 2017
BRADI PIT 153
Bradi Pit e il genere action.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
lunedì 25 settembre 2017
LETTERE DA IWO JIMA
(Letters from Iwo Jima di Clint Eastwood, 2006)
Seconda parte del dittico realizzato da Clint Eastwood sulla battaglia di Iwo Jima, episodio chiave della guerra del Pacifico e cruenta battaglia disputatasi tra marines americani e soldati dell'esercito imperiale giapponese. Se nel film precedente, Flags of our fathers, il regista ci mostrava il punto di vista statunitense sull'episodio storico, mettendo al centro della narrazione la conquista simbolica dell'isola tramite la posa della bandiera a stelle e strisce, qui abbiamo il suo contraltare grazie al punto di vista giapponese dell'intera vicenda, durante la quale mai si parla dell'episodio al centro di Flags of our fathers, episodio ovviamente ininfluente per i soldati giapponesi di stanza a Iwo Jima e che qui intravediamo di sfuggita giusto in un paio di frame. La scelta intelligente di Eastwood è stata quella di girare due film che trattano la stessa materia ma non speculari, trovata che ha evitato un potenziale calo di interesse nella visione della seconda pellicola, calo che fortunatamente non si avverte mai lungo l'intera durata del film.
Preferendo un tono più umano e intimista, Lettere da Iwo Jima si rivela tra i due l'episodio più riuscito, Eastwood con una sensibilità illuminata riesce a calarsi nei panni dell'avversario e giustamente lo dipinge esattamente come fosse uno dei ragazzi americani mandati dal proprio Paese alla guerra, un nemico con cultura e abitudini diverse ma con le stesse identiche paure, le stesse preoccupazioni, le stesse priorità, gli stessi desideri e i medesimi affetti. Semplicemente uomini, spesso ragazzi, da ambo le parti.
Quello che forse differenzia maggiormente i due film è il senso di morte incombente e di sconfitta inevitabile che pervade i protagonisti di Lettere da Iwo Jima, abbandonati dal loro Paese che chiede ormai loro solamente di resistere e morire per il Giappone, soverchiati dall'apparato bellico americano infinitamente più potente e numeroso. La difesa della patria sarà comunque strenua, nonostante non tutti i protagonisti messi in campo provino il senso d'onore tipico dei giapponesi ne una gran voglia di immolarsi per il proprio paese, idea troppo volatile, finanche stupida per certi versi, se paragonata alla possibilità di tornare dai propri cari o a quella di vedere per la prima volta un figlio non ancora nato.
Anche nei singoli episodi presenti nel film, Eastwood sottolinea come ci sia crudeltà da ambo le parti così come qualsiasi schieramento sia capace di solidarietà e pietà, può sembrare banale ma il messaggio veicolato dal film, "il nemico è come noi", ha valenza assoluta, messaggio che purtroppo perde voce di fronte agli interessi che muovono le guerre e i loro orrori.
Molto riuscito visivamente, con una fotografia quasi monocromatica e sequenze dinamiche davvero impressionanti, ottima quella dedicata al primo attacco americano all'isola. Alcuni passaggi riportano alla mente segmenti di Flags of our fathers, come è giusto che sia, anche se il focus rimane sempre rivolto all'interno dell'uomo più che a ciò che gli accade intorno.
In definitiva i due film, presi nel loro insieme, non sono comunque il lavoro migliore di un regista che ha sfornato diversi capolavori, rimangono però un bello spaccato di ciò che può voler dire dover affrontare drammi più grandi dell'uomo stesso, magari anche inutilmente, è un tipo di Cinema che si spera possa lasciare il segno sulle generazioni a venire, perché alla fine il vecchio detto "non bisogna dimenticare" rimane comunque sempre valido.
Seconda parte del dittico realizzato da Clint Eastwood sulla battaglia di Iwo Jima, episodio chiave della guerra del Pacifico e cruenta battaglia disputatasi tra marines americani e soldati dell'esercito imperiale giapponese. Se nel film precedente, Flags of our fathers, il regista ci mostrava il punto di vista statunitense sull'episodio storico, mettendo al centro della narrazione la conquista simbolica dell'isola tramite la posa della bandiera a stelle e strisce, qui abbiamo il suo contraltare grazie al punto di vista giapponese dell'intera vicenda, durante la quale mai si parla dell'episodio al centro di Flags of our fathers, episodio ovviamente ininfluente per i soldati giapponesi di stanza a Iwo Jima e che qui intravediamo di sfuggita giusto in un paio di frame. La scelta intelligente di Eastwood è stata quella di girare due film che trattano la stessa materia ma non speculari, trovata che ha evitato un potenziale calo di interesse nella visione della seconda pellicola, calo che fortunatamente non si avverte mai lungo l'intera durata del film.
Preferendo un tono più umano e intimista, Lettere da Iwo Jima si rivela tra i due l'episodio più riuscito, Eastwood con una sensibilità illuminata riesce a calarsi nei panni dell'avversario e giustamente lo dipinge esattamente come fosse uno dei ragazzi americani mandati dal proprio Paese alla guerra, un nemico con cultura e abitudini diverse ma con le stesse identiche paure, le stesse preoccupazioni, le stesse priorità, gli stessi desideri e i medesimi affetti. Semplicemente uomini, spesso ragazzi, da ambo le parti.
Quello che forse differenzia maggiormente i due film è il senso di morte incombente e di sconfitta inevitabile che pervade i protagonisti di Lettere da Iwo Jima, abbandonati dal loro Paese che chiede ormai loro solamente di resistere e morire per il Giappone, soverchiati dall'apparato bellico americano infinitamente più potente e numeroso. La difesa della patria sarà comunque strenua, nonostante non tutti i protagonisti messi in campo provino il senso d'onore tipico dei giapponesi ne una gran voglia di immolarsi per il proprio paese, idea troppo volatile, finanche stupida per certi versi, se paragonata alla possibilità di tornare dai propri cari o a quella di vedere per la prima volta un figlio non ancora nato.
Anche nei singoli episodi presenti nel film, Eastwood sottolinea come ci sia crudeltà da ambo le parti così come qualsiasi schieramento sia capace di solidarietà e pietà, può sembrare banale ma il messaggio veicolato dal film, "il nemico è come noi", ha valenza assoluta, messaggio che purtroppo perde voce di fronte agli interessi che muovono le guerre e i loro orrori.
Molto riuscito visivamente, con una fotografia quasi monocromatica e sequenze dinamiche davvero impressionanti, ottima quella dedicata al primo attacco americano all'isola. Alcuni passaggi riportano alla mente segmenti di Flags of our fathers, come è giusto che sia, anche se il focus rimane sempre rivolto all'interno dell'uomo più che a ciò che gli accade intorno.
In definitiva i due film, presi nel loro insieme, non sono comunque il lavoro migliore di un regista che ha sfornato diversi capolavori, rimangono però un bello spaccato di ciò che può voler dire dover affrontare drammi più grandi dell'uomo stesso, magari anche inutilmente, è un tipo di Cinema che si spera possa lasciare il segno sulle generazioni a venire, perché alla fine il vecchio detto "non bisogna dimenticare" rimane comunque sempre valido.
domenica 24 settembre 2017
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
(The sound of music di Robert Wise, 1965)
A volte l'incontro di più caratteristiche, in maniera del tutto olistica e per alcuni versi difficilmente comprensibile, si rivela più riuscito della somma delle singole parti. È quel che è indubbiamente successo al film Tutti insieme appassionatamente, pellicola della Hollywood dei 60 capace di creare introiti per più di duecentottantacinque milioni di dollari a fronte di una spesa di circa otto, una scommessa vincente che ha pagato più di trentacinque volte la posta, e parliamo di cifre da capogiro. Eppure i singoli elementi in ballo sono di quelli che a molti fanno storcere il naso: il genere musicale, un approccio familista, la fiera dei buoni sentimenti, lo scenario storico in periodo seconda guerra mondiale con tanto di minaccia nazista, la storia d'amore, paesaggi da cartolina (splendidi), l'empatia chiesta allo spettatore puntando sulla tenerezza suscitata da ragazzi e bambini protagonisti del film e un'interprete di grido, Julie Andrews, fresca reduce dal successo di Mary Poppins.
Proprio quest'ultima è indubbiamente la chiave del successo di un film che con un'altra protagonista avrebbe rischiato la caduta verso l'abisso della noia, i numeri musicali nei quali è presente la Andrews sono sempre godibili e giustificano la visione di un film onestamente troppo lungo e che andrebbe visto in lingua originale. Quasi tutti i passaggi musicali dove non compare Maria (Julie Andrews) sembrano superflui, con ogni probabilità non aiuta la scelta di doppiare tutti i pezzi in italiano, magari in versione sottotitolata con brani originali si sarebbe potuto apprezzare qualcosa in più, non avendo avuto modo di vedere il film in lingua però non garantisco nulla. Sconsigliata invece la visione televisiva per un film che interrotto anche dalla pubblicità raggiunge tempi di visione sfiancanti.
Alla regia Robert Wise, nome oggi poco conosciuto se non tra le fila dei cinefili appassionati, professionista duttile che ha lasciato buoni segni in diversi ambiti: nella fantascienza (Ultimatum alla Terra), nello stesso musical (West Side Story) e anche nel mondo geek in quanto direttore del primo film cinematografico della saga di Star Trek.
Maria è una novizia devota ma dal temperamento un po' esuberante, le sue superiori nel convento di Salisburgo hanno opinioni diverse sul suo conto, non tutte sono convinte che la strada giusta per la giovane sia quella di entrare nell'ordine. Per metterla alla prova la mandano presso la famiglia Von Trapp in qualità di istitutrice dei sette figli del Comandante Von Trapp (Christopher Plummer). L'approccio è quello risaputo: bambini che fino ad allora avevano avuto problemi con qualsiasi istitutrice in seguito alla scomparsa della madre, un padre anaffettivo col pallino della disciplina, il nuovo arrivo che entrerà nel cuore dei bimbi e farà innamorare di sé il protagonista maschile, il terzo incomodo (la baronessa Elsa interpretata da Eleanor Parker), la minaccia incombente qui rappresentata dal nazismo. Tutto segue lo schema, spezzato dai numeri musicali e dal fatto che qui l'istitutrice sarebbe una futura suora che oltre che con il suo cuore deve fare i conti anche col Padreterno.
Film musicale perfetto per ripetuti passaggi natalizi (cosa che effettivamente accade) e che risulterebbe inappuntabile se sforbiciato di una buona mezz'ora almeno, poi a mio parere il musical è Gene Kelly e qui siamo un poco distanti proprio nell'approccio alla materia, ma questo è un altro discorso, ciò non toglie che per molti versi il film possa risultare ben più che piacevole, lo sta a dimostrare anche l'enorme successo riscosso dalla pellicola e le diverse statuette portate a casa da Tutti insieme appassionatamente alla notte degli Oscar, premio per il miglior film compreso. Visione spensierata che almeno una volta nella vita... magari proprio a Natale.
A volte l'incontro di più caratteristiche, in maniera del tutto olistica e per alcuni versi difficilmente comprensibile, si rivela più riuscito della somma delle singole parti. È quel che è indubbiamente successo al film Tutti insieme appassionatamente, pellicola della Hollywood dei 60 capace di creare introiti per più di duecentottantacinque milioni di dollari a fronte di una spesa di circa otto, una scommessa vincente che ha pagato più di trentacinque volte la posta, e parliamo di cifre da capogiro. Eppure i singoli elementi in ballo sono di quelli che a molti fanno storcere il naso: il genere musicale, un approccio familista, la fiera dei buoni sentimenti, lo scenario storico in periodo seconda guerra mondiale con tanto di minaccia nazista, la storia d'amore, paesaggi da cartolina (splendidi), l'empatia chiesta allo spettatore puntando sulla tenerezza suscitata da ragazzi e bambini protagonisti del film e un'interprete di grido, Julie Andrews, fresca reduce dal successo di Mary Poppins.
Proprio quest'ultima è indubbiamente la chiave del successo di un film che con un'altra protagonista avrebbe rischiato la caduta verso l'abisso della noia, i numeri musicali nei quali è presente la Andrews sono sempre godibili e giustificano la visione di un film onestamente troppo lungo e che andrebbe visto in lingua originale. Quasi tutti i passaggi musicali dove non compare Maria (Julie Andrews) sembrano superflui, con ogni probabilità non aiuta la scelta di doppiare tutti i pezzi in italiano, magari in versione sottotitolata con brani originali si sarebbe potuto apprezzare qualcosa in più, non avendo avuto modo di vedere il film in lingua però non garantisco nulla. Sconsigliata invece la visione televisiva per un film che interrotto anche dalla pubblicità raggiunge tempi di visione sfiancanti.
Alla regia Robert Wise, nome oggi poco conosciuto se non tra le fila dei cinefili appassionati, professionista duttile che ha lasciato buoni segni in diversi ambiti: nella fantascienza (Ultimatum alla Terra), nello stesso musical (West Side Story) e anche nel mondo geek in quanto direttore del primo film cinematografico della saga di Star Trek.
Maria è una novizia devota ma dal temperamento un po' esuberante, le sue superiori nel convento di Salisburgo hanno opinioni diverse sul suo conto, non tutte sono convinte che la strada giusta per la giovane sia quella di entrare nell'ordine. Per metterla alla prova la mandano presso la famiglia Von Trapp in qualità di istitutrice dei sette figli del Comandante Von Trapp (Christopher Plummer). L'approccio è quello risaputo: bambini che fino ad allora avevano avuto problemi con qualsiasi istitutrice in seguito alla scomparsa della madre, un padre anaffettivo col pallino della disciplina, il nuovo arrivo che entrerà nel cuore dei bimbi e farà innamorare di sé il protagonista maschile, il terzo incomodo (la baronessa Elsa interpretata da Eleanor Parker), la minaccia incombente qui rappresentata dal nazismo. Tutto segue lo schema, spezzato dai numeri musicali e dal fatto che qui l'istitutrice sarebbe una futura suora che oltre che con il suo cuore deve fare i conti anche col Padreterno.
Film musicale perfetto per ripetuti passaggi natalizi (cosa che effettivamente accade) e che risulterebbe inappuntabile se sforbiciato di una buona mezz'ora almeno, poi a mio parere il musical è Gene Kelly e qui siamo un poco distanti proprio nell'approccio alla materia, ma questo è un altro discorso, ciò non toglie che per molti versi il film possa risultare ben più che piacevole, lo sta a dimostrare anche l'enorme successo riscosso dalla pellicola e le diverse statuette portate a casa da Tutti insieme appassionatamente alla notte degli Oscar, premio per il miglior film compreso. Visione spensierata che almeno una volta nella vita... magari proprio a Natale.
Etichette:
cinema,
film,
musical,
Robert Wise
giovedì 21 settembre 2017
L'ISOLA MISTERIOSA
(di Tiziano Sclavi e Carlo Ambrosini)
Dopo l'episodio Canale 666 è ancora una volta Carlo Ambrosini a dare corpo su carta agli incubi partoriti da Tiziano Sclavi, sconfinando dai territori horror in quelli del fantastico senza rinunciare al piglio citazionista tanto caro all'ideatore della serie. L'omaggio lampante questa volta è tutto per il classico L'isola del Dottor Moreau, romanzo di H. G. Welles pubblicato nel 1896.
Anche L'isola misteriosa si rivela in fin dei conti un buon episodio, si adagia forse su espedienti abusati quali l'oggetto alieno che scombina la realtà, la sperimentazione venuta dall'alto, l'omaggio letterario, tutti elementi però ben mescolati nel noto e sempre valido calderone del fanta-horror. Probabilmente non ci sono punti d'innovazione o grandi chiavi di lettura, tornano però l'avversione per i viaggi in mare di Dylan, la bella Robin e ovviamente l'impossibile.
Dopo alcune pagine introduttive, è proprio il viaggio in mare verso l'isola di Egg a scombussolare il nostro Dylan, dopo le prime avvisaglie di anormalità quotidiana (almeno per il protagonista), un piccolo incidente porta l'indagatore direttamente dal medico della piccola isola che dopo averlo rimesso in piedi si offrirà di accompagnarlo a Moreau, luogo dove Dylan dovrà incontrare il suo nuovo cliente, un certo Lancaster. Qui Ambrosini rende al meglio il tetrissimo castello arroccato su un'altura del quale il sig. Lancaster è proprietario, sembra di essere dalle parti del Dracula di Stoker ma a tutti gli effetti, come dimostra anche il maggiordomo, si è proprio sull'isola del Dottor Moreau. Qui Dylan Dog scopre il motivo del suo ingaggio, semplicemente, vista anche la cornice del luogo, Lancaster ha pensato di assumere l'indagatore per farsi uccidere, la rivelazione dei motivi dietro questa scelta è il nodo (qui neanche troppo approfondito) sul quale il lettore può soffermarsi a elucubrare un pochino. In seguito a questa richiesta alla quale Dylan pone un secco rifiuto si scateneranno ovviamente l'incubo e l'insolito.
Ottime le matite di Ambrosini che danno qui l'impressione di essere un poco più pulite e precise del solito, ci sono atmosfere molto indovinate, una bella resa dei luoghi e soprattutto un ottimo lavoro sugli uomini animale dell'isola, volti ferini per forza di cose inusuali ma che riescono a trasmettere i tratti delle personalità dei loro possessori, e non è cosa da poco. Un bell'episodio nel quale al nostro protagonista verrà risparmiato un finale tragico, Dylan infatti non sarà costretto a tornare sulla terra ferma ancora una volta via mare.
Dopo l'episodio Canale 666 è ancora una volta Carlo Ambrosini a dare corpo su carta agli incubi partoriti da Tiziano Sclavi, sconfinando dai territori horror in quelli del fantastico senza rinunciare al piglio citazionista tanto caro all'ideatore della serie. L'omaggio lampante questa volta è tutto per il classico L'isola del Dottor Moreau, romanzo di H. G. Welles pubblicato nel 1896.
Anche L'isola misteriosa si rivela in fin dei conti un buon episodio, si adagia forse su espedienti abusati quali l'oggetto alieno che scombina la realtà, la sperimentazione venuta dall'alto, l'omaggio letterario, tutti elementi però ben mescolati nel noto e sempre valido calderone del fanta-horror. Probabilmente non ci sono punti d'innovazione o grandi chiavi di lettura, tornano però l'avversione per i viaggi in mare di Dylan, la bella Robin e ovviamente l'impossibile.
Dopo alcune pagine introduttive, è proprio il viaggio in mare verso l'isola di Egg a scombussolare il nostro Dylan, dopo le prime avvisaglie di anormalità quotidiana (almeno per il protagonista), un piccolo incidente porta l'indagatore direttamente dal medico della piccola isola che dopo averlo rimesso in piedi si offrirà di accompagnarlo a Moreau, luogo dove Dylan dovrà incontrare il suo nuovo cliente, un certo Lancaster. Qui Ambrosini rende al meglio il tetrissimo castello arroccato su un'altura del quale il sig. Lancaster è proprietario, sembra di essere dalle parti del Dracula di Stoker ma a tutti gli effetti, come dimostra anche il maggiordomo, si è proprio sull'isola del Dottor Moreau. Qui Dylan Dog scopre il motivo del suo ingaggio, semplicemente, vista anche la cornice del luogo, Lancaster ha pensato di assumere l'indagatore per farsi uccidere, la rivelazione dei motivi dietro questa scelta è il nodo (qui neanche troppo approfondito) sul quale il lettore può soffermarsi a elucubrare un pochino. In seguito a questa richiesta alla quale Dylan pone un secco rifiuto si scateneranno ovviamente l'incubo e l'insolito.
Ottime le matite di Ambrosini che danno qui l'impressione di essere un poco più pulite e precise del solito, ci sono atmosfere molto indovinate, una bella resa dei luoghi e soprattutto un ottimo lavoro sugli uomini animale dell'isola, volti ferini per forza di cose inusuali ma che riescono a trasmettere i tratti delle personalità dei loro possessori, e non è cosa da poco. Un bell'episodio nel quale al nostro protagonista verrà risparmiato un finale tragico, Dylan infatti non sarà costretto a tornare sulla terra ferma ancora una volta via mare.
mercoledì 20 settembre 2017
BRADI PIT 152
Vite vissute (?)
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
lunedì 18 settembre 2017
THE WALKING DEAD - STAGIONI 6 e 7
 |
| Negan e Lucille |
Poi si inizia a parlare di Negan (Jeffrey Dean Morgan) e pian piano il volto della serie cambia, cambiamento che prenderà corpo definitivamente nell'ultima puntata della sesta stagione. Altri personaggi si aggiungono al cast, uno su tutti l'abile Jesus (Tom Payne) proveniente dalla comunità pacifica di Hilltop governata dal pavido Gregory (Xander Berkeley), le relazioni tra i protagonisti si allargano, mutano, ci sono i morti, i feriti e i momenti di picco emotivo non mancano. L'entrata in scena dei Salvatori, il gruppo che fa capo a Negan, scatena un'escalation della violenza nella serie, nei comportamenti di molti dei protagonisti che volenti o nolenti dovranno fare i conti con il loro lato più bestiale, dinamiche che metteranno in ginocchio (letteralmente in alcuni casi) anche elementi tra i più tosti come Carol (Melissa McBride). Nell'ultima splendida puntata, la tensione sale alle stelle, Negan si presenta in persona per la prima volta e si rivela essere uno dei più grandi figli di puttana che la televisione abbia mai concepito, un bastardo talmente odioso che però non puoi fare a meno di amare per i suoi modi scanzonati, ironici e bizzarri, un grandissimo Jeffrey Dean Morgan inizia piano piano a mangiarsi il resto del cast.
Negan è croce e delizia dell'intera settima stagione, i momenti in cui è presente sono passaggi di altissimo livello, di contro le puntate in cui è assente sembrano morte o comunque secondarie, siamo di fronte a un personaggio capace di eclissare tutto il resto, cosa non sempre positiva per la scansione del ritmo imposto alla serie. La prima puntata della settima stagione è da brividi, uno dei momenti più crudeli della televisione recente, tensione e densità emotiva ai vertici della serie (e non solo), si assiste alla caduta dell'uomo in tutti i sensi: umiliazioni, sottomissione, perdita della speranza, crudeltà e dolore in uno scenario dalla quale sembra impossibile uscire, sensazioni che prendono alla stomaco e che si ripeteranno (ma non con questa intensità) più di una volta nell'economia della stagione.
Il rischio è che l'azione, Negan, la violenza, annullino quelli che sono sempre stati i reali motivi di interesse di The walking dead: l'aspetto psicologico dei personaggi e la metafora sui comportamenti umani e sulla società. Non si può però negare che lo spettacolo offra ancora grandissimi momenti, vedremo con l'ottava stagione quale sarà la direzione che seguirà in futuro la serie.
domenica 17 settembre 2017
WOMB
(di Benedek Fliegauf, 2010)
Il dilemma etico di fondo che muove la visione di Womb è di quelli importanti, complessi e affascinanti. È un dilemma per noi ancora poco attuale o quotidiano, ma potremmo esserci vicini, scientificamente siamo a un passo; la vicenda narrata dall'ungherese Fliegauf non stonerebbe infatti all'interno della splendida serie tv britannica Black Mirror che ci mostra, agghiacciandoci, futuri possibili che potremmo trovarci davanti semplicemente girando l'angolo.
La storia è ambientata in una landa indefinita, su una costa di qualche mare del Nord, in quello che potrebbe essere un futuro prossimo apparentemente identico al nostro presente. La piccola Rebecca (Ruby O. Fee) vive con l'anziano nonno, un giorno incontra sulla spiaggia il coetaneo Thomas (Tristan Christopher). Col tempo i due bambini stringono una grande amicizia, affezionandosi sempre più l'uno all'altro, poi la bambina sarà costretta a trasferirsi per seguire la madre in Giappone. Passano gli anni, Rebecca (Eva Green) torna sui luoghi della sua infanzia, va alla ricerca di Tommy (Matt Smith) che non li ha mai lasciati. L'incontro tra i due, dopo i primi attimi di sorpresa, spazza via tutti gli anni di lontananza, Tommy ha sempre tenuto Rebecca nel cuore, alimentando il fuoco di un amore del ricordo, il sentimento è ricambiato con trasporto. Purtroppo il destino decide di mettersi di mezzo una volta ancora, Rebecca perde Tommy, di nuovo. Ma non è il nostro tempo che vede svolgersi la vicenda, è un tempo altro, un tempo in cui gli esseri umani possono essere clonati, Rebecca decide così di riavere Tommy, di riaverlo portandolo in grembo, di riaverlo per amarlo d'un amore tutto nuovo, altrettanto potente ma completamente diverso.
Le scelte stilistiche di Filegauf immergono la vicenda in una sensazione costante di sospensione, quasi di irrealtà, a scandire il passare del tempo l'ottima idea del regista di riproporre più volte le stesse inquadrature, soprattutto quelle con protagonista Rebecca (a letto, nella vasca), in momenti diversi della narrazione, ad anni di distanza. Le sensazioni sopra descritte sono sottolineate al meglio dalla fotografia di Péter Szatmari: toni grigi e blu, plumbei, che contribuiscono a fermare l'incedere degli eventi in singoli momenti, sospesi nella realtà.
Nonostante le cose sembrino filare lisce all'inizio, è inevitabile che l'amore tra la Rebecca madre e il Thomas figlio nasca malato, morboso e che col crescere del bambino, che assomiglierà sempre più al Tommy adulto amato da Rebecca in precedenza, le cose non potranno che divenire più difficili. Matt Smith ed Eva Green danno corpo a emozioni e situazioni forti, in maniera del tutto naturale, la Green porta al film un amore del tutto trattenuto, delicato quando è nella sua accezione più naturale, altrettanto interiorizzato ma tormentato nella seconda parte del film, in entrambi i casi con immutata bravura. Lo spettatore è abituato probabilmente a vedere Smith nei panni del Doctor Who, qui l'attore dimostra ancora una volta di essere davvero in gamba, portando in scena un personaggio che qualche punto in comune con il suo Dottore ce l'ha anche, più duttile nel ventaglio di emozioni esplicitate rispetto a quelle scritte per il personaggio di Rebecca, bella prova per entrambi i protagonisti.
Dà da pensare Womb, la percezione di ciò che è eticamente giusto e ciò che è sbagliato è soggettiva, quando sarà davvero il momento di scegliere su argomenti eticamente rilevanti come questo, bisognerà per forza mettere da parte profitti ed egoismi. Scommetto che non ci riusciremo.
Il dilemma etico di fondo che muove la visione di Womb è di quelli importanti, complessi e affascinanti. È un dilemma per noi ancora poco attuale o quotidiano, ma potremmo esserci vicini, scientificamente siamo a un passo; la vicenda narrata dall'ungherese Fliegauf non stonerebbe infatti all'interno della splendida serie tv britannica Black Mirror che ci mostra, agghiacciandoci, futuri possibili che potremmo trovarci davanti semplicemente girando l'angolo.
La storia è ambientata in una landa indefinita, su una costa di qualche mare del Nord, in quello che potrebbe essere un futuro prossimo apparentemente identico al nostro presente. La piccola Rebecca (Ruby O. Fee) vive con l'anziano nonno, un giorno incontra sulla spiaggia il coetaneo Thomas (Tristan Christopher). Col tempo i due bambini stringono una grande amicizia, affezionandosi sempre più l'uno all'altro, poi la bambina sarà costretta a trasferirsi per seguire la madre in Giappone. Passano gli anni, Rebecca (Eva Green) torna sui luoghi della sua infanzia, va alla ricerca di Tommy (Matt Smith) che non li ha mai lasciati. L'incontro tra i due, dopo i primi attimi di sorpresa, spazza via tutti gli anni di lontananza, Tommy ha sempre tenuto Rebecca nel cuore, alimentando il fuoco di un amore del ricordo, il sentimento è ricambiato con trasporto. Purtroppo il destino decide di mettersi di mezzo una volta ancora, Rebecca perde Tommy, di nuovo. Ma non è il nostro tempo che vede svolgersi la vicenda, è un tempo altro, un tempo in cui gli esseri umani possono essere clonati, Rebecca decide così di riavere Tommy, di riaverlo portandolo in grembo, di riaverlo per amarlo d'un amore tutto nuovo, altrettanto potente ma completamente diverso.
Le scelte stilistiche di Filegauf immergono la vicenda in una sensazione costante di sospensione, quasi di irrealtà, a scandire il passare del tempo l'ottima idea del regista di riproporre più volte le stesse inquadrature, soprattutto quelle con protagonista Rebecca (a letto, nella vasca), in momenti diversi della narrazione, ad anni di distanza. Le sensazioni sopra descritte sono sottolineate al meglio dalla fotografia di Péter Szatmari: toni grigi e blu, plumbei, che contribuiscono a fermare l'incedere degli eventi in singoli momenti, sospesi nella realtà.
Nonostante le cose sembrino filare lisce all'inizio, è inevitabile che l'amore tra la Rebecca madre e il Thomas figlio nasca malato, morboso e che col crescere del bambino, che assomiglierà sempre più al Tommy adulto amato da Rebecca in precedenza, le cose non potranno che divenire più difficili. Matt Smith ed Eva Green danno corpo a emozioni e situazioni forti, in maniera del tutto naturale, la Green porta al film un amore del tutto trattenuto, delicato quando è nella sua accezione più naturale, altrettanto interiorizzato ma tormentato nella seconda parte del film, in entrambi i casi con immutata bravura. Lo spettatore è abituato probabilmente a vedere Smith nei panni del Doctor Who, qui l'attore dimostra ancora una volta di essere davvero in gamba, portando in scena un personaggio che qualche punto in comune con il suo Dottore ce l'ha anche, più duttile nel ventaglio di emozioni esplicitate rispetto a quelle scritte per il personaggio di Rebecca, bella prova per entrambi i protagonisti.
Dà da pensare Womb, la percezione di ciò che è eticamente giusto e ciò che è sbagliato è soggettiva, quando sarà davvero il momento di scegliere su argomenti eticamente rilevanti come questo, bisognerà per forza mettere da parte profitti ed egoismi. Scommetto che non ci riusciremo.
mercoledì 13 settembre 2017
BRADI PIT 151
Senza parole
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
martedì 12 settembre 2017
IN TIME
(di Andrew Niccol, 2011)
Andrew Niccol esordì alla regia nel 1997 con un film molto riuscito come Gattaca, andando a inserirsi nell'elenco dei registi affascinati da una fantascienza intelligente, autore sicuramente da tenere d'occhio, confermatosi in seguito con l'interessante più che bello S1m0ne e in tempi più recenti proprio con questo In time, lucida metafora per mettere allo scoperto, se ancora ce ne fosse bisogno, l'insensatezza e la crudele dannosità del sistema capitalistico mondiale, qui ridotto in scala nella narrazione di eventi concentrati in un'unica città.
Siamo in un futuro indefinito, nell'aspetto poco dissimile dal nostro oggi se non per una serie di particolari. Grazie ad alcune modifiche genetiche gli esseri umani invecchiano fino all'età di 25 anni, giunti a quel punto il loro aspetto diventa immutabile, la loro vita da quel momento avrà scadenza a un anno, poi la morte, a meno che non si riesca a guadagnare tempo extra, lavorando, vincendolo al gioco, barattandolo, rubandolo e via discorrendo. La vita che resta è ben evidenziata da un timer digitale stampigliato sulle braccia delle persone in un continuo conto alla rovescia verso lo 0000.0000.0000 finale. Poi la morte subitanea. Il tempo ha preso il posto dei soldi, ci si comprano le cose, ci si paga l'affitto, si viene pagati in tempo, con l'unica differenza che se nella nostra realtà finisci i soldi sei povero, in quella di In time se finisci il tempo sei morto.
Will Salas (Justin Timberlake) vive nel ghetto, uno dei quartieri più poveri della città, dove la gente cerca giorno dopo giorno di guadagnarsi quel poco di tempo che gli permette di sopravvivere ancora un altro giorno. Purtroppo l'ordine mondiale, proprio come fa quello economico della nostra società, impone rincari continui al costo della vita, tagli sui compensi, calcoli spietati, tanto più necessari per l'élite ricca in un mondo dove il rischio di sovrappopolamento sarebbe altissimo se non si trovasse un sistema per falciare il grosso della popolazione e spingere invece pochi eletti verso l'immortalità, perché ricchezza è tempo e tempo qui è vita. Al contrario il rimanere senza lavoro, senza tempo è morte. A causa di questo sistema malato l'amata madre di Will (Olivia Wilde) perde la vita, cosa che farà aprire gli occhi al ragazzo ispirandogli moti di ribellione già propri della famiglia Salas. Grazie a una fortunata donazione di uno sconosciuto abbiente (Matt Bomer), Will si trasferirà nei quartieri ricchi maturando un suo piano di vendetta, in seguito supportato dalla bella Sylvia (Amanda Seyfried), figlia di Philippe Weis (Vincent Kartheiser), proprietario delle banche del tempo Weis. A frapporsi tra Will e il suo piano di ridistribuzione della ricchezza, perché in fondo questo è, il guardiano del tempo Raimond Leon (Cillian Murphy).
Sono diversi i punti di interesse in In time. Intanto il film, pur presentando un futuro visivamente non troppo dissimile al nostro quotidiano, ha il giusto appeal estetico, Justin Timberlake si rivela essere anche un buon attore e la Seyfried, meno brava e incisiva, sfodera comunque un lato sensuale che non guasta. La metafora con il nostro sistema del capitale è palese e sotto gli occhi di tutti, eppure funziona, non mancano inoltre spunti di riflessione sull'uso che facciamo del nostro tempo, qui nodo centrale del film. Durante lo sviluppo della trama l'accoppiata Will/Sylvia assume i toni delle coppie scanzonate alla Bonnie & Clyde, novelli Robin Hood che rubano tempo ai ricchi per darlo letteralmente ai poveri. Anche il ritmo è ben dosato, senza passaggi a vuoto grazie anche a diverse sequenze action parecchio dinamiche.
L'opera di Niccol è un ottimo compromesso tra prodotto d'intrattenimento e film con diverse cose da dire, ben girato e interpretato da attori che non vanno mai sotto la soglia di guardia. Più che una sorpresa in realtà, visto proprio il percorso di Niccol, In time è una bella conferma che può sicuramente soddisfare più di un tipo di pubblico.
Andrew Niccol esordì alla regia nel 1997 con un film molto riuscito come Gattaca, andando a inserirsi nell'elenco dei registi affascinati da una fantascienza intelligente, autore sicuramente da tenere d'occhio, confermatosi in seguito con l'interessante più che bello S1m0ne e in tempi più recenti proprio con questo In time, lucida metafora per mettere allo scoperto, se ancora ce ne fosse bisogno, l'insensatezza e la crudele dannosità del sistema capitalistico mondiale, qui ridotto in scala nella narrazione di eventi concentrati in un'unica città.
Siamo in un futuro indefinito, nell'aspetto poco dissimile dal nostro oggi se non per una serie di particolari. Grazie ad alcune modifiche genetiche gli esseri umani invecchiano fino all'età di 25 anni, giunti a quel punto il loro aspetto diventa immutabile, la loro vita da quel momento avrà scadenza a un anno, poi la morte, a meno che non si riesca a guadagnare tempo extra, lavorando, vincendolo al gioco, barattandolo, rubandolo e via discorrendo. La vita che resta è ben evidenziata da un timer digitale stampigliato sulle braccia delle persone in un continuo conto alla rovescia verso lo 0000.0000.0000 finale. Poi la morte subitanea. Il tempo ha preso il posto dei soldi, ci si comprano le cose, ci si paga l'affitto, si viene pagati in tempo, con l'unica differenza che se nella nostra realtà finisci i soldi sei povero, in quella di In time se finisci il tempo sei morto.
Will Salas (Justin Timberlake) vive nel ghetto, uno dei quartieri più poveri della città, dove la gente cerca giorno dopo giorno di guadagnarsi quel poco di tempo che gli permette di sopravvivere ancora un altro giorno. Purtroppo l'ordine mondiale, proprio come fa quello economico della nostra società, impone rincari continui al costo della vita, tagli sui compensi, calcoli spietati, tanto più necessari per l'élite ricca in un mondo dove il rischio di sovrappopolamento sarebbe altissimo se non si trovasse un sistema per falciare il grosso della popolazione e spingere invece pochi eletti verso l'immortalità, perché ricchezza è tempo e tempo qui è vita. Al contrario il rimanere senza lavoro, senza tempo è morte. A causa di questo sistema malato l'amata madre di Will (Olivia Wilde) perde la vita, cosa che farà aprire gli occhi al ragazzo ispirandogli moti di ribellione già propri della famiglia Salas. Grazie a una fortunata donazione di uno sconosciuto abbiente (Matt Bomer), Will si trasferirà nei quartieri ricchi maturando un suo piano di vendetta, in seguito supportato dalla bella Sylvia (Amanda Seyfried), figlia di Philippe Weis (Vincent Kartheiser), proprietario delle banche del tempo Weis. A frapporsi tra Will e il suo piano di ridistribuzione della ricchezza, perché in fondo questo è, il guardiano del tempo Raimond Leon (Cillian Murphy).
Sono diversi i punti di interesse in In time. Intanto il film, pur presentando un futuro visivamente non troppo dissimile al nostro quotidiano, ha il giusto appeal estetico, Justin Timberlake si rivela essere anche un buon attore e la Seyfried, meno brava e incisiva, sfodera comunque un lato sensuale che non guasta. La metafora con il nostro sistema del capitale è palese e sotto gli occhi di tutti, eppure funziona, non mancano inoltre spunti di riflessione sull'uso che facciamo del nostro tempo, qui nodo centrale del film. Durante lo sviluppo della trama l'accoppiata Will/Sylvia assume i toni delle coppie scanzonate alla Bonnie & Clyde, novelli Robin Hood che rubano tempo ai ricchi per darlo letteralmente ai poveri. Anche il ritmo è ben dosato, senza passaggi a vuoto grazie anche a diverse sequenze action parecchio dinamiche.
L'opera di Niccol è un ottimo compromesso tra prodotto d'intrattenimento e film con diverse cose da dire, ben girato e interpretato da attori che non vanno mai sotto la soglia di guardia. Più che una sorpresa in realtà, visto proprio il percorso di Niccol, In time è una bella conferma che può sicuramente soddisfare più di un tipo di pubblico.
lunedì 11 settembre 2017
AMERICANI
(Glengarry Glen Ross di James Foley, 1992)
Americani è il secondo film d'attori (dopo Barbecue) che mi è capitato di vedere nel giro di pochi giorni, pellicola di dialoghi, interpretazioni, bravura attoriale, sequenze strette in interni, a volte oppressive e soffocanti, chiuse nell'abitacolo di un'auto squassato dalla pioggia, all'interno di una cabina telefonica, illuminate artificiosamente davanti al bancone di un bar. La differenza tra i due film sta forse in un'unica parola: attori. Per fare un film d'attori ci vogliono degli attori, di quelli bravi, e qui ci sono tutti: Jack Lemmon, Al Pacino, Ed Harris, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Alan Arkin, elencati più o meno in ordine di merito, relativamente alle loro interpretazione in questa particolare occasione.
Foley dirige un gruppo affiatato che dovrebbe esserlo anche all'interno dell'economia della vicenda narrata, tutti professionisti impiegati alle dipendenze della stessa azienda, chiamati a remare nella stessa direzione sotto l'unica bandiera che ormai conti davvero nel mondo occidentale: quella del profitto personale, in primis ovviamente quello dei vertici aziendali. Essendo tutti venditori, per lo più in difficoltà, ben presto l'affiatamento e la cooperazione vanno a farsi benedire per lasciare spazio all'individualismo più bieco, alla disperazione, all'astio, all'invidia e a tutte le peggiori idee che uomini sull'orlo del fallimento possano arrivare a concepire.
La Mitch & Murray si occupa di proprietà immobiliari, terreni e lotti da vendere. Nell'agenzia in questione le cose non vanno bene, le vendite sono scarse, la sede centrale manda il mastino Blake (Alec Baldwin) a motivare i quattro venditori gestiti dal passacarte John Williamson (Kevin Spacey): ne escono minacce, umiliazioni e scoramento. La gara del mese prevede crudelmente una nuova Cadillac per il vincitore, un set di coltelli per il secondo classificato, il licenziamento per gli altri. Ricky Roma (Al Pacino) è in testa alle classifiche da diversi mesi, è un affabulatore, un mistificatore che con la chiacchiera che tutti potete immaginare se avete avuto l'occasione di vedere all'opera Al Pacino al suo meglio, riesce a intortare i clienti, se li cucina a dovere fino a portarli all'unico gesto che veramente conta, l'apposizione di quella cazzo di firma sulla linea tratteggiata. Non c'è nient'altro. Shelley Levene (Jack Lemmon) è il maestro del passato, un venditore sul viale del tramonto con problemi familiari ed economici assillanti, cerca le ultime indispensabili zampate per amore d'una figlia malata, non trova comprensione, i contatti dell'azienda sono usurati, gli spiragli di luce ormai pochissimi. Dave Moss (Ed Harris) è un calderone di rancore, insoddisfazione, livore, fallimento e auto assoluzione pronto a scoppiare in ogni momento, giusto contraltare per George Aaronow (Alan Arkin), un venditore ormai sconfitto, leso irrimediabilmente nell'autostima, insicuro e incerto sul da farsi.
Non c'è nessuna solidarietà tra i protagonisti, solo competizione, opportunismo, gesti di facciata e disonestà che scoperchiano il marciume di una società del lavoro competitiva fino alla distruzione del perdente, che non è più un uomo in difficoltà, non è nemmeno più un uomo. È un'etichetta: quella del fallito, quella della merda senza valore, accantonabile e calpestabile. Americani è un film dove prima della vicenda narrata, di cui non sto nemmeno a dirvi troppo, si apprezzano il messaggio di fondo ma soprattutto le interpretazioni degli attori coinvolti, e se nella vicenda finzionale la classifica dei loro meriti è chiara e legata a cifre indiscutibili, quella ipotetica per la migliore interpretazione sarebbe combattuta fino all'ultimo frame e incoronerebbe un vincitore solo sul filo di lana. La sceneggiatura è solida, scritta da un professionista indiscusso come David Mamet, adattata da una sua stessa opera teatrale, tiene viva l'attenzione senza cali di ritmo nonostante sia tutto basato sui soli dialoghi, tutto è aiutato dalla bella scelta dei brani in colonna sonora, pezzi di Donald Fagen, Duke Ellington e contributi di Al Jarreau e Wayne Shorter.
Per avere successo in operazioni come questa ci vogliono i nomi (non per forza solo famosi), e qui i nomi ci sono.
Americani è il secondo film d'attori (dopo Barbecue) che mi è capitato di vedere nel giro di pochi giorni, pellicola di dialoghi, interpretazioni, bravura attoriale, sequenze strette in interni, a volte oppressive e soffocanti, chiuse nell'abitacolo di un'auto squassato dalla pioggia, all'interno di una cabina telefonica, illuminate artificiosamente davanti al bancone di un bar. La differenza tra i due film sta forse in un'unica parola: attori. Per fare un film d'attori ci vogliono degli attori, di quelli bravi, e qui ci sono tutti: Jack Lemmon, Al Pacino, Ed Harris, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Alan Arkin, elencati più o meno in ordine di merito, relativamente alle loro interpretazione in questa particolare occasione.
Foley dirige un gruppo affiatato che dovrebbe esserlo anche all'interno dell'economia della vicenda narrata, tutti professionisti impiegati alle dipendenze della stessa azienda, chiamati a remare nella stessa direzione sotto l'unica bandiera che ormai conti davvero nel mondo occidentale: quella del profitto personale, in primis ovviamente quello dei vertici aziendali. Essendo tutti venditori, per lo più in difficoltà, ben presto l'affiatamento e la cooperazione vanno a farsi benedire per lasciare spazio all'individualismo più bieco, alla disperazione, all'astio, all'invidia e a tutte le peggiori idee che uomini sull'orlo del fallimento possano arrivare a concepire.
La Mitch & Murray si occupa di proprietà immobiliari, terreni e lotti da vendere. Nell'agenzia in questione le cose non vanno bene, le vendite sono scarse, la sede centrale manda il mastino Blake (Alec Baldwin) a motivare i quattro venditori gestiti dal passacarte John Williamson (Kevin Spacey): ne escono minacce, umiliazioni e scoramento. La gara del mese prevede crudelmente una nuova Cadillac per il vincitore, un set di coltelli per il secondo classificato, il licenziamento per gli altri. Ricky Roma (Al Pacino) è in testa alle classifiche da diversi mesi, è un affabulatore, un mistificatore che con la chiacchiera che tutti potete immaginare se avete avuto l'occasione di vedere all'opera Al Pacino al suo meglio, riesce a intortare i clienti, se li cucina a dovere fino a portarli all'unico gesto che veramente conta, l'apposizione di quella cazzo di firma sulla linea tratteggiata. Non c'è nient'altro. Shelley Levene (Jack Lemmon) è il maestro del passato, un venditore sul viale del tramonto con problemi familiari ed economici assillanti, cerca le ultime indispensabili zampate per amore d'una figlia malata, non trova comprensione, i contatti dell'azienda sono usurati, gli spiragli di luce ormai pochissimi. Dave Moss (Ed Harris) è un calderone di rancore, insoddisfazione, livore, fallimento e auto assoluzione pronto a scoppiare in ogni momento, giusto contraltare per George Aaronow (Alan Arkin), un venditore ormai sconfitto, leso irrimediabilmente nell'autostima, insicuro e incerto sul da farsi.
Non c'è nessuna solidarietà tra i protagonisti, solo competizione, opportunismo, gesti di facciata e disonestà che scoperchiano il marciume di una società del lavoro competitiva fino alla distruzione del perdente, che non è più un uomo in difficoltà, non è nemmeno più un uomo. È un'etichetta: quella del fallito, quella della merda senza valore, accantonabile e calpestabile. Americani è un film dove prima della vicenda narrata, di cui non sto nemmeno a dirvi troppo, si apprezzano il messaggio di fondo ma soprattutto le interpretazioni degli attori coinvolti, e se nella vicenda finzionale la classifica dei loro meriti è chiara e legata a cifre indiscutibili, quella ipotetica per la migliore interpretazione sarebbe combattuta fino all'ultimo frame e incoronerebbe un vincitore solo sul filo di lana. La sceneggiatura è solida, scritta da un professionista indiscusso come David Mamet, adattata da una sua stessa opera teatrale, tiene viva l'attenzione senza cali di ritmo nonostante sia tutto basato sui soli dialoghi, tutto è aiutato dalla bella scelta dei brani in colonna sonora, pezzi di Donald Fagen, Duke Ellington e contributi di Al Jarreau e Wayne Shorter.
Per avere successo in operazioni come questa ci vogliono i nomi (non per forza solo famosi), e qui i nomi ci sono.
venerdì 8 settembre 2017
TEMPESTA SU GALVESTON
(di Pasquale Ruju e Massimo Rotundo, 2015)
Dopo l'ottimo esito del precedente Texone, L'orda del tramonto, viene confermato per la seconda prova consecutiva alla sceneggiatura del Tex Speciale lo scrittore Pasquale Ruju al quale questa volta si affianca il disegnatore romano Massimo Rotundo. Nel corso degli anni mi è capitato diverse volte di leggere critiche severe al lavoro di Ruju, soprattutto in relazione agli albi di Dylan Dog da lui sceneggiati, questo un poco mi dispiace perché nelle storie di Ruju che mi è capitato di leggere all'interno di serie diverse, io alla fine mi sono sempre sentito un po' a casa. Probabilmente Ruju non è tra gli scrittori più originali e innovativi in circolazione, ha dei modelli che segue forse con fin troppa passione senza mai distaccarsene troppo, eppure ho come l'impressione che a Ruju piacciano le stesse cose che piacciono a me, questo a prescindere dall'originalità dei suoi scritti, proprio per questioni di affinità, me lo fa apprezzare praticamente sempre. La storia di questo Texone non fa eccezione.
È proprio il mix di elementi che anche questa volta mi ha fatto apprezzare la storia imbastita da Ruju: c'è l'America degli stati del sud, quella economicamente legata allo schiavismo, ritratta proprio nel momento in cui questa risorsa viene meno e i neri d'America, almeno sulla carta, ottengono i loro primi diritti, c'è un'ambientazione molto urbana e cittadina, con i suoi bei saloon, i vicoli bui, il porto, parecchi interni, ci sono dei buoni compagni di viaggio per Tex e Kit, una bella figura femminile forte e intelligente e ovviamente due o tre figli di buona donna. Gli ingredienti sono mescolati bene e offrono una bella narrazione, solida, di quelle che regalano qualche oretta di soddisfazioni.
Il Colonnello Woodlord è un possidente che sfrutta la manodopera negra nelle sue piantagioni, l'abolizione dello schiavismo però ha reso le cose più difficili anche per lui, proprio per questo il Colonnello non naviga più in acque economicamente tranquille. Con l'appoggio del corrotto giudice Trent, il Colonnello si garantisce lo sfruttamento dei condannati neri, anche quelli condannati ingiustamente, che alla prigione possono preferire per legge il lavoro nelle piantagioni di qualche ricco possidente. Fatta la legge, trovato l'inganno. Allo stesso tempo e nella stessa zona Tex e Kit Carson sono sulle tracce di un manipolo di assassini rei di aver steso un collega ranger. A Galveston i due si imbattono quindi nel nuovo sceriffo e nella bella Miss Eleanor, proprietaria del miglior saloon della città, va da sé che la figura della damigella in pericolo è servita. Le trame si incroceranno fino a portare alla decisiva Tempesta su Galveston.
Ammetto che i disegni di Massimo Rotundo non rientrino nel novero dei miei favoriti per quel che riguarda la collana del Texone, nel complesso si parla sempre del lavoro di un grande professionista, eppure alcune spigolosità nei volti, una certa discontinuità nella resa grafica di quello di Tex non incontrano proprio i miei gusti. Manca a mio modo di vedere la meraviglia del soffermarsi davanti alla tavola che ti stupisce, c'è un bel lavoro sugli interni, su diversi piani ampi e su alcune vedute che mi sono piaciute particolarmente, ma nel complesso ho trovato il lavoro di Rotundo ben realizzato e godile ma nulla più, cosa che comunque, unita a una buona storia, rende Tempesta su Galveston una bella lettura.
Dopo l'ottimo esito del precedente Texone, L'orda del tramonto, viene confermato per la seconda prova consecutiva alla sceneggiatura del Tex Speciale lo scrittore Pasquale Ruju al quale questa volta si affianca il disegnatore romano Massimo Rotundo. Nel corso degli anni mi è capitato diverse volte di leggere critiche severe al lavoro di Ruju, soprattutto in relazione agli albi di Dylan Dog da lui sceneggiati, questo un poco mi dispiace perché nelle storie di Ruju che mi è capitato di leggere all'interno di serie diverse, io alla fine mi sono sempre sentito un po' a casa. Probabilmente Ruju non è tra gli scrittori più originali e innovativi in circolazione, ha dei modelli che segue forse con fin troppa passione senza mai distaccarsene troppo, eppure ho come l'impressione che a Ruju piacciano le stesse cose che piacciono a me, questo a prescindere dall'originalità dei suoi scritti, proprio per questioni di affinità, me lo fa apprezzare praticamente sempre. La storia di questo Texone non fa eccezione.
È proprio il mix di elementi che anche questa volta mi ha fatto apprezzare la storia imbastita da Ruju: c'è l'America degli stati del sud, quella economicamente legata allo schiavismo, ritratta proprio nel momento in cui questa risorsa viene meno e i neri d'America, almeno sulla carta, ottengono i loro primi diritti, c'è un'ambientazione molto urbana e cittadina, con i suoi bei saloon, i vicoli bui, il porto, parecchi interni, ci sono dei buoni compagni di viaggio per Tex e Kit, una bella figura femminile forte e intelligente e ovviamente due o tre figli di buona donna. Gli ingredienti sono mescolati bene e offrono una bella narrazione, solida, di quelle che regalano qualche oretta di soddisfazioni.
Il Colonnello Woodlord è un possidente che sfrutta la manodopera negra nelle sue piantagioni, l'abolizione dello schiavismo però ha reso le cose più difficili anche per lui, proprio per questo il Colonnello non naviga più in acque economicamente tranquille. Con l'appoggio del corrotto giudice Trent, il Colonnello si garantisce lo sfruttamento dei condannati neri, anche quelli condannati ingiustamente, che alla prigione possono preferire per legge il lavoro nelle piantagioni di qualche ricco possidente. Fatta la legge, trovato l'inganno. Allo stesso tempo e nella stessa zona Tex e Kit Carson sono sulle tracce di un manipolo di assassini rei di aver steso un collega ranger. A Galveston i due si imbattono quindi nel nuovo sceriffo e nella bella Miss Eleanor, proprietaria del miglior saloon della città, va da sé che la figura della damigella in pericolo è servita. Le trame si incroceranno fino a portare alla decisiva Tempesta su Galveston.
Ammetto che i disegni di Massimo Rotundo non rientrino nel novero dei miei favoriti per quel che riguarda la collana del Texone, nel complesso si parla sempre del lavoro di un grande professionista, eppure alcune spigolosità nei volti, una certa discontinuità nella resa grafica di quello di Tex non incontrano proprio i miei gusti. Manca a mio modo di vedere la meraviglia del soffermarsi davanti alla tavola che ti stupisce, c'è un bel lavoro sugli interni, su diversi piani ampi e su alcune vedute che mi sono piaciute particolarmente, ma nel complesso ho trovato il lavoro di Rotundo ben realizzato e godile ma nulla più, cosa che comunque, unita a una buona storia, rende Tempesta su Galveston una bella lettura.
mercoledì 6 settembre 2017
BRADI PIT 150
150!!! Traguardo importante tagliato a tutta velocità!
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
Clicca sull'immagine per ingrandire.
Aiutaci a diffondere il verbo del Bradipo linkandolo. Fallo tu perché il Bradipo fa n'caz.
martedì 5 settembre 2017
BARBECUE
(di Éric Lavaine, 2014)
Scuole di pensiero. C'è chi sostiene che a certa commedia francese piaccia un poco parlarsi addosso, c'è invece chi apprezza i film in cui si discetta degli avvenimenti quotidiani, di quegli aspetti dell'esistenza che prima o poi potrebbero toccare un po' tutti quanti e che tutti potrebbero vederci protagonisti. Insomma, la vita. Ok, sta bene, ma quale vita? Tra poco ci torniamo. In Barbecue abbiamo un gruppo di amici di lungo corso, uomini e donne, prevalentemente coppie o ex coppie e un single. Durante un evento sportivo uno di loro, Antoine (Lambert Wilson), ha un infarto. Rimessosi senza conseguenze dal piccolo inconveniente, Antoine decide di cambiare vita: lascia il lavoro, decide di prendersi il suo tempo, smette di fare attenzione al cibo, la fa finita con lo sport, ricomincia a fumare, mette da parte tutte quelle cose fatte fino a cinquant'anni nella convinzione di trarne giovamento. Invece l'infarto è arrivato lo stesso, inaspettato, e allora fanculo tutto (e magari potessimo farlo tutti, infarto o meno), sembra sia arrivato il momento di vivere davvero. L'episodio è solo il punto di partenza per raccontare le vicende di questo gruppo di amici, i loro caratteri, l'evolversi dei rapporti tra di loro, le cose dette ma soprattutto quelle non dette per paura di offendere o ferire qualcuno, i loro drammi (?) e via discorrendo.
Come si diceva prima, e qui torniamo al punto, la vita. Ok, sta bene, ma quale vita? No, perché in Barbecue accade che siano tutti molto benestanti, a parte il povero Jean-Mich (Jérome Commandeur) che sembra essere di estrazione proletaria (ha un lavoro normale in officina) e guarda caso è l'unico che ha l'aria di essere un po' ignorante, non ha una donna, è imbranatello, non distingue un vino da centinaia e centinaia di euro da uno in cartone (e sai che dramma). Ora non so se sia più stupido questo stereotipo o più insultante per la figura femminile il fatto che ovviamente nessuna donna stia con il morto di fame, mentre chi è meglio sistemato economicamente ha naturalmente una compagna. Ma qui forse è la mia indole proletaria e un poco spazientita che prende il sopravvento, andiamo oltre. Il grande dramma diffuso all'interno della compagnia, salvo rare eccezioni, sembra quello derivante dalla difficoltà di tenere gli organi genitali all'interno delle rispettive mutande, insomma si è tradito, si tradisce, probabilmente si tradirà, si fanno volentieri esperienze piacevoli, si fatica ad accettare quelle degli altri, gelosie, ritorni di fiamma, happy ending. Tutto in una cornice di sufficienza e noncuranza molto ammirevole, i ragazzi (uomini ormai) sanno come prendere la vita. Si cresce (?), tutto si risolve per il meglio, l'amico possidente di terreni che sembrava sul punto di subire un tracollo finanziario si riprende, siamo tutti contenti. I figli che pure ci sono, sono relegati su uno sfondo di cui non ci si cura, al massimo gli si consiglia di scopare, fumare e vivere felici (ottimi consigli per carità, ovviamente il figlio in questione è maschio) e poi cos'altro? Sì, ecco, la noia e la sincerità. In un mucchio di tematiche che lasciano il tempo che trovano forse questi sono i due aspetti che davvero possono accomunare un po' tutti, l'idea di non dire, di non essere sinceri per non offendere, di camminare lungo la linea senza deviazioni, per il quieto vivere. La noia, non solo quella subita ma anche inevitabilmente quella procurata agli altri. Qualcosa di interessante su cui riflettere.
Il film in realtà non è poi terribile, si lascia guardare, corre via innocuo; non c'è ironia, non c'è spessore, ma nemmeno ci si annoia. È il tipo di film che nell'ambito del fumetto verrebbe definito una sequenza di teste parlanti, una vicenda cioè dove sono i dialoghi a farla da padrone, con una presenza scarsa o nulla di sequenze dinamiche o, come in questo caso, di una storia. Però, per passare una serata senza pensieri, sono dell'idea che sia sempre meglio qualcosa di più proletario, forse come direbbe Lavaine, qualcosa di più ignorante. Ridateci gli action anni '80.
Scuole di pensiero. C'è chi sostiene che a certa commedia francese piaccia un poco parlarsi addosso, c'è invece chi apprezza i film in cui si discetta degli avvenimenti quotidiani, di quegli aspetti dell'esistenza che prima o poi potrebbero toccare un po' tutti quanti e che tutti potrebbero vederci protagonisti. Insomma, la vita. Ok, sta bene, ma quale vita? Tra poco ci torniamo. In Barbecue abbiamo un gruppo di amici di lungo corso, uomini e donne, prevalentemente coppie o ex coppie e un single. Durante un evento sportivo uno di loro, Antoine (Lambert Wilson), ha un infarto. Rimessosi senza conseguenze dal piccolo inconveniente, Antoine decide di cambiare vita: lascia il lavoro, decide di prendersi il suo tempo, smette di fare attenzione al cibo, la fa finita con lo sport, ricomincia a fumare, mette da parte tutte quelle cose fatte fino a cinquant'anni nella convinzione di trarne giovamento. Invece l'infarto è arrivato lo stesso, inaspettato, e allora fanculo tutto (e magari potessimo farlo tutti, infarto o meno), sembra sia arrivato il momento di vivere davvero. L'episodio è solo il punto di partenza per raccontare le vicende di questo gruppo di amici, i loro caratteri, l'evolversi dei rapporti tra di loro, le cose dette ma soprattutto quelle non dette per paura di offendere o ferire qualcuno, i loro drammi (?) e via discorrendo.
Come si diceva prima, e qui torniamo al punto, la vita. Ok, sta bene, ma quale vita? No, perché in Barbecue accade che siano tutti molto benestanti, a parte il povero Jean-Mich (Jérome Commandeur) che sembra essere di estrazione proletaria (ha un lavoro normale in officina) e guarda caso è l'unico che ha l'aria di essere un po' ignorante, non ha una donna, è imbranatello, non distingue un vino da centinaia e centinaia di euro da uno in cartone (e sai che dramma). Ora non so se sia più stupido questo stereotipo o più insultante per la figura femminile il fatto che ovviamente nessuna donna stia con il morto di fame, mentre chi è meglio sistemato economicamente ha naturalmente una compagna. Ma qui forse è la mia indole proletaria e un poco spazientita che prende il sopravvento, andiamo oltre. Il grande dramma diffuso all'interno della compagnia, salvo rare eccezioni, sembra quello derivante dalla difficoltà di tenere gli organi genitali all'interno delle rispettive mutande, insomma si è tradito, si tradisce, probabilmente si tradirà, si fanno volentieri esperienze piacevoli, si fatica ad accettare quelle degli altri, gelosie, ritorni di fiamma, happy ending. Tutto in una cornice di sufficienza e noncuranza molto ammirevole, i ragazzi (uomini ormai) sanno come prendere la vita. Si cresce (?), tutto si risolve per il meglio, l'amico possidente di terreni che sembrava sul punto di subire un tracollo finanziario si riprende, siamo tutti contenti. I figli che pure ci sono, sono relegati su uno sfondo di cui non ci si cura, al massimo gli si consiglia di scopare, fumare e vivere felici (ottimi consigli per carità, ovviamente il figlio in questione è maschio) e poi cos'altro? Sì, ecco, la noia e la sincerità. In un mucchio di tematiche che lasciano il tempo che trovano forse questi sono i due aspetti che davvero possono accomunare un po' tutti, l'idea di non dire, di non essere sinceri per non offendere, di camminare lungo la linea senza deviazioni, per il quieto vivere. La noia, non solo quella subita ma anche inevitabilmente quella procurata agli altri. Qualcosa di interessante su cui riflettere.
Il film in realtà non è poi terribile, si lascia guardare, corre via innocuo; non c'è ironia, non c'è spessore, ma nemmeno ci si annoia. È il tipo di film che nell'ambito del fumetto verrebbe definito una sequenza di teste parlanti, una vicenda cioè dove sono i dialoghi a farla da padrone, con una presenza scarsa o nulla di sequenze dinamiche o, come in questo caso, di una storia. Però, per passare una serata senza pensieri, sono dell'idea che sia sempre meglio qualcosa di più proletario, forse come direbbe Lavaine, qualcosa di più ignorante. Ridateci gli action anni '80.
domenica 3 settembre 2017
AURELIO GALLEPPINI IN ARTE GALEP
Ogni appassionato di Tex riconosce la firma di Aurelio Galleppini, in arte Galep, a prima vista, quella grande G che si interseca obliqua con la A, le restanti lettere comode, adagiate nella pancia dell'iniziale. Non meno inconfondibile è il tratto del creatore grafico del ranger del Texas, a tutti gli effetti uno dei due padri putativi dell'ex fuorilegge con la camicia gialla (l'altro è ovviamente Gianluigi Bonelli). A cent'anni esatti dalla sua nascita ci sembra giusto ricordare un artista così importante per la cultura popolare italiana, il "suo" Tex ancora oggi, a quasi settant'anni dalla nascita, è il fumetto più venduto di casa Bonelli e non solo, una creatura che in qualche modo è riuscita a unire diverse generazioni nella passione per l'avventura e il western, genere un poco messo da parte negli ultimi decenni ma che grazie a Tex ancora fa capolino mensilmente nelle edicole di tutta Italia.
Nato nel 1917, Galep (per l'affetto che per lui nutriamo ci permettiamo di chiamarlo così) si afferma nel mondo del fumetto in un'epoca in cui il disegnatore era un artigiano, un forzato del lavoro stretto dai tempi di consegna e da incarichi plurimi. Nel 1948, anno di nascita di Tex, la Sergio Bonelli Editore ancora non esisteva, almeno non con questo nome, c'erano invece le Edizioni Audace che facevano capo a Tea Bonelli, ex moglie del creatore di Tex: Gianluigi Bonelli. Proprio la signora Bonelli pensò ad Aurelio Galleppini, già forte di diverse esperienze professionali tra le quali quella con Arnoldo Mondadori Editore e con l'Avventuroso di casa Nerbini, per affidargli le matite di ben due nuove proposte: Occhio Cupo e La Collana del Tex.
Più che nei primi albi della serie a strisce di Tex, l'arte di Galep si poteva ammirare proprio sulle tavole di Occhio Cupo, personaggio appartenente al genere cappa e spada e sul quale la casa editrice puntava molto: albo in grande formato, quindicinale e dal prezzo doppio rispetto a quello delle strisce settimanali, imponeva a Galleppini di concentrare gran parte degli sforzi del suo lavoro su questo titolo. Grazie alle tavole più ampie e al maggior investimento adoperato sulla testata (la collana Serie D'Oro Audace), sia in termini artistici che di aspettativa, sulle pagine di Occhio Cupo possiamo ammirare un Galep con una marcia in più rispetto a quello del primissimo Tex. Le vignette sono dettagliate, maggiore è l'attenzione ai volti, al lavoro sulle ombreggiature, i segni si moltiplicano e sono usati con particolare maestria nel costruire immagini di forte impatto, sicuramente aiutate dal più ampio spazio a disposizione. Tutti elementi di stile meno rintracciabili tra le pagine delle strisce di Tex, fumetto nato per essere puramente popolare, di poche pretese e dal quale la stessa casa editrice non si aspettava più di tanto, pronta a sostituirlo con altro alle prime avvisaglie di stanca. Prendendo in mano Il totem misterioso, primo albo di Tex, è evidente come la priorità professionale dell'epoca per Galep non fossero le storie del ranger: fondali non molto ricchi, poca varietà nei volti (tranne quello di Tex che guarda allo stesso Galep), un tratto più affrettato e spesso poco definito, ma anche tanto dinamismo, grande confidenza con i cavalli (notoriamente incubo di molti disegnatori), una bella capacità di infondere sensualità alla figura femminile e soprattutto una velocità produttiva senza eguali, sforzo stoico e continuativo che porterà Galep a sobbarcarsi da solo le prime 100 uscite de La Collana del Tex. Come sanno anche i muri, fu poi proprio Tex a ottenere un buon successo commerciale (ottimo in seguito), mentre il più sfortunato Occhio Cupo fu archiviato dopo solo una dozzina di episodi.
Così albo dopo albo, Galep contribuisce non solo a dar forma alla fantasia a briglia sciolta di Gianluigi Bonelli, ma anche a creare quella mitologia "texiana" così viva ancora oggi nella serie mensile: nel giro di poche uscite il disegnatore toscano (di nascita) imprime negli occhi dei lettori non solo un protagonista e lo scenario western in cui si muove, ma anche i volti di noti comprimari come il sodale Kit Carson, il ribelle messicano Montales o ancora Steve Dickart in arte Mefisto, caratteri sempre cari ai fan dell'epopea di Tex. Non manca inoltre di ibridare i topoi del genere con soluzioni più esotiche dettate da esigenze di sceneggiatura, guardando al cinema, allo stesso fumetto ma anche ai luoghi della sua vita. Non mancava nemmeno il tocco umoristico nei primi albi di Tex disegnati da Galep, non era affatto inusuale infatti trovarvi elementi comici disseminati nei colonnini delle didascalie, caricature stilizzate di animali vari: pesci, uccelli, soprattutto cani che in qualche caso sconfinano anche all'interno della vignetta (vedi striscia 8 de La freccia della morte), residui di un giovanile amore per il disegno umoristico e di vecchi lavori realizzati per il mondo dei cartoni animati.
Da queste parti amiamo Galep per il Tex, creatura sua che l'ha accompagnato quasi fino al giorno della morte sovvenuta nel 1994; quattro anni prima Galep lasciò il segno anche sulla collana più prestigiosa dedicata al ranger, disegnando il terzo Texone (Il segno del serpente, 1990) in un momento storico in cui ormai la matita dell'artista era incerta ma ancora capace di sfornare una mole incredibile di tavole a tempo record, togliendo le castagne dal fuoco in quell'occasione a un Sergio Bonelli in difficoltà, causa la lentezza degli artisti designati alla produzione dei nuovi albi giganti (realizzare un Texone non è impresa da tutti, soprattutto se con tempi stretti). Così il Texone di Galep ha il sapore di un lussuoso ritorno a casa, un tratto noto, maturato nel corso degli anni, finalmente da assaporare in grande formato. Il Tex di Galep è sempre stato molto particolare, originale quasi, con un taglio del volto molto diverso da come l'hanno dipinto artisti più moderni, meno bello forse, ma assolutamente unico. Ne Il segno del serpente è proprio sui volti che spicca la particolarità del tratto del disegnatore: gli avversari, i cattivi, mostrano in faccia la corruzione dell'animo, se i nostri eroi non sono così belli gli antagonisti diventano decisamente brutti. Brutti ma, soprattutto nei primi piani, molto, molto espressivi. Si ammirano ancora le tavole scure, zeppe di segni e la devozione di un artista votato anima e corpo al suo lavoro.
Come dicevamo, qui amiamo Galep per il Tex. Questo nulla toglie ai precedenti lavori del disegnatore, che noi conosciamo e amiamo meno, ma che l'artista ricorda forse con maggiore affetto di quello che sembrava nutrire per Tex, un compagno di vita che gli ha dato da mangiare ma che, come lui stesso afferma, "gli ha anche chiuso la mano". La produzione intensiva aveva infatti fatto perdere a Galep quella che era la sua formazione artistica da autodidatta dell'illustrazione e della pittura, il fumetto è sempre stata una passione risalente all'età giovanile, nata grazie alle storie di Flash Gordon ma anche, e soprattutto, la via per tirare a campare, così, per stessa ammissione dell'autore, alcuni lavori erano pagati pochissimo e quindi tirati via (quelli per L'Intrepido ad esempio) perché si doveva necessariamente puntare sulla quantità. Altre cose invece lo stesso Galep le ricordava con affetto, i primi racconti illustrati per l'infanzia commissionatigli dalle Edizioni Modellina ad esempio permettevano al disegnatore di cimentarsi proprio con quel tratto umoristico a lui congeniale, in seguito i fumetti illustrati, con sole didascalie per Mondadori e per L'Avventuroso, lavori che presentavano tavole di grande eleganza, ricercate, con dettagli tecnici e paesaggistici che raramente abbiamo visto nel Tex di Galep, soprattutto il primo. Poi l'esperienza con Nerbini che Galep ricorda con affetto, storie di guerra e tante illustrazioni, copertine di libri popolari realizzate con lo stile di un illustratore navigato, di quelle che ancora adesso si lasciano ammirare. Poi si arrivò al '48 e a Bonelli.
Tutto quello che abbiamo già detto, tutte le copertine dei primi 400 numeri di Tex, migliaia di tavole prodotte, ristampe che ancora oggi si affastellano l'una sull'altra, l'ultima iniziata pochi mesi or sono con la riproposta integrale del Tex, a partire dalla prima serie a strisce riadattata in un formato ad albo a colori, un lavoro immane. Ovviamente nemmeno la Sergio Bonelli Editore si farà sfuggire l'occasione del centenario per festeggiare e omaggiare ancora una volta Galep, in settembre il numero annuale di Avventura Magazine sarà dedicato proprio a lui, salvo modifiche dell'ultima ora dovrebbe offrirci la possibilità di vedere l'autore all'opera non solo su Tex (con la ristampa di Silver Bell), proponendo le ristampe del primo episodio di Occhio Cupo (Il giuramento del forzato) e una riduzione in vignette de Il libro della giungla. Lo aspettiamo con immutato affetto e malcelata impazienza.
Nato nel 1917, Galep (per l'affetto che per lui nutriamo ci permettiamo di chiamarlo così) si afferma nel mondo del fumetto in un'epoca in cui il disegnatore era un artigiano, un forzato del lavoro stretto dai tempi di consegna e da incarichi plurimi. Nel 1948, anno di nascita di Tex, la Sergio Bonelli Editore ancora non esisteva, almeno non con questo nome, c'erano invece le Edizioni Audace che facevano capo a Tea Bonelli, ex moglie del creatore di Tex: Gianluigi Bonelli. Proprio la signora Bonelli pensò ad Aurelio Galleppini, già forte di diverse esperienze professionali tra le quali quella con Arnoldo Mondadori Editore e con l'Avventuroso di casa Nerbini, per affidargli le matite di ben due nuove proposte: Occhio Cupo e La Collana del Tex.
Più che nei primi albi della serie a strisce di Tex, l'arte di Galep si poteva ammirare proprio sulle tavole di Occhio Cupo, personaggio appartenente al genere cappa e spada e sul quale la casa editrice puntava molto: albo in grande formato, quindicinale e dal prezzo doppio rispetto a quello delle strisce settimanali, imponeva a Galleppini di concentrare gran parte degli sforzi del suo lavoro su questo titolo. Grazie alle tavole più ampie e al maggior investimento adoperato sulla testata (la collana Serie D'Oro Audace), sia in termini artistici che di aspettativa, sulle pagine di Occhio Cupo possiamo ammirare un Galep con una marcia in più rispetto a quello del primissimo Tex. Le vignette sono dettagliate, maggiore è l'attenzione ai volti, al lavoro sulle ombreggiature, i segni si moltiplicano e sono usati con particolare maestria nel costruire immagini di forte impatto, sicuramente aiutate dal più ampio spazio a disposizione. Tutti elementi di stile meno rintracciabili tra le pagine delle strisce di Tex, fumetto nato per essere puramente popolare, di poche pretese e dal quale la stessa casa editrice non si aspettava più di tanto, pronta a sostituirlo con altro alle prime avvisaglie di stanca. Prendendo in mano Il totem misterioso, primo albo di Tex, è evidente come la priorità professionale dell'epoca per Galep non fossero le storie del ranger: fondali non molto ricchi, poca varietà nei volti (tranne quello di Tex che guarda allo stesso Galep), un tratto più affrettato e spesso poco definito, ma anche tanto dinamismo, grande confidenza con i cavalli (notoriamente incubo di molti disegnatori), una bella capacità di infondere sensualità alla figura femminile e soprattutto una velocità produttiva senza eguali, sforzo stoico e continuativo che porterà Galep a sobbarcarsi da solo le prime 100 uscite de La Collana del Tex. Come sanno anche i muri, fu poi proprio Tex a ottenere un buon successo commerciale (ottimo in seguito), mentre il più sfortunato Occhio Cupo fu archiviato dopo solo una dozzina di episodi.
Così albo dopo albo, Galep contribuisce non solo a dar forma alla fantasia a briglia sciolta di Gianluigi Bonelli, ma anche a creare quella mitologia "texiana" così viva ancora oggi nella serie mensile: nel giro di poche uscite il disegnatore toscano (di nascita) imprime negli occhi dei lettori non solo un protagonista e lo scenario western in cui si muove, ma anche i volti di noti comprimari come il sodale Kit Carson, il ribelle messicano Montales o ancora Steve Dickart in arte Mefisto, caratteri sempre cari ai fan dell'epopea di Tex. Non manca inoltre di ibridare i topoi del genere con soluzioni più esotiche dettate da esigenze di sceneggiatura, guardando al cinema, allo stesso fumetto ma anche ai luoghi della sua vita. Non mancava nemmeno il tocco umoristico nei primi albi di Tex disegnati da Galep, non era affatto inusuale infatti trovarvi elementi comici disseminati nei colonnini delle didascalie, caricature stilizzate di animali vari: pesci, uccelli, soprattutto cani che in qualche caso sconfinano anche all'interno della vignetta (vedi striscia 8 de La freccia della morte), residui di un giovanile amore per il disegno umoristico e di vecchi lavori realizzati per il mondo dei cartoni animati.
Da queste parti amiamo Galep per il Tex, creatura sua che l'ha accompagnato quasi fino al giorno della morte sovvenuta nel 1994; quattro anni prima Galep lasciò il segno anche sulla collana più prestigiosa dedicata al ranger, disegnando il terzo Texone (Il segno del serpente, 1990) in un momento storico in cui ormai la matita dell'artista era incerta ma ancora capace di sfornare una mole incredibile di tavole a tempo record, togliendo le castagne dal fuoco in quell'occasione a un Sergio Bonelli in difficoltà, causa la lentezza degli artisti designati alla produzione dei nuovi albi giganti (realizzare un Texone non è impresa da tutti, soprattutto se con tempi stretti). Così il Texone di Galep ha il sapore di un lussuoso ritorno a casa, un tratto noto, maturato nel corso degli anni, finalmente da assaporare in grande formato. Il Tex di Galep è sempre stato molto particolare, originale quasi, con un taglio del volto molto diverso da come l'hanno dipinto artisti più moderni, meno bello forse, ma assolutamente unico. Ne Il segno del serpente è proprio sui volti che spicca la particolarità del tratto del disegnatore: gli avversari, i cattivi, mostrano in faccia la corruzione dell'animo, se i nostri eroi non sono così belli gli antagonisti diventano decisamente brutti. Brutti ma, soprattutto nei primi piani, molto, molto espressivi. Si ammirano ancora le tavole scure, zeppe di segni e la devozione di un artista votato anima e corpo al suo lavoro.
Come dicevamo, qui amiamo Galep per il Tex. Questo nulla toglie ai precedenti lavori del disegnatore, che noi conosciamo e amiamo meno, ma che l'artista ricorda forse con maggiore affetto di quello che sembrava nutrire per Tex, un compagno di vita che gli ha dato da mangiare ma che, come lui stesso afferma, "gli ha anche chiuso la mano". La produzione intensiva aveva infatti fatto perdere a Galep quella che era la sua formazione artistica da autodidatta dell'illustrazione e della pittura, il fumetto è sempre stata una passione risalente all'età giovanile, nata grazie alle storie di Flash Gordon ma anche, e soprattutto, la via per tirare a campare, così, per stessa ammissione dell'autore, alcuni lavori erano pagati pochissimo e quindi tirati via (quelli per L'Intrepido ad esempio) perché si doveva necessariamente puntare sulla quantità. Altre cose invece lo stesso Galep le ricordava con affetto, i primi racconti illustrati per l'infanzia commissionatigli dalle Edizioni Modellina ad esempio permettevano al disegnatore di cimentarsi proprio con quel tratto umoristico a lui congeniale, in seguito i fumetti illustrati, con sole didascalie per Mondadori e per L'Avventuroso, lavori che presentavano tavole di grande eleganza, ricercate, con dettagli tecnici e paesaggistici che raramente abbiamo visto nel Tex di Galep, soprattutto il primo. Poi l'esperienza con Nerbini che Galep ricorda con affetto, storie di guerra e tante illustrazioni, copertine di libri popolari realizzate con lo stile di un illustratore navigato, di quelle che ancora adesso si lasciano ammirare. Poi si arrivò al '48 e a Bonelli.
Tutto quello che abbiamo già detto, tutte le copertine dei primi 400 numeri di Tex, migliaia di tavole prodotte, ristampe che ancora oggi si affastellano l'una sull'altra, l'ultima iniziata pochi mesi or sono con la riproposta integrale del Tex, a partire dalla prima serie a strisce riadattata in un formato ad albo a colori, un lavoro immane. Ovviamente nemmeno la Sergio Bonelli Editore si farà sfuggire l'occasione del centenario per festeggiare e omaggiare ancora una volta Galep, in settembre il numero annuale di Avventura Magazine sarà dedicato proprio a lui, salvo modifiche dell'ultima ora dovrebbe offrirci la possibilità di vedere l'autore all'opera non solo su Tex (con la ristampa di Silver Bell), proponendo le ristampe del primo episodio di Occhio Cupo (Il giuramento del forzato) e una riduzione in vignette de Il libro della giungla. Lo aspettiamo con immutato affetto e malcelata impazienza.
sabato 2 settembre 2017
ALAN MOORE - FUNGHI DI YUGGOTH E ALTRE COLTURE
(Alan Moore: Yuggoth cultures and other growths di AA.VV, 2007)
Funghi di Yuggoth è un bel volumone, lettura indicata per tutti i fan del bardo di Northampton (il riferimento è ad Alan Moore) e per quelli delle atmosfere care allo scrittore di Providence Howard Phillips Lovecraft, un binomio che dovrebbe far tremare le ginocchia a chiunque. Il volume di circa 350 pagine è un'antologia che mischia fumetto, racconti illustrati, interviste, articoli, opere di Moore e fumetti di altri autori ispirati alle sue idee. Per gran parte del volume si guarda alle atmosfere orrorifiche, cariche di terrore cosmico incomprensibile e ingestibile, derivate dall'opera lovecraftiana legata ai celebri Miti di Cthulhu.
Tutto nasce da un vecchio progetto che Alan Moore avrebbe dovuto sviluppare per la Oneiros Books, una serie di racconti da raccogliere in volume ispirati al ciclo di poesie di Lovecraft Funghi da Yuggoth (36 sonetti). Il materiale realizzato dall'autore andò purtroppo perso in gran parte e, a parte alcune eccezioni come il racconto lungo Il cortile, definitivamente accantonato.
La raccolta si apre con il racconto in versi La collina di Zaman che descrive luoghi e creature terrificanti, opera breve graziata dalle illustrazioni dettagliatissime, piene di segni eppure pulite, di un ottimo Juan José Ryp, al quale segue La nottola, racconto dai toni occulti scritto da Moore all'epoca della collaborazione con la rivista Warrior e poi messo da parte e mai pubblicato. A parte le tavole del fumetto, finalmente realizzate grazie alle matite di Bryan Talbot, si presenta qui il primo comparto testuale per il quale questo volume si rivela davvero prezioso. Abbiamo la possibilità di leggere la sceneggiatura scritta da Moore per questo primo episodio de La nottola, cosa che ci permette di studiare un poco il maestro all'opera; ancor più interessante è la pubblicazione di una lettera di Moore spedita a Talbot nella quale lo scrittore esplica al disegnatore tutte le sue idee su come vorrebbe portare avanti questo specifico lavoro, poi ancora un pezzo con i ricordi di Talbot su quell'esperienza, un insieme di scritti di gran lunga più intriganti del racconto stesso. Segue una serie di fumetti brevi dagli esiti alterni che sono una bella panoramica del Moore nei primi anni di attività, opere che indagano la Londra più nascosta, testi dissacranti, racconti più divertenti, ancora cose ispirate a Lovecraft, nell'insieme una bella raccolta ottima per completisti e cultori di Alan Moore ma apprezzabile anche per molti altri (ma non per tutti). Alle matite Bryan Talbot, Val Semeiks, Jacen Burrows, Oscar Zarate e diversi altri ancora. Ma è di nuovo l'apparato testuale a intrigare maggiormente, una lunga intervista di William Christensen a Moore nella quale lo scrittore racconta idee, nascita, episodi e aneddoti legati a ogni singolo racconto, e seguire Moore in questo è forse più appagante che leggere i racconti stessi.
Come in molti sanno, Alan Moore, oltre a essere uno dei maggiori scrittori di fumetto di tutti i tempi, è noto per il suo ruolo di mago e sciamano. Ed è proprio su questi argomenti che verte la successiva intervista nella quale si parla del rapporto tra magia, arti e linguaggio, argomenti affrontati anche nel bel documentario Mindscapes of Alan Moore (lo trovate su Youtube con sottotitoli in italiano, imperdibile). Seguono ancora un saggio che in tempi non sospetti Moore scrisse sulla situazione politica internazionale prevedendone sviluppi futuri e ancora un'ultima intervista dove si parla delle sue opere, a partire dall'allora suo unico libro di narrativa: La voce del fuoco.
La seconda parte del voluminoso volume (scusate la ridondanza) ci propone finalmente Le creature di Yuggoth, opera in tre volumi divisi in piccoli racconti ispirati tutti agli scritti di Lovecraft, racconti realizzati però non da Moore ma da Antony Johnston con l'ausilio di svariati artisti tra i quali spicca ancora Juan José Ryp. Geoffrey Carlisle, editore newyorkese, si reca nel New England per incontrare il professor Ericsson, antropologo autore di alcuni manoscritti che nel corso dei tre volumi il lettore avrà modo di scoprire insieme all'editore. Vi sono qui narrati gli orrori indicibili con i quali, non casualmente, Ericsson si è trovato in contatto lungo tutto l'arco della sua vita. Creature come Dagon, Shantak, i Mi-Go, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, luoghi come Yuggoth, Arkham, R'lyeh, Leng, la valle di Miskatonic, libri quali il Necronomicon, l'Unaussprechlichen Kulten e oggetti come il trapezoedro scintillante. Un insieme di suggestioni davvero appagante che riaccende la voglia di andare a riprendere in mano i libri di Lovecraft.
Seguono un bell'approfondimento sulle opere e sulla visione di Lovecraft, le sceneggiature dei tre volumi de Le creature di Yuggoth e un apparato di annotazioni per l'edizione italiana.
Non c'è che dire, un volumone davvero imperdibile per chi ha dell'interesse nelle tematiche trattate al suo interno, anche il prezzo di 19 euro per un'opera del genere si rivela in fin dei conti più che adeguato.
Funghi di Yuggoth è un bel volumone, lettura indicata per tutti i fan del bardo di Northampton (il riferimento è ad Alan Moore) e per quelli delle atmosfere care allo scrittore di Providence Howard Phillips Lovecraft, un binomio che dovrebbe far tremare le ginocchia a chiunque. Il volume di circa 350 pagine è un'antologia che mischia fumetto, racconti illustrati, interviste, articoli, opere di Moore e fumetti di altri autori ispirati alle sue idee. Per gran parte del volume si guarda alle atmosfere orrorifiche, cariche di terrore cosmico incomprensibile e ingestibile, derivate dall'opera lovecraftiana legata ai celebri Miti di Cthulhu.
Tutto nasce da un vecchio progetto che Alan Moore avrebbe dovuto sviluppare per la Oneiros Books, una serie di racconti da raccogliere in volume ispirati al ciclo di poesie di Lovecraft Funghi da Yuggoth (36 sonetti). Il materiale realizzato dall'autore andò purtroppo perso in gran parte e, a parte alcune eccezioni come il racconto lungo Il cortile, definitivamente accantonato.
La raccolta si apre con il racconto in versi La collina di Zaman che descrive luoghi e creature terrificanti, opera breve graziata dalle illustrazioni dettagliatissime, piene di segni eppure pulite, di un ottimo Juan José Ryp, al quale segue La nottola, racconto dai toni occulti scritto da Moore all'epoca della collaborazione con la rivista Warrior e poi messo da parte e mai pubblicato. A parte le tavole del fumetto, finalmente realizzate grazie alle matite di Bryan Talbot, si presenta qui il primo comparto testuale per il quale questo volume si rivela davvero prezioso. Abbiamo la possibilità di leggere la sceneggiatura scritta da Moore per questo primo episodio de La nottola, cosa che ci permette di studiare un poco il maestro all'opera; ancor più interessante è la pubblicazione di una lettera di Moore spedita a Talbot nella quale lo scrittore esplica al disegnatore tutte le sue idee su come vorrebbe portare avanti questo specifico lavoro, poi ancora un pezzo con i ricordi di Talbot su quell'esperienza, un insieme di scritti di gran lunga più intriganti del racconto stesso. Segue una serie di fumetti brevi dagli esiti alterni che sono una bella panoramica del Moore nei primi anni di attività, opere che indagano la Londra più nascosta, testi dissacranti, racconti più divertenti, ancora cose ispirate a Lovecraft, nell'insieme una bella raccolta ottima per completisti e cultori di Alan Moore ma apprezzabile anche per molti altri (ma non per tutti). Alle matite Bryan Talbot, Val Semeiks, Jacen Burrows, Oscar Zarate e diversi altri ancora. Ma è di nuovo l'apparato testuale a intrigare maggiormente, una lunga intervista di William Christensen a Moore nella quale lo scrittore racconta idee, nascita, episodi e aneddoti legati a ogni singolo racconto, e seguire Moore in questo è forse più appagante che leggere i racconti stessi.
Come in molti sanno, Alan Moore, oltre a essere uno dei maggiori scrittori di fumetto di tutti i tempi, è noto per il suo ruolo di mago e sciamano. Ed è proprio su questi argomenti che verte la successiva intervista nella quale si parla del rapporto tra magia, arti e linguaggio, argomenti affrontati anche nel bel documentario Mindscapes of Alan Moore (lo trovate su Youtube con sottotitoli in italiano, imperdibile). Seguono ancora un saggio che in tempi non sospetti Moore scrisse sulla situazione politica internazionale prevedendone sviluppi futuri e ancora un'ultima intervista dove si parla delle sue opere, a partire dall'allora suo unico libro di narrativa: La voce del fuoco.
La seconda parte del voluminoso volume (scusate la ridondanza) ci propone finalmente Le creature di Yuggoth, opera in tre volumi divisi in piccoli racconti ispirati tutti agli scritti di Lovecraft, racconti realizzati però non da Moore ma da Antony Johnston con l'ausilio di svariati artisti tra i quali spicca ancora Juan José Ryp. Geoffrey Carlisle, editore newyorkese, si reca nel New England per incontrare il professor Ericsson, antropologo autore di alcuni manoscritti che nel corso dei tre volumi il lettore avrà modo di scoprire insieme all'editore. Vi sono qui narrati gli orrori indicibili con i quali, non casualmente, Ericsson si è trovato in contatto lungo tutto l'arco della sua vita. Creature come Dagon, Shantak, i Mi-Go, Nyarlathotep, Yog-Sothoth, luoghi come Yuggoth, Arkham, R'lyeh, Leng, la valle di Miskatonic, libri quali il Necronomicon, l'Unaussprechlichen Kulten e oggetti come il trapezoedro scintillante. Un insieme di suggestioni davvero appagante che riaccende la voglia di andare a riprendere in mano i libri di Lovecraft.
Seguono un bell'approfondimento sulle opere e sulla visione di Lovecraft, le sceneggiature dei tre volumi de Le creature di Yuggoth e un apparato di annotazioni per l'edizione italiana.
Non c'è che dire, un volumone davvero imperdibile per chi ha dell'interesse nelle tematiche trattate al suo interno, anche il prezzo di 19 euro per un'opera del genere si rivela in fin dei conti più che adeguato.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)