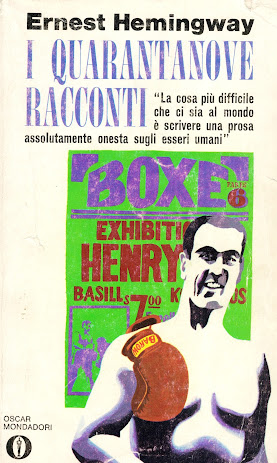(Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, 2020)
Cité Gagarine è il nome di un complesso residenziale costruito negli anni 60 (inaugurato nel '63) a Ivry-Sur-Seine, un sobborgo parigino a sud est dell'area metropolitana, in una di quelle zone che oggi anche noi indichiamo con il termine francese banlieu. Il complesso abitativo nasceva da pulsioni moderniste del Partito Comunista francese che vedeva in questi casermoni proiettati verso l'alto un futuro di onesta prosperità per la classe operaia dell'epoca, tanto che a inaugurare la grande opera di edilizia abitativa venne chiamato addirittura il cosmonauta russo Yuri Gagarin, primo uomo ad andare nello spazio e simbolo di modernità e orgoglio per il Partito che ovviamente guardava alla Russia con un occhio di favore. Nel corso dei decenni Cité Gagarine iniziò a vedere un avvicendarsi di inquilini con operai che si trasferivano altrove, anche a causa della chiusura delle fabbriche, e una residenza fatta di immigrazione che aumentava anno dopo anno. Poi i problemi di molte banlieu e infine la decisione di dismettere e demolire gli edifici del complesso, ormai fatiscenti, con la promessa di trasferire altrove i suoi residenti; nel 2019 iniziano le opere di demolizione, l'anno successivo Fanny Liatard e Jérémy Trouilh girano quest'opera di finzione arricchita con inserti di repertorio che vuole narrare la vicenda Gagarine concentrandosi sul senso di appartenenza dei suoi abitanti a un luogo fisico, ai ricordi di una vita, più che sulla storia del complesso abitativo in sé.Youri (Alseni Bathily), che porta il nome del celebre astronauta e, di rimando, del complesso abitativo in cui è cresciuto, è un sedicenne che non si vuole rassegnare alla decisione presa dal comune di abbattere Cité Gagarine, il luogo che per lui non è solo casa ma anche un mondo fatto di relazioni, ricordi, un luogo per cui il ragazzo prova un forte senso di appartenenza e attaccamento. Mentre alcune delle famiglie residenti si sono arrese, pronte a spostarsi sperando magari in una collocazione che possa essere per loro più dignitosa, viste anche le difficoltà abitative ormai presenti al Gagarine, Youri e il suo amico Houssam (Jamil McCraven) fanno di tutto per ridare al complesso una parvenza di abitabilità: sostituiscono le lampadine bruciate, imbiancano, riparano l'ascensore, anche con l'aiuto dell'amica Diana (Lyna Khoudri). L'impresa però è proibitiva, c'è troppo da fare, pochi fondi e una disillusione che serpeggia tra la maggior parte dei giovani del quartiere tra i quali spicca il piccolo spacciatore Dali (Finnegan Oldfield); gli ispettori alla fine daranno l'ordine di evacuazione, la demolizione è ormai inevitabile. Con una testardaggine sognante dettata dall'amore per il luogo in cui è cresciuto Youri rimarrà fino alla fine in casa sua, nella speranza di poter fare qualcosa per cambiare il destino di Cité Gagarine.
Esordio di qualità nel lungo per la coppia Liatard e Trouilh che partono dal loro corto del 2016 per arrivare a quest'opera dal sapore parecchio originale. Quella narrata è una vicenda che avrebbe potuto facilmente prendere la via del documentario o addirittura finire in una trasmissione televisiva a stampo cronachistico, nelle mani dei due registi francesi Gagarine diventa invece un film sognante, dove il fantastico si unisce al reale (si è parlato anche di realismo magico) e il complesso Cité Gagarine diventa un luogo dell'anima. I due autori evitano lo stereotipo della banlieu, il luogo difficile, la marginalità, spostando il discorso sull'attaccamento al quartiere, sulle radici, sull'amore per i luoghi della vita, per i muri, per i corridoi, per i tetti, per il circondario, un'appartenenza che un protagonista giovane, più di tutti, non è disposto a perdere, non è disposto a cedere, in questo senso sembra indovinato il sottotitolo italiano, Proteggi ciò che ami. I due registi riescono a oscillare tra reale e fantastico grazie anche a un'ottimo lavoro sulle immagini, senza voler rivelare nulla è da tenere presente almeno quella magnifica che coinvolge l'intero complesso sul finale del film ma, bene o male, tutti i passaggi onirici e sognanti con protagonista Youri sono realizzati con grande mestiere. C'è cuore, c'è testa, c'è professionalità in Gagarine, c'è un ottimo cast fatto da bei volti giovani, c'è l'amore che tutti provano per i luoghi cari e che mai, per nessun motivo, si vorrebbero perdere.