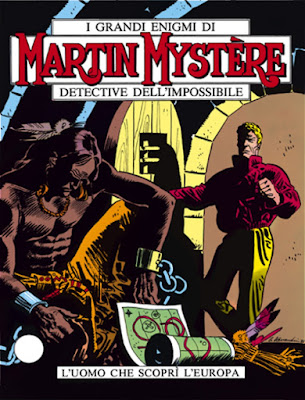Sempre più difficile stilare classifiche articolate divise in più sezioni per quel che riguarda la macro categoria
fumetto. Il motivo principale è la mole sempre decrescente di materiale letto a causa della mole sempre decrescente di soldi guadagnati, quindi come l'anno scorso tenterò di riunire in tre sole categorie tutti gli albi letti quest'anno (che comunque ancora non sono proprio pochi, pochi).
Le tre categorie saranno dedicate ai
fumetti inediti usciti in Italia nel corso del 2016 (e qui siamo sul pezzo), alle
ristampe edite sempre nel corso del 2016 (sul pezzo anche qui stranamente) e una a quei
volumi o a quelle
graphic novel che io ho recuperato nel corso dell'anno, quindi qui ci rientra di tutto, anche roba molto vecchia.
Iniziamo proprio dalla categoria dedicata al materiale più datato, quella dei
VOLUMI,
GRAPHIC NOVEL e
RECUPERI VARI, in quest'ottica prosegue il mio recupero dei
Texoni, nei mesi in cui ho lavorato in fumetteria ho avuto modo di mettere mano anche a letture un po' diverse da quelle affrontate di solito. Ma vediamo questo benedetto podio.
Terzo classificato:
Rughe di
Paco Roca
Bellissima visione sulla terza età, sulla vita degli anziani spesso abbandonati all'interno di fredde case di cura, una narrazione dal tocco lieve e sensibile, commovente e divertente. È qui, ma anche in vetta al podio non avrebbe sfigurato.
Secondo classificato:
Death Note di
Tsugumi Ohba e
Takeshi Obata
Ebbene sì, non avevo ancora mai letto l'appassionante
Death Note, manga rivoluzionario, forse imperfetto e allungato oltre il naturale finale, quello che più avrebbe amato il pubblico, una vicenda che però ti prende alla grande. Poi c'è l'irresistibile
Ryuk.
Primo classificato:
Alack Sinner di
Carlos Sampayo e
Josè Munoz
Stupendo l'
hard boiled di
Alack Sinner, aspetto con impazienza la ristampa annunciata dall'
Editoriale Cosmo nella speranza che comprenda tutto il materiale dedicato al personaggio. Da recuperare a occhi chiusi.


La seconda categoria che vorrei prendere in considerazione è quella dedicata alle
RISTAMPE di vecchio materiale pubblicate nel corso del 2016, anche qui un podio del tutto soddisfacente (almeno per me) con tre gradite sorprese, tutti fumetti che non avevo mai avuto occasione di leggere.
Terzo classificato:
I.R.$. di
Stephen Desberg e
Bernard Vrancken
Ottimo thriller ambientato nel mondo della finanza e soprattutto delle tasse e delle dichiarazioni dei redditi. Potrebbe sembrare noioso ma non lo è. Affatto. Ottima cura negli albi da parte dell'
Editoriale Aurea, cura alla quale non ci aveva abituato. Peccato il progetto degli
Integrali sembri già arenato dopo la proposta di questa prima serie.
Secondo classificato:
Xenozoic di
Marc Schultz
Oltre a una bella serie, divertente e
vintage, la scoperta di un grandissimo disegnatore, sarà il cognome ma gli
Schultz con il fumetto ci sapevano davvero fare.
Primo classificato:
Blake e Mortimer di
Edgar P. Jacobs
Onore e merito ai tipi di
Gazzetta dello sport che continuano a portare in edicola capolavori a prezzo più che accessibile. Quest'anno è stata la volta, tra le altre cose, di
Blake e Mortimer. Fantastico.


Chiudiamo con la categoria dei
FUMETTI INEDITI, più che un vero e proprio
gotha del fumetto targato 2016, semplicemente qualche buona segnalazione, qualche consiglio per recuperare una o due buone serie per chi fosse interessato a farlo. Mi sembra che nel fumetto
mainstream ci sia una flessione qualitativa generale, l'impressione è che le cose davvero interessanti arrivino sempre più da ristampe e materiale datato o che si trovino in volumi costosi che non posso più permettermi. Insomma, il fumetto a prezzi popolari langue un poco, qualcosa di buono c'è sempre, non si parla però quasi mai di capolavori. Rispetto all'anno scorso sono mancati quei progetti degni di nota come
Multiversity di
Morrison o
Sandman ouverture di
Gaiman, altre cose come
Battaglia e
Morgan Lost hanno a mio avviso un po' deluso le aspettative, rimane qualche colpo di
Bonelli, qualche outsider e la cara vecchia
Marvel (la
DC per me è ormai scomparsa, speriamo nel rilancio). Ecco comunque qualche segnalazione (la classifica prendetela pure un po' con le pinze):
Dodicesimo classificato:
The Professor di
Andrea Corbetta e
AA.VV.
Sulla fiducia e per il coraggio. Una nuova proposta italiana, un editore nuovo per il fumetto, un personaggio potenzialmente interessante con alcune cose ancora da mettere a posto (cliché dai quali allontanarsi, qualche ingenuità nella grafica e anche nel nome), però dai, due storie tutto sommato piacevoli da leggere, poi i soliti frantumapalle criticheranno a manetta, però per la buona volontà è giusto premiare l'iniziativa. I miei migliori auguri. Gli stessi auguri li estendo anche al nuovo
Martin Mystère della
Bonelli, ho avuto modo di leggere diffidente solo il primo numero, per questo non è in classifica, mi ha sorpreso piacevolmente, se son rose...
Undicesimo classificato:
Astonishing Ant-Man di
Nick Spencer e
Ramon Rosanas
Una serie fresca, divertente, che non si prende mai sul serio ma che non disdegna di toccare alcune corde che sono molto più vicine all'uomo che non al supereroe. Poteva potenzialmente essere ancora meglio, ma va bene così.
Decimo classificato:
Mighty Thor di
Jason Aaron e
Russell Dauterman
Largo alle donne! Se i puristi avranno storto il naso con la nuova incarnazione di
Thor tutta al femminile, c'è da dire che la serie è piacevole e ha i giusti toni che debbono avere le vicende legate a un Dio del Tuono che si rispetti. In più il tema della malattia, con una
Jane Foster ammalata di cancro e che a ogni sua trasformazione nella potentissima
Thor vanifica tutte le sue sedute di chemioterapia, essere potentissimo condannato al deperimento. Non male.
Nono classificato:
Deathlock di
Nathan Edmonson e
Mike Perkins
Serie limitata dedicata a un personaggio minore, rilanciato probabilmente grazie alla sua presenza nello show televisivo
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e che nelle mani di
Edmonson diventa l'ennesima pedina ben manovrata all'interno di trame più vicine alle spy stories complottistiche che non a quelle supereroiche. Niente male.
Ottavo classificato:
Black Widow di
Nathan Edmonson e
Phil Noto
Ancora
Edmonson, ancora
spy story e la possibilità di sbirciare un poco nel privato della
Vedova Nera, personaggio abbastanza mortificato al cinema quando è in compagnia dei suoi colleghi uomini. A quando un film a solo sulla bella
Natasha? Credo che
Scarlett sarebbe d'accordo.
Settimo classificato:
Squadron Sinister di
Marc Guggenheim e
Carlos Pacheco
Legate all'evento
Secret Wars ci sono state diverse sorprese, miniserie brevi di quattro o cinque numeri molto divertenti o interessanti, penso a
1872,
A-Force o
Vecchio Logan e altre... decido però di segnalare la squadra di stronzi dello
Squadrone Sinistro, bastardi fino al midollo.
Sesto classificato:
Star Wars di
Jason Aaron e
Stuart Immonen
Le storie inseriti nell'universo di
Star Wars continuano a divertire, sia con questa serie principale sia con gli altri progetti come la serie dedicata a
Darth Vader e le mini con protagonisti altri personaggi come
Lando o
Chewbacca. Intramontabili.
Quinto classificato:
All New Hawkeye di
Jeff Lemire e
Ramon Perez
Non ha la forza innovative della serie di
Occhio di Falco di
Fraction e
Aja ma anche
Lemire ha fatto un ottimo lavoro andando a scavare nel passato dei due
Occhio di Falco,
Clint e
Kate. Uno, anzi due, dei personaggi meglio gestiti dalla
Marvel più recente.
Quarto classificato:
Daredevil di
Charles Soule e
Ron Garney
Devil ritorna alle atmosfere urbane e oscure, quelle che più si confanno al personaggio. Trainato anche dalla splendida serie tv, una nuova rinascita per il diavolo di Hell's Kitchen che per la prima volta si muove in città potendo contare su una valida spalla, il giovane
Blindspot.
Terzo classificato:
Doctor Strange di
Jason Aaron e
Chris Bachalo
Potenza del cinema, un'esposizione del personaggio mai vista prima: ristampe, volumi lussuosi, collane allegate ai quotidiani e questa nuova serie regolare (in Italia accompagnata da
Scarlet Witch) che promette una visione diversa sull'universo
Marvel e tanto divertimento. Non male caro dottore, non male...
Secondo classificato:
Manifest Destiny di
Chris Dingess e
Matthew Roberts
La storica spedizione di
Lewis e
Clarke alla scoperta dell'ovest americano tra autoctoni, zombi vegetali, minotauri e mostri delle specie più disparate, un'esplorazione avventurosa dalle forti tinte horror narrata con il giusto piglio. Altro centro della factory di
Kirkman.
Primo classificato:
Ut di
Paola Barbato e
Corrado Roi
Semplicemente la narrazione più originale che ho avuto modo di leggere quest'anno, un mondo affascinante come pochi, tavole meravigliose per le quali le lodi a
Roi non saranno mai troppe. Sei numeri da avere senza se e senza ma nonostante la difficile comprensione della vicenda.